È ottobre, “Fare Voci” si addentra nell’autunno, a passi lenti e necessari.
Ad iniziare da Roberto Ferrucci, che con il suo “Il mondo che ha fatto” rende omaggio ad uno degli autori italiani più importanti, Daniele Del Giudice, ricordandoci anche che “il volo è come la scrittura”…
L’autunno è anche quello della nostra società contemporanea, luogo che si fa croce, come ben raccontato da Daniele Ricci, con le poesie de “La macchina da cucire. Geologia del dolore“; e da Nerio Vespertin, che con i versi di “M.U.S.A.” esplora il sempre più critico mondo del lavoro.
Gli inediti sono a titolo “Rimango qui e aspetto” firmati da Francesco Tomada, e Laura Mautone e Magdalena Oberhofer ci fanno scoprire il fare poesia dell’austriaca Cornelia Hülmbauer, “Mein gehäuse geht auf stelzen Il mio guscio cammina sui trampoli”.
L’Austria, in questo caso del passato, è anche evocata da Hans Kitzműller con il suo “Lontano da Vienna”, omaggio all’attrice Nora Gregor, nata a Gorizia, vero volto dimenticato dell’arte cinematografica.
Nella natura ci addentriamo con i due testi inediti di Luca Buiat, “Verso l’isola che c’è” e “Di fine settembre”.
Una regalità selvaggia è l’immaginario che alimenta il bel libro di Giancarlo Baroni, “Il mio piccolo bestiario in versi”, dedicato alla presenza animale nella poesia.
Le immagini sono quelle di Franco Belsole, e del suo progetto “HABITAT in un tempo e luogo qualunque”.
Buona lettura
Giovanni Fierro
(la nostra mail farevoci@gmail.com)
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Voce d’autore ——————–
Il volo è come la scrittura
Roberto Ferrucci, “Il mondo che ha fatto”
di Roberto Lamantea

La scrittura di Roberto Ferrucci è narrativa, diario, mémoir, reportage: millimetrica, lineare, affabulatoria; i registri s’intrecciano, scivolano uno dentro l’altro con naturalezza e il lettore, più che sfogliare un libro, incontra un compagno di conversazione che lo cattura, lo porta sulla scena, lo devia su un foglio ritrovato, una vecchia lettera, la delicatezza di un rimpianto, la luce di una giornata.
Ferrucci è magico nel disegno degli spazi: è come se la penna fosse una macchina da presa capace di portare nella pagina una prospettiva, il colore di una luce, persino il frullo d’ala di un pensiero, e non senza umorismo e autoironia. La scrittura è lo sguardo: è attento a tutto, all’angolo del tavolino di un bar, alla prospettiva che si alza dal foglio, i suoni, le voci, che diventano una partitura.
Un’école du regard: lo scrittore disegna interni ed esterni come se avesse una macchina da presa, chiaroscuri, angolazioni, scale dei piani. Roberto Ferrucci si racconta e insieme racconta le città: Venezia e la terraferma (Mestre, Marghera dov’è nato), il litorale adriatico sino al Friuli, Parigi che per Roberto, fine traduttore dal francese, è una seconda patria. Racconta le sue passioni e i suoi incontri e attraverso quelli fotografa il mondo: il tennis di “Terra rossa”, il suo primo libro, nelle tre edizioni di Transeuropa (1993, pubblicato dal severissimo Massimo Canalini; 1998 Fernandel; 2005 Amos); le “scorribande a Nordest” di “Andate e ritorni” (Amos 2003); “Sentimenti sovversivi” (Isbn 2011), che segue l’edizione bilingue, italiano e francese, di Meet (2010) e via via gli altri.
Ma è la Nave di Teseo a darci ora il suo libro più bello: “Il mondo che ha fatto”, dedicato a Daniele Del Giudice, mancato nel 2021.
Roberto Ferrucci racconta Daniele Del Giudice da quando l’ha conosciuto passando in via Brenta Vecchia a Mestre, dov’era una bellissima libreria d’essai, la Don Chisciotte di Billy Lamarmora e sua moglie Rachele: davanti alla libreria era parcheggiata una Peugeot 304 cabriolet color bronzo: l’auto di Daniele Del Giudice. Ne nascerà un’amicizia di 36 anni (figura indimenticabile, Billy, la libreria ricordava certe vecchie botteghe inglesi alla Dickens e lui l’ha trasformata in un magico luogo d’incontro tra chi i libri li legge e chi li scrive): quando si conoscono Roberto ha 25 anni, Daniele 36.
Le peregrinazioni per Venezia, il festival “Fondamenta” – memorabile il “cameo” di Agota Kristof fotografata su una panchina di campo S. Angelo – gli scherzi che gli giocava Daniele, come quando Roberto l’ha visto conversare con un signore che gli ha presentato come un professionista che assomigliava tanto ad Antonio Tabucchi: la tira a lungo, poi gli rivela che sì, è davvero Tabucchi; la tesi alla Facoltà di Lettere di Ca’ Foscari, all’ex convento di San Sebastiano, dove Ferrucci si è laureato con Alfonso Berardinelli – succeduto da poco alla cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea ad Anco Marzio Mutterle – con una tesi dedicata proprio a Del Giudice e Tabucchi, discussa lo stesso giorno di un grande amico di Roberto, Tiziano Scarpa, che qui firma la bandella; un nero sacco condominiale delle immondizie pieno di ritagli di stampa, fotocopie, nastri di vecchie registrazioni, dattiloscritti, appunti, inediti; il volo fino a Trieste a bordo di un Tampico decollato dall’aeroporto Nicelli del Lido.
“Il volo ha due o tre cose che per me, come scrittore, sono fondamentali, il volo è l’unico che le tiene insieme. Una è la passione per il movimento. La seconda è la geografia, e l’altra è il navigare, che è metafora poi del narrare, del raccontare”; il volo, dirà più avanti, “è come la scrittura”. “Del Giudice ripeteva sempre che la letteratura è un mare e che gli autori sono isole in mezzo a quel mare, che ogni autore deve trovare il suo pezzetto di oceano dove mettere insieme la propria opera, costruire la propria isola. […] La sua, quella che ha costruito lettura dopo lettura, pagina scritta dopo pagina scritta, nell’oceano della letteratura, è una delle più belle e irrinunciabili. L’isola Daniele Del Giudice”. E pensare – il libro lo ricorda – che Daniele non ha mai vinto un premio.
Ferrucci “attraversa” la vita di Daniele Del Giudice: le tante interviste, salvate da vecchi nastri, le dediche, gli scherzi, persino gli “indovinelli”: seduti in una trattoria Daniele si divertiva a lanciare una parola, una sola, e chi era con lui doveva intuire a quale ricordo si riferisse.
La passione per il teatro: in Polonia ha frequentato Jerzy Grotowski; il cinema, Wim Wenders. La bibliografia per la tesi: Kundera, Handke (in tedesco), James, Borges, Orwell, Stevenson, Queneau, Conrad, Virginia Woolf (Per le strade di Londra), Blanchot, Gadda, Valéry: una biblioteca intera.
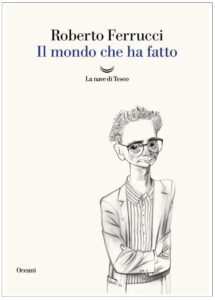
Venezia: Del Giudice era nato a Roma l’11 luglio 1949 – nome anagrafico
Giandaniele – ma anche se non l’ha mai raccontata nei suoi libri “Venezia c’è sempre, tra le righe, entra come un respiro narrativo, attraverso la dilatazione dei tempi, le descrizioni di una certa luce che è solo lagunare”.
C’è una pagina bellissima sulla luce: “Una volta sono arrivato sotto la sua finestra in barca. Un pomeriggio di fine febbraio, tiepido, un po’ opaco, dorato. Sì, c’era quella luce – in quella luce – che a volte trovi in piena laguna, che cade giù laterale e dev’essere la convergenza fra giallo del sole, verde della laguna e una traccia sottile di foschia a trasformare in oro la somma cromatica e allora era come se la barca di mio cugino Giorgio fendesse una lastra dorata sul canale La Grazia, la tagliasse in due, per arrivare là, sotto la finestra di Daniele Del Giudice, sul retro della residenza per anziani” alla Giudecca.
“Un libro a cassetti”, lo chiama Roberto. E c’è l’elegia, non poteva non esserci, in un libro così tessuto nel ricordo. Il temps perdu – quanti ne hanno scritto oltre a Proust: Leopardi, Pascoli, Pedro Salinas, Montale. “Da tempo erano incominciati i rimpianti. I miei. Te ne accorgi dopo sempre, quando ormai è troppo tardi, con chiunque, hai rimandato, preso tempo, e sono di volta in volta famigliari, amori, amici, quel docente all’università o la professoressa di storia delle medie. […] Te ne accorgi quando è troppo tardi, perché quando ce l’hai, il tempo, ti sembra di averlo tutto, di possederlo, e aspetti il momento più opportuno, ti dici che l’occasione arriverà, nel corso del tempo, che però poi smette di scorrere, ed è finito”.
Si legge come un romanzo, “Il mondo che ha fatto”, un diario, un journal intime, ma è anche ricco di spunti per un saggio critico. Quel che è certo è che d’ora in poi chi si occuperà di Daniele Del Giudice dovrà leggere questo libro, che Claudio Magris ha candidato al Premio Strega.

Intervista a Roberto Ferrucci:
Il tuo libro è tante cose: mémoir, narrazione biografica e autobiografica, saggio critico, ma è prima di tutto dedica a un amico. Scrivi che “Il mondo che ha fatto” si è formato in 12 anni di scrittura. Com’è nata l’idea del libro?
Eravamo a Pordenone, per il festival Pordenonelegge, settembre 2011. La sera prima insieme a Tiziano Scarpa avevo presentato “Sentimenti sovversivi”, il romanzo uscito quell’anno per l’editore Isbn.
La mattina a colazione mi pare ci fosse anche Andrea Bajani al nostro tavolo. A un certo punto si parlava di cosa stavamo scrivendo e io ho detto “Devo scrivere qualcosa su Daniele”. Non dissi “desidero”, o “vorrei”. Era un dovere, quello che sentivo. Poche settimane dopo Daniele Del Giudice, malato di demenza precoce, sarebbe entrato nella residenza per anziani non autosufficienti alla Giudecca.
Aveva 62 anni, era il più giovane di tutti là dentro. Non è più uscito fino alla sua morte, il 2 settembre 2021. È nato quella mattina di settembre il libro. Poi, tutti gli anni da lì a questo 2025, sono stati necessari per rileggere i suoi libri, studiare tutta quella parte del suo archivio che mi aveva lasciato, riascoltare le ore e ore di conversazioni e interviste che gli avevo fatto col registratore e, soprattutto, attutire il dolore, risolvere i dubbi, trovare una struttura che potesse contenere tutto nel miglior modo possibile.
Aneddoti, luoghi, riflessioni critiche sulla letteratura e sul metodo di lavoro di Daniele Del Giudice sono un unico intreccio: scrivendo hai seguito un’architettura predefinita e/o ti sei lasciato andare anche al ricordo improvviso?
Figurati, lungo tutti gli anni di lavoro è successo di tutto. Ci è voluto del tempo per trovare il contenitore ideale che potesse contenere il materiale necessario, e trasformarlo poi in narrazione. Non a caso io lo considero un libro a cassetti, dove ogni capitolo è il cassetto tematico di volta in volta in questione.
Era inevitabile che alla fine il tema ricorrente, fra i molti altri, fosse la scrittura, il mestiere di scrittore. E all’interno, racconti. Aneddoti.
Ci tengo a precisare che “Il mondo che ha fatto” è sì il racconto – anche – della malattia di Daniele Del Giudice, ma poi è pieno della sua ironia, racconto i suoi scherzi. È un libro che attraversa gli anni ottanta, novanta e inizio del duemila. C’è la guerra nella ex Jugoslavia, ci sono altri amici comuni, altri scrittori, c’è Wim Wenders e c’è il Daniele Del Giudice pilota.

(Daniele Del Giudice)
C’è un sacco condominiale delle immondizie che compare più volte: dentro ci sono dattiloscritti, fotografie, appunti, ritagli di giornale e più volte parli di inediti di Daniele: esiste un archivio? Ci sono testi che vorresti pubblicare? Soprattutto: dove sono i suoi inediti? Racconti anche di un libretto che doveva stampare la libreria Don Chisciotte di Mestre di Billy Lamarmora per cui Daniele aveva scritto dei testi appositi: è possibile che alcune pagine inedite di Daniele siano andate smarrite?
Esiste un archivio, certo. Ma non sono io a curarlo. Ho usato meglio che ho potuto il materiale che Daniele mi aveva lasciato per la tesi che avevo fatto su di lui e Antonio Tabucchi, ma per il resto non saprei.
Che ci siano dei racconti inediti lo racconto nel libro, alcuni me li fece leggere, compresi i due che aveva dato a Billy della Libreria Don Chisciotte di Mestre.
Spero che prima o poi vengano pubblicati, così come gli articoli che ha scritto per le pagine culturali di Paese Sera e del Corriere della Sera, oppure i numerosi saggi che ha scritto negli anni su Italo Calvino. Io credo di averli tutti, ma non sta a me pubblicarli.
Molte anche, dal tuo passato di giornalista televisivo, le interviste audio-video: hai mai pensato di riorganizzare tutto quel materiale?
Sì, penso che farò dei podcast, e poi c’è l’idea di una lettura a tre voci da portare in giro. Le voci sarebbero la mia, quella di Tiziano Scarpa e la voce di Daniele Del Giudice, dalle registrazioni che ho usato per il libro.
Tu sei uno scrittore “tecnologico”, tra i primi a usare computer, tablet, portatili ma anche, invece della solita biro, la penna stilografica, e ti piace scrivere all’aperto, al tavolo di un bar, magari guardando la laguna: lo spazio aperto t’ispira? Non sei un “topo di biblioteca”? E, soprattutto, che cos’è per te scrivere?
Intanto devo dirti che non ho mai abbandonato i taccuini, e da qualche anno li tengo con continuità, ci scrivo con la stilo, ci appiccico foto, biglietti, scontrini, articoli e – mi vergogno quasi a dirlo – ci scarabocchio sopra anche dei tentativi di acquerello.
Poi è vero: sto rispondendo alle tue domande dal mio irrinunciabile iPad (dopo avere preso appunti su uno dei miei taccuini artigianali che mi fa su misura il mio amico Giuseppe De Santis) seduto al tavolino del caffè El Giardin, a Venezia. Ormai, come Claudio Magris (che non finirò mai di ringraziare per lo splendido testo che ha scritto candidando il mio libro al Premio Strega) scrivo solo fuori casa, al bar, in vaporetto, nei treni. Non ne ho ancora ben capito le ragioni, ma va così.

L’autore:
Roberto Ferrucci è nato a Venezia (Marghera) nel 1960. Ha esordito nel 1993 con il romanzo “Terra rossa”, pubblicato da Transeuropa. Nel 2007 Marsilio pubblica il romanzo “Cosa cambia”, rieditato nel 2021 da People con la prefazione di Antonio Tabucchi. Nel 2022 pubblica il memoir “Storie che accadono” (People), incentrato sulla figura di Tabucchi, libro che con “Il mondo che ha fatto”, uscito nel 2025 per La nave di Teseo e candidato da Claudio Magris al Premio Strega, forma un dittico.
È il traduttore italiano di Jean-Philippe Toussaint. Scrive per i quotidiani di “Nordest Multimedia” e su La Lettura del “Corriere della Sera”. Dal 2002 insegna Scrittura creativa alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova, conduce laboratori di scrittura in Italia e Francia. Per Helvetia Editrice dirige la collana Taccuini d’autore.
(Roberto Ferrucci “Il mondo che ha fatto” pp. 384, 20 euro, La nave di Teseo 2025)
www.robertoferrucci.com
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Tempo presente —————–
Rimango qui e aspetto
Sette testi inediti
di Francesco Tomada
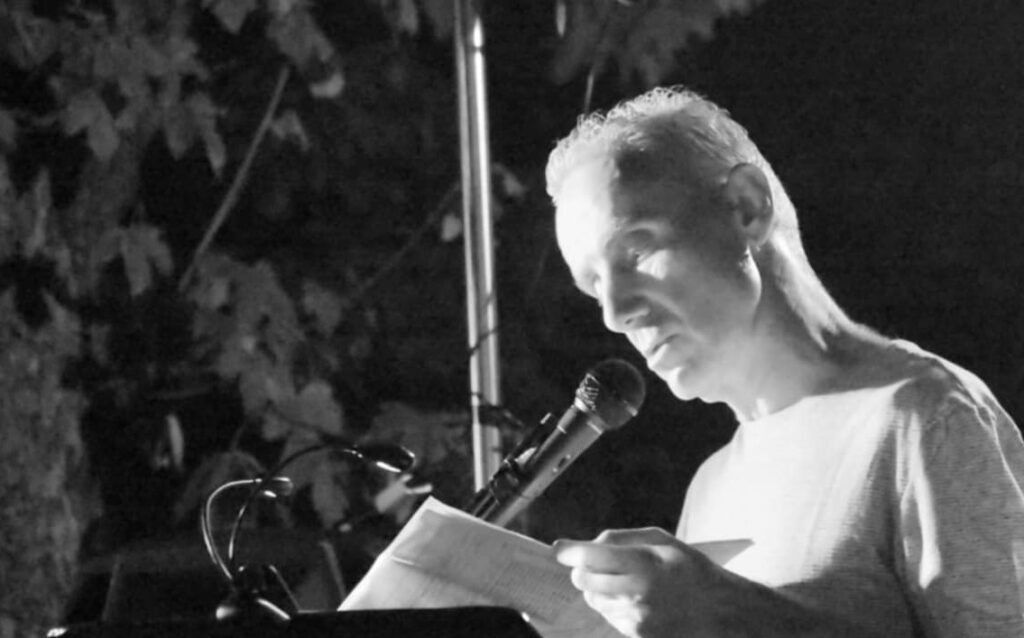
Sony C90
Per fare colpo sulle ragazze registravamo le selezioni di brani sulle musicassette. Il primo lato era sempre più energico e rock, il secondo tranquillo e piacevole, in modo da dimostrare che sapevamo essere entrambe le cose.
Avvia il nastro e metti la musica, finisce la musica e ferma subito il nastro, nei tre secondi di pausa cambia canzone, metti la musica e riparti col nastro e avanti così e ricomincia. Un lavoro infinito e snervante. Sbagliare, tornare indietro imprecando. Adesso con Spotify si sta un attimo, per preparare una C90 come si deve servivano diversi pomeriggi.
Lo so che sto parlando del passato.
Però le cose le ho fatte per bene, lei è ancora qui con me.
*
(senza titolo)
Speravo esistesse una specie di vaccinazione contro il dolore
che fosse come le malattie dei bambini
prese una volta non ti ricapita più
o almeno se torna è più lieve
ma quando mio figlio è finito in rianimazione
mi è stato chiaro che non c’è niente da fare
lui già uomo fatto
lui molto più forte e robusto di me
allora ho pensato soltanto che non è possibile perdere un figlio
e tante altre cose che non voglio ricordare
e poi ho pensato ai genitori di Giulio Regeni
*
Kindergarten
Non li potevamo tenere.
Prima che aprissero gli occhi, mia nonna prendeva i gattini e li avvolgeva in una coperta. Poi li affogava in un secchio pieno d’acqua. Non hanno visto niente, non se ne sono nemmeno accorti, lei mi consolava così.
Solo con una cucciolata aspettò di più e ormai erano cresciuti. Uno era bianco e la seguiva dappertutto. Poi decise che erano troppi, e quello fu il primo che le corse incontro per morire.
È come costruire le mine antiuomo a forma di giocattolo per ingannare i bambini.
Oppure chiamarli dopo tre mesi di guerra per distribuire il cibo e l’acqua, magari anche dei dolci, e poi sparargli addosso.
Mentre premeva verso il basso, mia nonna diceva: non piangere, vedrai cose peggiori nella vita. Ma non credo che fosse questo che immaginava.
*
L’elaborazione del lutto
Ma durante un temporale gli angeli come tengono le ali
che il vento non finisca per strapparne le membrane delicate
che non si crivellino di buchi come una velina se dovesse grandinare
che poi le devi buttare via per forza
e un angelo che non sa volare è inutile
non si prende cura di te, non protegge
forse a mia sorella era stato destinato un angelo ferito
o più semplicemente non esisteva un angelo
capace di salvarla da quella emorragia improvvisa
così sono vent’anni che convivo con questa solitudine
mi stringo nelle braccia come se le braccia fossero il telaio delle ali
collegate al busto da una pelle semitrasparente
rimango qui e aspetto
da vent’anni io sono qui che aspetto che passi la tempesta
*
(senza titolo)
Eravamo questo: mia madre rincasa alle sei si toglie il cappotto
e il corridoio si riempie di freddo e di inverno
le gabbie con i conigli e un gambo di fieno da dargli
la Dyane da mettere in moto a manovella
la prima volta che con un salto sono riuscito a toccare
lo stipite sopra la porta sentendomi adulto
come mai prima e mai dopo
eravamo questo: se a volte mi vedi lontano
è perché torno lì, oggi che mi fanno male i ginocchi
sono le botte che hai preso da piccolo che vengono fuori
dice il dottore e allora ricordo la tuta bucata e
mi fanno male i ginocchi perché mi sono lanciato sui sassi
e forse era meglio di no però per un portiere vuoi mettere
la soddisfazione di quel rigore parato
*
Eternità
Una rondine si arrampica nel vento
un po’ batte le ali, un po’
le tiene tese e comunque risale
e certo che vorrei essere capace di volare
e certo che invidio la sua naturalezza
il suo dare per scontato che resterà sospesa
come accade anche a noi di dare per scontati
il respiro il buio e il silenzio e il fatto
che quando tu mi ripeti per sempre
ci credi davvero
*
Riconoscenza
Le tue vertebre sono il mio rosario
il tuo seno il mio sagrato
io non credo in dio
ma tu mi hai dato modo di pregare

L’autore:
Francesco Tomada è nato nel 1966 e vive a Gorizia. I suoi testi sono apparsi su numerose riviste, antologie, plaquettes e siti web in Italia, Slovenia, Canada, Francia, Slovacchia, Lituania, Austria, Messico, Spagna, Svizzera, Belgio.
La sua prima raccolta è “L’infanzia vista da qui” (Sottomondo 2005), che nel 2007 ha vinto il Premio Nazionale “Beppe Manfredi” per la migliore opera prima.
La seconda raccolta, “A ogni cosa il suo nome” (Le Voci della Luna 2008) ha ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi (Premio Città di Salò, Premio Litorale, Premio Baghetta, Premio Osti, Premio Gozzano, Premio Percoto).
Ha poi pubblicato “Portarsi avanti con gli addii” (Raffaelli 2014), “Non si può imporre il colore ad una rosa” (Carteggi Letterari, 2016), “Affrontare la gioia da soli” (Pordenonnelegge/Samuele, 2021).
Per la collana “Autoriale” (Dot.Com Press) è stata edita nel 2016 una sua antologia ragionata. Ha curato un volume sulla produzione letteraria della Provincia di Gorizia dal 1861 ad oggi.
Collabora con il sito web “Perigeion” e la rivista “Smerilliana”.
Una selezione di suoi testi, dal titolo “Questo è il mio tempo”, è stata edita dalla casa editrice Scalino di Sofia. Nel 2022 è stato pubblicato “Il figlio della lupa” (Bottega Errante Edizioni), un romanzo scritto a quattro mani assieme a Anton Špacapan Vončina.
(la foto ritratto grande di Francesco Tomada è di Roberto Marino Masini)
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Voce d’autore ———————-
Per inquieto vivere, procrastinare
Nerio Vespertin, “M.U.S.A.”
di Giovanni Fierro
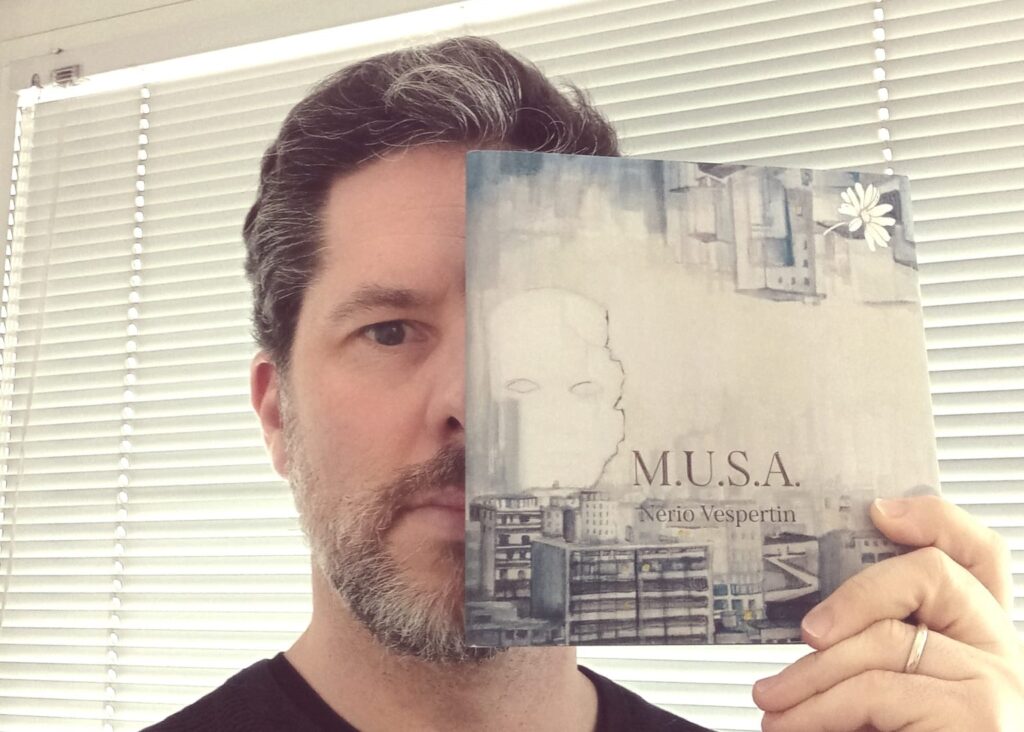
Il mondo del lavoro è sempre più in difficoltà. Svilito nel suo svolgersi nella qualità dell’esercizio, indebolito da salari dal potere d’acquisto sempre più misero, pericoloso nella sempre più grande mancanza di sicurezza e protezione. Allo stato attuale, il lavoro è diventato luogo nel quale l’uomo ha sempre più difficoltà a rimanere, in cui il nobilitare è verbo orami consunto.
E in questa dimensione, comunque ancora vincolante e necessaria, si muove “M.U.S.A.”, di Nerio Vespertin.
La poesia diventa così strumento per indagare un aspetto della nostra società a cui ogni individuo è vincolato, per necessità o anche per impossibilità di accedervi.
Un mondo, quello del lavoro – allargato a tutti i lavori, la difficoltà è orami trasversale – che è sintomo di sofferenza: “Ferma. Respira./ Anche questo tutto/ anche questa fibra di coscienza/ diventa numero. Termina”, e la cui radice comune è sempre più chiara: “Ci stringeva la fame padrona/ la domanda e l’offerta della miseria”.
È accurata la scrittura di Nerio Vespertin, non rinuncia a nulla, capace com’è di trovare un nucleo di senso, una lettura per mettere le cose ancor di più in chiaro, “Pensaci./ A subappaltare il domani/ a un piano d’accumulo/ a migliorare la produzione oraria”, senza omettere nulla, “Lasciare che succeda// Il solito, l’inevitabile./ Il disastro o il successo in ugual misura”.
E in questo suo indagare, emerge la fragilità dell’individuo, a cui sempre più è tolta identità e speranza, “A giornata finita:/ [1] Riallacciare il sorriso alla faccia/ [2] Ricollegare la fatica”, con il porre semplici domande che trovano il nervo della questione, “Chiedersi/ quand’è stato l’ultimo lavoro senza ansia”.
E in questa pienezza che il lavoro promette (stipendio, qualifica, spessore), Vespertin sottolinea il taglio, il crollo di aspettative, il vuoto che si prepara e accade, quel “Poi il risveglio/ somministrato a tutti/ nella casella di posta elettronica.// Oggetto : “Mancato rinnovamento”” che diventa il ‘segni particolari’ sulla propria carta d’identità. La condanna: “Il fallimento/ ci fa scendere/ dentro ciò che era/ (che sarà)/ per sempre/ nostro”.
Le pagine di “M.U.S.A.” esplorano il mondo del lavoro nelle sue diverse sfaccettature, facendo emergere il prodotto crudele che distingue ogni singola persona, la solitudine. Una solitudine cattiva, inesorabile, indefinita nel suo durare e progredire, dove allo specchio puoi dirti e dire “Chiedo perdono/ ma il cuore fa male/ e non so lasciare/ la carne sul rogo/ per un mondo migliore”.
Ed è il vuoto dell’umanità che manca il tratto fondamentale che Vespertin fa emergere, indicandolo e chiamandolo per nome, senza la paura di trovare per forza una via d’uscita, se non quella di una difesa necessaria ed assoluta, un non arrendersi che deve fare sempre i conti con le problematicità di ogni giorno, con o senza salario.
“Se solo sapessimo trascrivere il cuore un dio mondo sarebbe rivelato un mostro mitologico magico oracolo nascosto a tutti”, perché c’è sempre qualcosa che ancora si nasconde, “Fin quando saremo noi/ questa città incroci di mani di lingue di bici legate con catene comuni/ il nostro giorno migliore”.
Con “M.U.S.A.” Nerio Vespertin fa della poesia documentario.
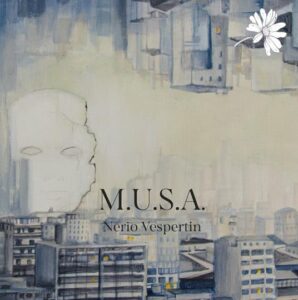
Dal libro:
manutenzione¬_offset
Routine di avvio
[1] Verifica aggiornamento di sistema
acquisite nuove competenze
tutte le volte
da capo
[2] Riposizionare lo strumento sul banco di taglio
sono al contempo
materiale grezzo
forza lavoro
[3] Azzerare il puntatore: spegnere e riaccendere
per inquieto vivere, procrastinare
[4] Ripetere fino ad azzeramento stato
fino esaurimento scopo
ancora
da capo
*
sequenza_lavorativa_10000
Da zenith a nadir, a tempo zero.
Elettrificato
da un filo scoperto
ridotto a unità di pensiero
riprogrammato azzerato
da lira a euro
abbandonato cassaintegrato
annoverato come perdente
per non disturbare
i discorsi del sindacato
multato rinegoziato
se rincara il tabacco
fumerò la testa
costretto al consenso
il vostro bene
il nostro male
lasciato solo
costretto al precariato.
Ma mai, nemmeno una volta
che abbia pensato di arrendermi.
*
CS_01102011_160311.pdf
[Radiografia di un cranio umano adulto, vista laterale, sezione
trasversale sinistra; il documento PDF risulta prodotto dal reparto
di Radiologia del Policlinico S.Raffaele di Milano; al centro del lobo
sinistro, nell’area occipitale, è visibile un piccolo punto nero cerchiato
in rosso; il nome del paziente è coperto da un filtro per la privacy]
Dopo l’operazione, mal di vita.
Gli occhi non tengono più le immagini
perdo la notte dalle palpebre.
Le dita litigano con l’idea della stanza
la stabilità degrada in brevi
pause di benessere.
Il tempo mi mette l’ovatta in bocca
sotto ai piedi le orecchie
ascoltano rumori informi.
Sto bene – mi ripeto – Sto bene.
E ogni volta assomiglio di più
alla mia idea di calma.
Ma non basta.
La salute è divenuta
malattia cronica, incurabile.
*
terza voce
il mattino presto a lavoro calmo lo schermo pulito
non ricordo il fuoco la fine intravista pulito stanco buco di coscienza
mi lavo le mani parlo qualcosa funzionano facili le intenzioni altri anni
ancora come questi
come granelli di clessidra secondi minuti ore
funzionano da sole le cose semplici le parole le scuse da inventare

Intervista a Nerio Vespertin:
Cosa significa usare la poesia per scrivere del mondo del lavoro?
Wislawa Szymborska, nella sua poesia “Scrivere un curriculum”, diceva: “A prescindere da quanto si è vissuto/ Il curriculum dovrebbe essere breve“. Quello che credo volesse dirci con la sua ironia acuta, era di fare attenzione alla trappola del linguaggio pragmatico: la lingua del business è un’arma affilatissima, una lama che sottrae alle parole ciò che non è immediatamente utile a una funzione pratica. Quello che resta però, quando il mondo viene rappresentato solo in termini di efficienza e praticità, è poco più di una macchina: uno strumento che da una parte assorbe tempo, risorse ed esseri umani e dall’altra sputa fuori scatole chiuse, a uso e consumo del mercato.
Per tutte queste ragioni sono convinto che ci sia bisogno di contaminare il linguaggio del lavoro, pratico e funzionale, con il linguaggio introspettivo dell’arte e della poesia.
Per via della mia professione vivo tutti i giorni la vita dell’azienda e proprio per questo riconosco il bisogno di riscoprire un linguaggio nuovo, più umano. Usare la poesia è un atto necessario perché da un lato consente di descrivere una realtà che spesso viene ignorata in letteratura e, in secondo luogo, perché le restituisce dignità a bellezza.
La poesia ha questo merito: crea interruzioni, ci costringe a ragionare “fuori dagli schemi”, non “per punti”, ma per similitudini e allusioni. In questo modo al centro di tutto viene ricondotta l’esperienza umana e non più il principio dell’utile.
Tanti gli spunti che nascono da queste pagine; più di tutto, mi sembra, è il fatto che ormai ci si sia arresi al dio assoluto della produttività…
Troppo spesso trascuriamo l’importanza della narrazione mediatica. Non è semplicemente la ripetizione della medesima parola o il mantra di uno slogan, ma qualcosa di molto più subdolo e pervasivo. Noah Yuval Harari nel suo saggio “Sapiens” chiede provocatoriamente al lettore: “Come si fa a far credere alla gente in un ordine immaginato come il cristianesimo, la democrazia o il capitalismo? Prima di tutto, non si deve mai ammettere che si tratta di un ordine immaginato”.
Allo stesso modo il mito della produttività è diventato un’entità reale e ineluttabile: dagli anni Ottanta in poi la cultura di massa ci ha propinato la convinzione che l’unica cosa che conta sia “accrescere un numero”.
Viviamo così ogni giorno dentro un sistema che enfatizza la bravura e la qualità di una persona in base a “quanto produce in meno tempo possibile”. Che sia la quantità di prodotti elaborati, il numero di mail spedite o ricevute o la cifra che abbia guadagnato o fatto guadagnare. Questo ordine di valori, o meglio, questo ordine di narrazione, vince proprio grazie alla persuasione delle parole che la presentano come l’unica possibile realtà possibile.
Ecco perché il linguaggio (e in particolare il linguaggio poetico) è così importante: anche se è una piccola proposta narrativa, con “M.U.S.A.” voglio far intendere che un’alternativa al dio assoluto della produttività è sempre possibile.
I protagonisti delle mie poesie non ignorano la brutalità della realtà postindustriale, ma proprio negli spazi angusti in cui si muovono, aziende, fabbriche o ingorghi stradali, vanno alla ricerca di spiragli di speranza e rinascita.
Tutta la scrittura di “M.U.S.A.” vive di un’attenzione quasi scientifica, rispetto al tema che tratta. È un qualcosa che si è sviluppato nel tempo della creazione del libro, oppure è un qualcosa di voluto, da cui partire per costruire il libro?
Mi piacerebbe dire che il progetto di “M.U.S.A.” sia frutto di un’analisi attenta e scientifica del mondo del lavoro, ma la verità è (come in tutto quello che scrivo) che sono partito da un sentimento intimo e violento, nient’affatto scientifico.
La verità è che ho vissuto realtà lavorative profondamente diverse nel giro di pochissimo tempo: durante la crisi economica del 2008 ho affrontato la cassaintegrazione e il licenziamento collettivo, nel 2009 sono entrato in una multinazionale mastodontica e frenetica e infine, dal 2010, ho affrontato una carriera lavorativa estenuante, con viaggi continui da nord a sud, con una media di 6000 km al mese.
Queste diverse esperienze mi hanno insegnato a pensare in fretta, ragionando fuori da quegli schemi che dividerebbero il mondo in “colletti blu” e “colletti bianchi” (come scrive sagacemente Francesca Del Moro nella postfazione). Per questo ognuna delle quattro sezioni della silloge registra un cambio sia nella prospettiva che nel linguaggio narrativo: ogni ambito lavorativo ha le sue formule e i suoi tecnicismi e di conseguenza cambia il modo di rappresentarlo. Ma ognuno, a suo modo, subisce la stessa spaventosa pressione esistenziale.
Così “Meccanica”, la prima parte, racconta il punto di vista di chi vive la catena di montaggio e l’eterno ripetersi del ciclo in postazione, con poesie che integrano il linguaggio tecnico dei manuali ai pensieri degli operai.
“Umana”, la seconda parte, traduce invece il disorientamento di una nuova “risorsa umana”, appena inserita nell’ecosistema di una multinazionale, con il suo gergo d’inglesismi e neologismi dal sapore orwelliano. E così via.
Devo riconoscere che in fase di editing la poetessa Camilla Ziglia mi ha fatto notare queste e altre peculiarità del mio linguaggio e di conseguenza mi ha saputo orientare verso un’intelligente affinazione stilistica. Tuttavia, la peculiarità stilistica che hai osservato era sempre là: un doloroso punto di partenza per ogni passaggio della silloge.

Tutta la terza sezione, “Sintetica”, è un tratteggiare luoghi come fossero dei quadri, in cui entrare. Sembrano anche dei cortometraggi…. Ti ci ritrovi in questo?
Il grande regista russo Tarkovsky sostiene che la poesia sia una forma speciale di vedere la realtà e che di conseguenza il cinema debba essere poesia. L’estetica delle immagini dei suoi film attua una vera e propria metafora esistenziale: le inquadrature si fermano, le scene si congelano in immagini pittoriche. La pausa diventa il mezzo di una riflessione necessaria per attuale la rivelazione: fermarsi per comprendere, trascendere.
Ora non sono troppo sicuro di aver costruito la terza parte della silloge come un’opera filmica, quanto piuttosto come una serie di ‘fotogrammi’ immobilizzati nel tempo. La scusa è quella di un’unità di memoria sintetica trovata in una stanza d’hotel (fatto realmente accaduto durante i miei continui viaggi di lavoro): dalla lettura dei file contenuti, vero e proprio messaggio in bottiglia dell’era digitale, si sviluppa poi una riflessione intima, dove ci si interroga sulla fragilità di un’esistenza iperconnessa alla rete, dove i momenti più significativi sono ridotti a una manciata di file su di un dispositivo elettronico.
Le poesie di “Sintetica” sono composte letteralmente di queste tracce digitali (non a caso i titoli dei componimenti coincidono con i nomi dei file) e rappresentano un istante bloccato nel tempo. Le foto su di un cellulare diventano così i fermo immagine di storie drammatiche, i PDF di ricevute o di referti medici le sceneggiature di eroi sconosciuti.
In questo senso il linguaggio è ridotto a immagine pura, perché è la vita stessa a essere limitata a sua rappresentazione digitale: il protagonista di “Sintetica” siamo tutti noi, ogni volta che ce ne stiamo davanti a uno schermo, vivendo l’imitazione digitale al posto dell’esperienza reale.
Il libro esplora molto bene anche la dimensione della solitudine che ci affligge. Nell’anno 2025, che solitudine è questa? E cosa comporta nella vita quotidiana?
La solitudine dei nostri giorni è innanzitutto una solitudine voluta. È difficile ammetterlo apertamente, ma credo che sia il nostro stesso bisogno di libertà a spingerci all’isolamento. Questa tendenza di per sé non sarebbe un problema, se i tempi ridotti e le regole sociali in cui siamo incastrati non ci portassero a una pericolosa autoreferenzialità: lasciati da soli con i nostri feticci, nella convinzione di non poter essere compresi, subiamo la mancanza di un confronto amico e disteso, le idee si incancreniscono e la coscienza si alinea.
Ancora una volta la responsabilità maggiore di questo stato di cose è della narrazione mediatica che esaspera il bisogno di appartenenza al cosiddetto “club dei giusti”, ovvero un clan esclusivo di persone fisicamente perfette e moralmente ineccepibili. Narrazione che viene poi amplificata e polarizzata dall’uso compulsivo dei social media che dividono l’opinione pubblica in schieramenti da stadio.
In “Automatica”, la quarta e ultima parte della raccolta, la vera protagonista della poesia diventa proprio questa solitudine fatta di voci dissonanti. I componimenti trascrivono direttamente il flusso di coscienza di voci chiuse e incomunicabili; la metafora adoperata è quella di un ingorgo stradale a causa del quale la solitudine di individui diversi viene portata alla rottura. Mi piace pensare che proprio questa immagine, così ingloriosa, scomoda e insignificante, possa dare il via a una rivoluzione sociale necessaria ora più che mai: per guarire dalla nostra solitudine abbiamo bisogno di riconoscere e riconoscerci nell’altro.
Non è un caso che una delle poesie di questa sezione sia dedicata alla figura di Fernand Deligny, poeta, educatore e cineasta assolutamente fuori dal comune, che con il suo metodo di mappaggio dei movimenti erratici quotidiani (lignes d’erre), ha tracciato le basi di una comunicazione non verbale con ragazzi neurodivergenti. È proprio un modo di pensare come il suo, io credo, a indicarci oggi un metodo possibile ricostruire i nostri legami perduti.
Il lavoro ormai è un qualcosa che divide, non che unisce. Chi ce l’ha e chi non ce l’ha, la concorrenza che diventa invidia e divisione, che crea nemici. I tempi sempre più accelerati e le richieste sempre più esose… Il mondo del lavoro è davvero avvelenato?
Certamente il nostro mondo soffre d’invidia, un male cronico che lo sta erodendo dall’interno.
La direzione verso cui si è spostato il mondo del lavoro è quello della specializzazione estrema: miglioriamo in un unico ambito fino a raggiungere l’apoteosi. Questa tendenza, che può andar benissimo per la logica della catena di montaggio e della “scatola chiusa”, diventa disastrosa nella nostra vita privata. Più ci specializziamo in un ambito, diventando effettivamente “bravi”, tanto più lasciamo scoperti altri ambiti ugualmente necessari alla nostra felicità, acuendo un disperato bisogno di aiuto. Questa logica divisoria è alla base di molte “patologie” che avvelenano il nostro pensiero, non ultimo il bisogno di sentirci migliori degli altri, distinguendoci in impiegati di serie A e serie B, o fra impiegati e disoccupati.
La verità è che dividersi non paga nessuno: la natura umana è principalmente politica e d’interazione. Abbiamo bisogno di muoverci in gruppi socialmente aperti e integrati per sentirci completi. Persino presso le “alte sfere” le cose non vanno bene: se leggiamo le statistiche sul consumo di stupefacenti e antidepressivi fra i dirigenti e i top manager, ci rendiamo conto che la frattura sociale colpisce più dolorosamente proprio chi è più in alto.
Per fortuna di recente qualcosa sta cambiando persino in un paese tradizionale e culturalmente conservatore come il nostro: una nuova consapevolezza investe soprattutto le ultime generazioni, rivalutando l’esperienza lavorativa secondo uno schema più organico e inclusivo. C’è sempre più attenzione al proprio tempo libero e all’esperienza umana, un rifiuto quasi completo della retorica della carriera sopra ogni altra cosa. Qualcosa sta cambiando, ma certo, la strada per la rinascita dell’individuo è ancora lunga.

L’autore:
Nerio Vespertin è nato a Roseto degli Abruzzi nel 1981. Si dedica fin da giovanissimo alla poesia. Trasferitosi a Bologna per gli studi universitari, entra in contatto con il mondo delle associazioni studentesche, collaborando con collettivi di scrittura/poesia e nel mondo delle riviste underground di Bologna.
Nel 2010 si classifica nella rosa dei finalisti del “Premio Teramo”, nel 2019 è vincitore del premio “Coop for words”. Dal 2015 al 2019 collabora con la community del Writer’s Dream, per la quale ha curato il podcast e due raccolte di poesie.
Nel 2020 pubblica la sua prima silloge “Ama con rabbia”. Nel 2022 entra a far parte della segreteria di Bologna in Lettere, festival multidisciplinare di cultura letteraria, con cui collabora attivamente.
Nel 2024 vince il premio “Tema Originale” con la sua raccolta “Il turista” al premio XXX Premio Nazionale di Poesia “Tra Secchia e Panaro”.
(Nerio Vespertin “M.U.S.A.” pp. 100, 17 euro, Selvatiche Edizioni – Seed 2025)
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole
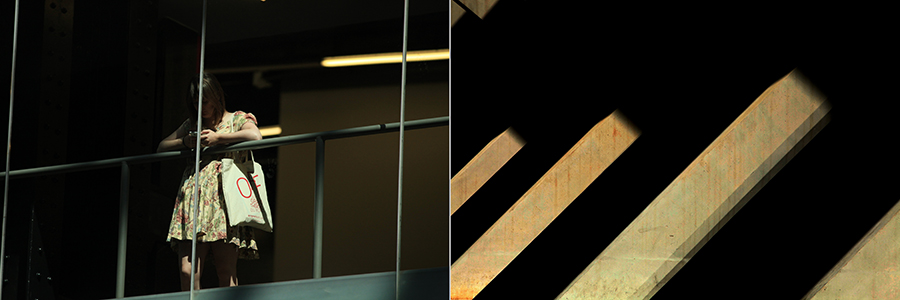
Tempo presente ————–
Mein gehäuse geht auf stelzen Il mio guscio cammina sui trampoli
Quattro testi inediti in italiano

MAU OEH
das mädchen schneidet sich ins tischtuch
das mädchen will prinzessin sein
das mädchen schreit wie aufgespießt
das mädchen spürt die spitzen
tanz den tanz
dreh den rock
dreh den rock wie teller
mache gute mienen
spiele gutes spiel
sprenge trockne felder
aus dem haus gerät die mutter
an den hans gerät sie recht
in den seilzug eine schlaufe
was dem kopf der kragen wird
schweigen ist hochzeit
reden ist blech
schweigen ist ehern
scheiden ist pech
der onkel nimmt dich untern arm
der onkel will nur spielen
der onkel sperrt dich in den kasten
der onkel tut nichts tut er wohl
ein teil tier
& ein teil herzen
ein überwurf wie pelz
mein gehäuse geht auf stelzen
MAU OEH
la ragazza si taglia nella tovaglia
la ragazza vuol essere una principessa
la ragazza grida come se fosse trafitta
la ragazza sente la ruvidezza
balla il ballo
ruota la gonna
ruotala come piatti
fai buon viso
gioca un buon gioco
annaffia i campi aridi
la madre perde la testa
le sta bene finire con Hans
nella guaina un cappio
che diventa colletto per la testa
tacere è matrimonio
parlare è lamiera
tacere è ferro
divorziare è sfortuna
lo zio ti prende sottobraccio
lo zio vuole solo giocare
lo zio ti chiude nell’armadio
lo zio non fa niente, ma lo fa
una parte animale
& una parte cuore
un soprabito come pelliccia
il mio guscio cammina sui trampoli
da “MAU OEH D”, Sukultur, Berlino, 2018
*
SPOREN SÄEN VER
SCHWOREN SEIN
wo dir deine rute abbricht stell ich mich für dich ins fenster
hinter scheiben hauch ich anschlag
die passierten die passablen alle liegenschaften jeder abdruck
auf den laken auf den tisch und bodenplatten was versehrt ist ist
versehen von
festlich in die knie gegangen diese form von anstoß was dir in die
kehlen fährt wenn die beine erst auf stelzen
wissen wessen vorlaut lockt wer den leckstein tiefer hängt seine
wunden salzig will rauft sich nun zusammen
wer zu spät kommt findet vor
SEMINARE SPORE FARE
COMPLOTTI
dove ti si spezza la verga, io mi metto per te in vetrina
dietro vetri alito attacco
ciò che è capitato, ciò che è considerato accettabile tutte le proprietà ogni impronta
sulle lenzuola sul tavolo e sulle piastrelle del pavimento ciò che è mutilato è
marcato da
festosamente in ginocchio questa forma di impeto che nelle
gole ti entra quando le tue gambe prima sono sui trampoli
sapere di chi seduce sfacciato chi abbassa la pietra salina, vuole le sue
ferite salate ora trova un compromesso
chi arriva troppo tardi trova
da “Zyklus V”
*
TREFFEN SICH ZWEI BRÜSTEN SICH ZWEI
vereinzelt beginne
fleck auf flanke drang nach haltung man siehts dir an man siehts
einander am sternum gemeinsam geheimnis rachen sagst du meinst
statt mündung mehrzahl
die sippschaft im nacken wer war beteiligt wer gibt sein zeugnis
ab sein hemd
lass uns einander zu blutsschwestern trinken zum einstand den
flaschen die hälse traktieren
ehestens ehern schließlich unendlich nennst mich komplizin
nach tagen schon
sag nicht du zählst nicht bekenn dich bist immer im takt
SI INCONTRANO DUE SI VANTANO DUE
Comincio di qua e di là
macchia su fianco impulso a stare dritti lo si vede in te lo si vede
uno con l’altro allo sterno insieme un segreto vendette dici intendi
plurale e non gola in bocca
col fiato della famiglia sul collo chi era coinvolto chi dà la sua testimonianza
la sua camicia
brindiamo a diventare sorelle di sangue una per l’altra al debutto prendiamo a pugni i colli delle bottiglie
se proprio di ferro alla fine eternamente mi chiami complice
già dopo giorni
non dire che non conti ammetti che sei sempre nel tempo
da “Zyklus V”
*
DU SOLLST NICHT SALUTIEREN DU SOLLST NICHT SOLLEN
lippen lackieren mit zungenspitzen das herz fester schnallen den
fremdgängern nach
schleichend wie katzen als wäre es nächtens siehst du im
dunkeln bist du voraus
über wellblechdächer steigen erst die leichten ziele mit den
büchsen fängt es an
auf sekrete sollst du setzen blut und spiele spuk und speichel
läuft es richtig ab der ersten übung feucht
schrot wie schnurren längst rekrutin schwörst vorm welken
letzten saft
NON DOVRESTI FARE IL SALUTO NON DOVRESTI DOVERE
lucidarsi le labbra con la punta della lingua stringere più forte il cuore
seguendo i traditori
andando di soppiatto come gatti come se fosse di notte vedi
nel buio sei avanti
attraversare tetti di lamiera prima le mete più facili con
i fucili si comincia
dovresti puntare sulle secrezioni sangue e giochi fantasmi e saliva
funziona bene alla prima esercitazione umido
pallettoni come le fusa recluta da tanto tempo giuri prima di appassire
ultimo succo
da “Zyklus V”
(I testi di Cornelia Hülmbauer sono tradotti in italiano da Laura Mautone e Magdalena Oberhofer)
Tradurre le poesie di Cornelia Hülmbauer
di Laura Mautone

La traduzione non avviene tra sistemi, bensì tra testi.
(Umberto Eco “Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione” Bompiani 2003)
Ogni testo rappresenta un mondo possibile.
Bisogna saper fare ipotesi.
Mi sono avvicinata alle poesie di Cornelia Hülmbauer con un’avventata spensieratezza, partendo da una buona conoscenza del tedesco, cosa che mi deriva dalla fortuna di essere nata in Sudtirolo. Era giugno, la scuola stava finendo, ma eravamo ancora impegnati con gli Esami di Stato. Subito mi sono accorta della complessità dei testi e di una lingua fortemente metaforica e frammentata: giochi di parole che si rifacevano al dialetto austriaco, scelta di non utilizzare maiuscole e minuscole, regole grammaticali a volte disattese, frasi e espressioni che potevano avere più di un significato. Ad una prima lettura ho colto alcuni aspetti del contenuto e alcune difficoltà nelle traduzioni in inglese, che mi erano state inviate. Non sapevo nulla dell’autrice, non avevo letto nulla di suo e si trattava di tradurre 4 poesie, senza altre informazioni sulle opere da cui erano tratte.
Mi sono subito rivolta ad alcuni colleghi di madrelingua tedesca, per cercare di raggiungere i luoghi del testo, aggirandoli, attraverso una collaborazione tra le due lingue. Ci siamo accorti che non sarebbe stato un lavoro di qualche ora buca. Abbiamo, dunque, deciso di rimandare a tempi più distesi. Si è dimostrata la soluzione vincente.
Durante l’estate, di fronte ad un mare splendido, ho realizzato la mia versione delle traduzioni dal tedesco in italiano. Poi ho inviato questa prima bozza ad una collega di madrelingua tedesca, che l’ha rivista e ha individuato alcuni punti critici.
Ci siamo date appuntamento alla fine dell’estate e, di fronte ad un caffè, al tavolino di un bar sotto le fronde di un albero, ci siamo confrontate: è stato molto bello discutere con Magdalena e cercare di mettere insieme il rigore della grammatica con la resa in italiano, la scelta delle parole e gli eventuali rimandi a giochi di parole, che necessariamente non potevano essere tradotti allo stesso modo nelle due lingue.
Dopo una lettura che si è soffermata più sugli stimoli che alcuni dei testi suggerivano dal punto di vista dei temi: la denuncia di una sostanziale violenza avvenuta in famiglia, con la complicità di chi sa e non vuole vedere, ci siamo soffermate sui punti critici e abbiamo inviato all’autrice le nostre domande, espresso i nostri dubbi. Ne è nata una corrispondenza con lei e, insieme, siamo giunte alla fine ad una versione che ci sembra rispetti il senso e lo stile dei versi originali e sia abbastanza fruibile in italiano.
La traduzione che proponiamo ha cercato di rispettare i temi, il lessico, i significati a volte sottointesi e lo stile sincopato, frammentato di questi testi di Cornelia Hülmbauer. Tradurre poesia cercando di rispettare i versi dell’autrice e cercando di renderli efficaci anche in italiano non è stato sempre facile. Noi ci abbiamo provato e ci siamo divertite a esplorare, aprire le menti alla poesia e, insieme, alle due lingue.
Ne è risultato un viaggio e una scoperta alla ricerca dell’espressione, della sfumatura e del significato più vicini a quello che l’originale ci sembrava volesse dire.
Brevi annotazioni filosofiche a margine
Tradurre senza tradire non è facile e sono in tanti a ritenere che non si possano trasferire parole ed espressioni da una lingua all’altra.
Qualcuno sostiene, invece, che il lavoro del traduttore è molto più simile a quello del copista che riproduce un testo.
In ambito letterario la traduzione è sempre anche una riscrittura, ha una sua propria essenza diversa dall’originale. Diversa, ma non totalmente altra. Chi traduce narrativa o poesia deve essere anche un po’ uno scrittore o un poeta.
La realtà di chi traduce è che, a volte, si devono cancellare parole intraducibili o crearne ex novo, dando vita ad una traduzione che richiede la stessa abilità e creatività dell’autore originario.
Tradurre, da traducere, significa far passare un’opera da una lingua, da una cultura, da una tradizione ad un’altra: tradurre significa dunque «rendere un significato disponibile» per altri.
Visto che i confini tra le parole non sono stabiliti a priori, ma mutano nel tempo, nello spazio e nei luoghi, tradurre è un’operazione, un percorso al limite tra il tradimento del significato originale e il senso che noi attribuiamo a quella parola o espressione.
Tradurre, quindi, potrebbe voler dire essenzialmente trasmettere il significato senza modificarlo, bensì restituirlo fedelmente, se ciò fosse possibile.
Il traduttore dovrebbe possedere due anime: quella del linguista e quella del creativo.
Curiosità e distacco sono due parole chiave di un percorso di avvicinamento all’opera da tradurre: la curiosità di chi si pone prima di tutto come lettore attento di un testo, di un messaggio e il distacco di chi lo deve trasferire ai lettori, mantenendo il più possibile il suo ritmo e le sue sfumature.
Tradurre è prima di tutto, quindi, anche una sfida linguistico-cognitiva, oltre che culturale.
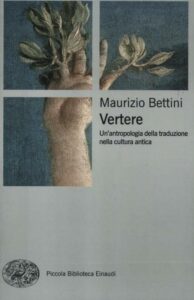
Ogni atto linguistico è una traduzione: ogni articolazione di materiale semantico necessita di essere decifrata dal destinatario e ricomposta in un messaggio; leggere o ascoltare un testo equivale a decodificarlo, a trasporlo in termini funzionali alla comprensione. Questa trasposizione si identifica a tutti gli effetti come una traduzione, che è dunque qualificabile come immanente conditio humana (G.Steiner). Tradurre è anche un efficace strumento di esplorazione dell’identità individuale e sociale, di comunicazione intra- e inter-culturale, di percezione dell’alterità.
(Maurizio Bettini “Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica” Einaudi 2012)
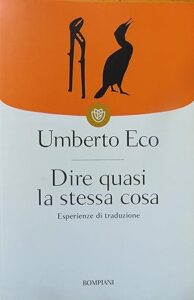
Che cosa vuol dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire cosa significhi “dire la stessa cosa”, e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo parafrasi, definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. In secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi, è persino dubbio che cosa voglia dire dire.
(Umberto Eco “Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione” Bompiani 2003)

L’autrice:
Cornelia Hülmbauer è nata nel 1982 nella Bassa Austria, è poetessa e scrittrice di prosa e saggi. Ha studiato inglese e storia dell’arte a Vienna e a Malta, nonché discipline linguistiche presso l’Università di Arti Applicate di Vienna.
Ha conseguito un dottorato in Linguistica Applicata sul multilinguismo europeo e ha partecipato per diversi anni a progetti di ricerca internazionali in questo campo. Oltre alle pubblicazioni in antologie e riviste (tra cui traduzioni dei suoi testi in ceco, olandese, inglese, francese, greco e slovacco), il suo esordio in poesia è “MAU OEH D“, pubblicato da Sukultur (Berlino) nel 2018, mentre il romanzo “Oft manchmal nie” è apparso nel 2023 con Residenz (Salisburgo/Vienna).
Per i suoi scritti, Cornelia Hülmbauer ha ricevuto diverse borse di studio e premi. Vive a Vienna.
Le traduttrici:

Laura Mautone ha studiato Filosofia e Letteratura, insegna Italiano e Storia in una scuola superiore in provincia di Bolzano, ama la poesia e ha pubblicato diverse raccolte di versi e intervistato alcuni tra i più importanti poeti italiani del secondo Novecento.
Ha pubblicato “Che cos’è la poesia?” (Corraini 2002) , “Dell’amore e di altri aneurismi” (prefazione di Gregorio Scalise, Traven Books 2005), “Acufeni nel cuore” (prefazione di Mary de Rachewiltz, Raffaelli 2007) e “Come sabbia come neve” (prefazione di Maria Luisa Spaziani, Alpha Beta Edizioni 2014).

Magdalena Oberhofer ha studiato Germanistica, Filosofia e Linguistica moderna, insegna Tedesco come seconda lingua in una scuola superiore in provincia di Bolzano, è appassionata di letteratura e si impegna come volontaria nella protezione degli animali.
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Voce d’autore ——————
Luogo che si fa croce
Daniele Ricci, “La macchina da cucire. Geologia del dolore”
di Giovanni Fierro

Il dolore è il luogo dove si può incontrare la persona più prossima a te. Il nostro tempo sociale lo certifica, non c’è dubbio in questo. È l’esperienza che più di tutte si sta facendo linguaggio, presenza di una umanità sempre più in difficoltà, sempre di più nel torto.
A questa verità fa riferimento la poesia contenuta in “La macchina da cucire. Geologia del dolore“, il più recente libro di Daniele Ricci.
L’autore indica con precisione assoluta ciò che sta accadendo, la cronaca – “schegge di granata rompono i vetri,/ dentro la stanza/ c’è un uomo con la formula del fiore” – che trancia il sogno. In modo irreversibile, con l’unica cucitura possibile, quella di fare di una ferita la testimonianza di una cicatrice.
Perché tutto è molto più difficile, non c’è più alcuna direzione chiara e percorribile, “la linea delle briciole/ è incerta/ la sentenza paludosa,/ nel bosco niente uccelli./ L’esilio si beve il lamento” e diventa una nuova assenza.
Il dolore contenuto nelle poesie di Daniele Ricci diventa così un dolore accettato, indistinguibile ormai dalla vita in sé, ma invece sua natura, sua radice, suo ultimo (in tutti i sensi) perché.
È un dolore che libera (“alzarsi nella notte/ corrosa da sogni non terminati/ la parola inventa la realtà“), è un dolore che condanna (“sono un corpo che vive/ senza coscienza/ sdraiato su un letto appena rifatto“), e proprio tra queste due tensioni sta l’essere umano odierno, in un attrito che lo accende, lo consuma e lo fa svanire. Quante cose, anche terribili, si possono dire con la poesia. Quando se ne ha confidenza, proprio come Daniele Ricci fa.
In questo quadro la propria esistenza è la verità da difendere, anche nella determinazione di trasformarla, di adattarla in un tempo atroce e senza speranza, “io sono altrove,/ nella luce ritrovata/ delle mie cicatrici“.
“La macchina da cucire. Geologia del dolore” è voce del proprio io; è resoconto di altri sé, che hanno bisogno di raccontarsi, che non sono in grado di estirpare l’incavo del dolore di cui sono vittime, in un disegno a cui Daniele Ricci, pagina dopo pagina, è capace di dare la profondità di una geologia.
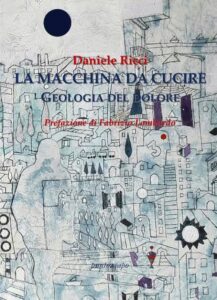
Dal libro:
È domenica mattina
e sei sincero,
sei mio nemico.
Ti nascondi in un buco
e i tuoi soldi non mi interessano.
Gli oggetti non hanno peso
le serrande sono chiuse
i libri di scuola e i quaderni
sono ancora sul tavolo.
Non so ridere, pettino il silenzio.
Nella stanza sento ancora
l’odore di mia madre
l’immagine del mondo.
Se ci fosse vento stamattina
non sarebbe così male…
21 luglio 2022
*
Ci tiene nella stanza
la paura dell’estraneità,
giocando a soldatini
crescono nuove malinconie.
L’ombra della fede
incrosta i sensi
s’arrampica sui nervi,
ruote che perdono il controllo
mio figlio sbanda senza scarpe
senza scrupolo morale
lungo la strada statale
la fila di automobili
sotto il vivaio delle stelle.
28 agosto 2022
*
Tre stelle da cercare ogni sera
lungo la verticale
strada dei girasoli
dove s’inciampa e s’impara
fino alla preghiera.
La mano che cade
nel pomeriggio lacerato,
nel buio della bocca
una strofa obliqua.
Con sguardi evocati dal mercato
sprofondato
nel vivente fiume
noi ragazzi, noi ciliegie
da custodire
la metamorfosi del gelo,
luogo che si fa croce,
inverno paziente.
L’abisso è di calce
spenta nell’acqua
la finestra spalancata
sul nulla.
Nel delirio
di questo stupido baratto
preparo il ritorno.
Metà marzo 2023
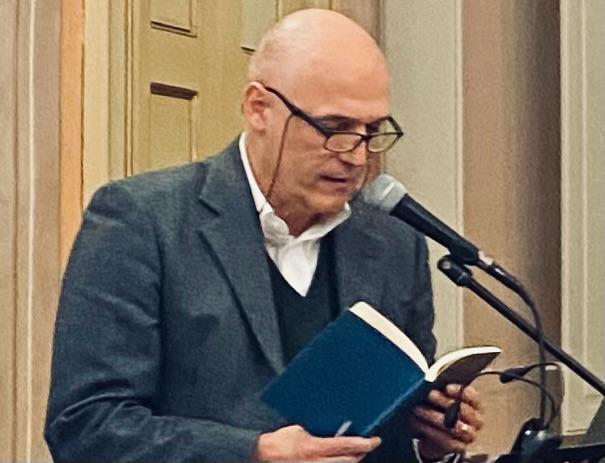
Intervista a Daniele Ricci:
Bisogna stare un po’ dentro a “La macchina da cucire. Geologia del dolore”, è un’esperienza in sé… Per poi forse poter dire che questo dolore di cui scrivi è un dolore accettato, che fa parte della vita. È così?
Forse sì, scrivere il dolore, entrare nel flusso delle sofferenze degli uomini ci aiuta a capire il dolore, ad accoglierlo, ad accettarlo. Ed io questo l’ho fatto anche scrivendo “La macchina da cucire. Geologia del dolore”.
È vero, il dolore nella mia raccolta non è solo un tema, ma una materia viva, stratificata, da attraversare con lentezza e attenzione. Il titolo stesso suggerisce un lavoro meticoloso: la “macchina da cucire” si presenta come uno strumento atto a “rammendare” le ferite, a “ricucire” le lacerazioni, e la “geologia” come scienza che studia le profondità, le sedimentazioni del tempo e dell’esperienza.
Il dolore, allora, non è rifiutato né esorcizzato. È scavato, cucito, stratificato. E forse proprio per questo può essere accettato: perché è stato guardato in faccia, nominato, trasformato in parola. Non è dolore che paralizza, ma che si lascia abitare, che diventa paesaggio interiore. Il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) afferma (in “Zettel. Lo spazio segregato della psicologia“) che il dolore sconvolge e lacera l’uomo, ma egli attraverso il linguaggio può esprimere il dolore dandogli un senso, concedendo così un sollievo alla sofferenza.
In questa raccolta il dolore del corpo si fa voce. Sicuramente qui c’è più voce che corpo, e in questa voce il dolore della memoria e quello presente, il dolore personale e quello universale si confondono e si fondono indissolubilmente.
Che poi il dubbio rimane sempre, perché a volte sembra quasi che sia un dolore che libera, e subito dopo pensi che sia un dolore che condanna…. Cosa ne pensi di questo?
È una tensione potentissima quella che suggerisci: da come la proponi, sembra quasi essere, secondo te, il cuore pulsante della raccolta. Il dolore che libera e condanna, che si muove tra opposti senza mai stabilizzarsi, è forse il segno che non sto cercando una risposta definitiva, ma un modo per stare dentro al mistero dell’uomo e della vita, dentro al mistero dell’essere.
Il dolore che libera può essere quello che ci costringe a guardarci dentro, a smettere di fingere, a ricostruire. Ma, nello stesso tempo, il dolore che condanna è quello che ci inchioda, che ci ricorda ciò che abbiamo sbagliato, ciò che è andato perso, ciò che non può essere cambiato. E ne “La macchina da cucire” questi due poli sembrano cuciti insieme, punto dopo punto, come se non potessero esistere l’uno senza l’altro.
Forse è proprio questo il gesto poetico: non scegliere tra liberazione e condanna, ma accettare che il dolore sia ambivalente, che possa essere allo stesso tempo soglia e prigione, vento e pietra. E solo attraversandolo, senza volerlo risolvere, si può davvero ascoltarne la voce.
Certamente, come afferma Salvatore Natoli (in “L’esperienza del dolore”), “il dolore, qualunque sia la sua origine ed in qualunque modo sia vissuto, rompe il ritmo abituale dell’esistenza, produce quella discontinuità sufficiente per gettare nuova luce sulle cose ed essere insieme patimento e rivelazione”.
Quasi tutte le poesie hanno una data, come a voler indicare il loro momento preciso, il contenitore temporale che le conserva, che le ha generate. Da cosa nasce questa decisione?
Scrisse Charles Baudelaire nella XXXIII prosa poetica de Lo Spleen di Parigi: “Bisogna essere sempre ebbri… per non sentire il fardello orribile del tempo che passa… Di vino, di poesia o di virtù… Ma ubriacatevi”. E, quando alla Vigilia di Natale del 1995, a casa sua a Urbino, intervistai Umberto Piersanti per una monografia che stavo preparando sul poeta delle Cesane (dopo l’uscita della prima edizione de I luoghi persi, Einaudi 1994), alla domanda “Perché scrive poesie?”, lui rispose: “Scrivere poesie è tentare di fermare il tempo, è vivere comunque e dare un segno al caos che ci investe e ci circonda. Scrivo poesie per non morire, scrivo poesie per restare, scrivo poesie perché alcune cose importanti della vita possano trascendere la mia stessa esistenza”. Anche io, come loro e altri grandi poeti, vivo “drammaticamente” il rapporto col tempo, anch’io scrivo poesie per “tentare di fermare il tempo”, per trattenere o differire la fuga temporum inesorabile. Allora, soprattutto ispirandomi a Il porto sepolto (che poi costituirà la sezione principale de L’allegria) del tanto amato Giuseppe Ungaretti, ma anche ad altri poeti come Vittorio Sereni in Diario d’Algeria o Cesare Pavese in Lavorare stanca, per ricordare e trattenere (per sempre?) l’“attimo che accade”, amo riportare al termine di ogni poesia la data esatta del momento dell’ispirazione e composizione del testo. Questa intenzione diaristica nasce dunque da un’urgenza profonda, da un’esigenza dell’anima.

Il terzo capitolo Frammenti dall’inferno è un luogo di fantasmi? Perché queste presenze che tu tratteggi si muovono con una incisività a volte violenta, da cui non si può scappare. Chi sono?
In origine il titolo della terza sezione era Inferno e la mia intenzione iniziale era quella di riprodurre “su scala ridotta” l’inferno dantesco. In questa parte del libro volevo proporre un campionario dei mali e delle sofferenze degli uomini perlopiù causate da altri uomini, dunque volevo proporre nove testi sulle malvagità e sulle crudeltà degli esseri umani. Di quel proposito iniziale sono rimasti solo il numero dei componimenti (nove, come i cerchi dell’inferno della cosmologia medievale e dantesca), qualche immagine tratta dalla prima cantica della Commedia, qualche personaggio (ad esempio Giuda) e un’espressività e un’“incisività a volte violenta”. Ma quest’ultima non è una ripresa voluta e consapevole dall’Inferno di Dante, è nata spontaneamente dal ritmo dei giorni che si succedono e da un’esigenza profonda, a me ignota. La “durezza” e la violenza espressionistica di certi testi come Le piccole mani (in cui viene evocato lo stupro di una ragazza in guerra e il suo successivo, tragico, aborto volontario) vuole essere certamente una testimonianza della crudeltà e degli orrori commessi dall’uomo contemporaneo e di ogni tempo, ma nasce anche, come gran parte delle poesie di questa e della precedente raccolta, da un’intima esigenza d’amore e di vita autentica; parte da una zona oscura e misteriosa della mia persona, dove non sono “padrone di me stesso”; una poesia che viene dai luoghi più arcani, sconosciuti e profondi, ma anche più veri, del mio essere, dove l’“io”, la mia parte razionale, non ha il controllo sulle cose e sulla realtà, per cui la mia poesia si presenta a tratti surreale ed “enigmatica”, ci sono versi o interi testi onirici, visionari, oscuri, il cui senso è sfuggente e, talvolta, sfugge anche a me.
Dunque in questa sezione ci sono i poveri del mondo (Non c’è acqua quaggiù), profughi (Fra coloro che attendono), giovani donne stuprate (Le piccole mani), inetti e ragazzi smarriti nei social (Che cosa s’aggira), ci sono i genitori di Mattia (La mia pietra), ma ci sono anch’io con le mie oscurità, le mie paure e il tedio (Nel cortile di casa), le mie ossessioni (Avvicìnati e spiegami), i miei incubi (Nella casa dei matti) e i fantasmi del passato (Giuda).
Il libro è comunque ricco di presenze, in queste pagine dai voce a diverse persone. Cosa significa entrare nel loro mondo, dare loro voce? E principalmente sono persone che con la vita hanno un attrito importante….
“La macchina da cucire. Geologia del dolore” è una silloge di 64 poesie (scritte tra il 2022 e il 2023 e divise in 7 sezioni) sul dolore degli uomini. Tuttavia il dolore non è più solo evocato e declinato in chiave lirica e personale come nel precedente libro “Lezione di meraviglia” del 2022: ora questa raccolta va a rilevare soprattutto i sommovimenti esterni, contemporanei o già storici. C’è dunque una tensione centrifuga nuova rispetto alla prevalente tensione centripeta della raccolta precedente. Ed è vero, “principalmente sono persone che con la vita hanno un attrito importante” e ricorrono anche figure assai note, come la cantante Amy Winehouse o lo statista italiano Aldo Moro.
Ne “La macchina da cucire” ho sentito l’esigenza di parlare del dolore di tutti gli uomini nelle sue molteplici manifestazioni. Il libro è quindi un campionario del dolore umano in cui tento di dar voce al dolore di chi soffre ovvero cerco di assumere e di vivere, volta per volta, anche solo per un istante, il punto di vista del “paziente”, della vittima, o mi faccio testimone del suo dramma esistenziale. Ma non sono mai “carnefice”, non ce l’ho mai fatta a vivere secondo questa prospettiva l’esperienza dolorosa.
Queste poesie sono dei “viaggi”, anche molto sofferti, nel dolore degli altri: mi addentro per pochi istanti nelle sofferenze altrui e poi, subito dopo, esco fuori, perché non riesco a restarci troppo a lungo, tanto è penosa questa esperienza mimetica.
Il titolo “La macchina da cucire” trae origine dal mestiere dei miei genitori che erano sarti. Ma fa riferimento anche all’attività poetica: nella antica Grecia il rapsòdo (ῥαψῳδός) era un poeta professionista che recitava e cantava poemi epici e altri componimenti (perlopiù opere già esistenti), “cucendo” insieme frammenti di testi esametrici secondo il gusto e l’umore del pubblico. “Rapsòdo” infatti deriva da ῥάπτω, “cucio” e ᾠδή, “canto”: il “rhapsodòs” è quindi “un cucitore di canti, un cantore”, “un rapsòdo” appunto.
Dunque la “macchina da cucire” nasce per “cucire” parole e versi, e con i versi “cucire” il mio dolore con quello degli altri, solidarizzare con gli altri, condividere la mia pena e accogliere il dolore del prossimo. Per realizzare quella “social catena” di cui parla Giacomo Leopardi ne La ginestra. Perché solo con l’amore e la solidarietà tra gli uomini possiamo alleviare o tentare di alleviare il dolore e il male del mondo.
Ha ragione Dino Buzzati quando, ne “Il deserto dei tartari” (1940), scrisse: “Proprio in quel tempo Drogo si accorse come gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangono sempre lontani; che se uno soffre il dolore è completamente suo, nessun altro può prenderne su di sé una minima parte; che se uno soffre, gli altri per questo non sentono male, anche se l’amore è grande, e questo provoca la solitudine della vita”. Nel dolore siamo tutti soli e la solidarietà e l’amore non ci rendono meno soli. Ma l’amore ci può aiutare a sopportare meglio il dolore. È un conforto e un sollievo.
“L’unica salvezza per colui che soffre a causa dell’esistenza è quella di non soffrire più per la propria esistenza. Come potrà ottenerlo? Con la rapida morte oppure con il lungo amore” (Friedrich W. Nietzsche da Frammenti postumi 1882-1884). E io ho scelto il “lungo amore”.
In una poesia c’è un passaggio davvero significativo: “divento me stesso/ mi faccio parola”. È il dire che “La macchina da cucire. Geologia del dolore” è una cronaca dei nostri tempi che si fa documento?
No, la poesia Vorrei una primavera senza inganno (l’ultima della quarta sezione La ginestra sul bordo della strada) è una testimonianza di “fuga dalla realtà presente”. Perché tante mie poesie sono anche un viaggio di evasione dalla realtà storica e contingente: un viaggio in un “tempo-luogo differente” per fuggire il dolore e il male di vivere, il non senso dell’esistenza, la sua precarietà, la fuga temporum inarrestabile, ineluttabile. Un viaggio anche per fuggire me stesso.
L’unico luogo dove posso essere veramente e interamente vivo è “nel caldo” della parola poetica, nel suo incanto. E “laggiù lontano/ dove bianco è il mondo” trovo rifugio, conforto e, forse, salvezza.

L’autore:
Daniele Ricci è nato nel 1967 a Fano. Nel 1998 ha pubblicato la raccolta di versi “Lontananze”, con postfazione di Giuseppe Bomprezzi e sue poesie sono comparse in varie antologie e riviste letterarie.
Nel 2002 ha conseguito un Master in Poesia Contemporanea presso l’Università di Urbino, e ha pubblicato “Lezione di meraviglia”, con prefazione di Marco Ferri, premiato e segnalato in numerosi premi letterari.
Alcuni suoi testi sono compresi nel numero 25 e nel numero 27 della rivista “Smerilliana”.
Del 2023 è la pubblicazione di una silloge di vecchie poesie, scritte tra il 1998 e il 2005, a titolo “Il filo del vento”, con nota introduttiva di Andrea Angelucci. A marzo del 2024 è uscita una nuova edizione riveduta e ampliata di “Lontananze”, con nota introduttiva di Gianni Iasimone.
Dal 2024 cura la rassegna di poesia “Le poetesse e i poeti salutano la primavera” organizzata dal “Circolo Culturale A. Bianchini” di Fano e da gennaio 2025 collabora con il lit-blog Finestre de L’Irregolare, curando la rubrica “Da Orfeo all’infinito. Sguardi e incursioni poetiche”.
(Daniele Ricci “La macchina da cucire. Geologia del dolore” pp. 97, 15 euro, Puntoacapo 2025)
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Ti racconto ——–
Verso l’Isola che c’è
Un testo inedito
di Luca Buiat

Nell’avvicinarmi correndo in bici senza fretta, verso l’Isola che c’è, quella della Cona, mi faccio accarezzare da questo cielo azzurro che illumina la mia ombra sulla strada bianca, sono un corpo umano in costante esplorazione, profondamente immerso nel paesaggio poetico che il Nord-Est ha nelle sue strade.
Intanto cammina allegro e senza pensieri il cielo sopra la centrale termoelettrica di Monfalcone.
Mi volto per ringraziare ancora una volta la strada che mi ha portato fino a qui, quando si “fanno” percorrere, si manifestano, non stanno mai ferme le strade, hanno una coscienza che anima la loro polvere che si scuote.
Le voglio continuare a raccogliere, a comprendere l’essenza di cui sono fatte, durante questi viaggi che faccio nei miei giri infiniti del Nord-Est.
Sono grato a te cara strada, ancora una volta ho sentito ed ascoltato la tua voce, ora siamo qui nell’Isola che c’è.

Nel centro del mio cuore ci sono delle strade che mi portano sempre da un’altra parte.
Partono dalla rampa grigia del mio garage, per andare sui monti, sui fiumi, sui mari che abbiamo là fuori. Bisogna solamente andare, l’unica pratica da tallonare è questa, nulla di più chiaro e limpido, vai fuori, esci, corri con il vento sulla fronte, sulle spalle. Corri!
Strade che mi chiedono un po’ di sudore e sacra fatica.
Questa è una strada che splende sulla riva dell’Isonzo fino al mare dove il fiume la tocca, andandoci dentro.
Guardo felice il cartello di legno con la scritta bianca in rilievo “Isola della Cona”, dove mi abbandono al candore di queste vie che attraversano l’isola che mi respira.
Cerco di avvicinarmi il più possibile alla scansione dei sollievi che genera, intanto il tramonto caldo inizia a sorgere sulle rive, dal pontile il cielo s’immerge nel fiume, dove il fiume assomiglia al cielo che si fonde,
nello specchio del fiume.
Sono qui per abbandonare per un po’ la terra, per diventare come di un’altra forma, un’altra forma di vita.
Qui per imparare ad essere acqua, solamente acqua, acqua che va ed il silenzio che gli suona attraverso.

L’autore:
Luca Buiat è nato a Cormons (Go) nel 1971. Il piacere di “stare” nei libri lo scopre da ragazzo grazie alla lettura de La natura ci parla di Herman Hesse.
È appassionato di escursionismo e dei paesaggi naturali del Nord-Est del Friuli, che percorre in bici oppure a piedi.
Da qualche anno ha iniziato a frequentare i corsi di scrittura creativa che si tengono all’UNITRE di Cormons.
Nel 2024 ha pubblicato il suo primo libro “Una raccolta di silenzi e temporali”, edito da Qudulibri.
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Ti racconto ———-
Nora Gregor, il volto dimenticato
Hans Kitzműller, “Lontano da Vienna”
di Anna Piccioni

Una storia vera, la biografia ricostruita e in parte romanzata di un’attrice, che ai suoi tempi è stata acclamata nei teatri di Vienna, che ha vissuto i set cinematografici di Parigi e di Hollywood e che ha avuto i natali a Gorizia, nel 1901: si chiamava Nora Gregor e Hans Kitzműller col raccontare la sua storia in “Lontano da Vienna” ne onora la sua memoria.
Questa edizione del 2023 del libro riprende, ampliata, l’edizione del romanzo “Weit weg von Wien” scritta da Kitzműller e uscita nel 2014.
Nora Gregor era una donna bellissima, che fin dall’età di quattordici anni volle fare l’attrice e con caparbietà impose ai suoi genitori la sua decisione, trasferendosi con la famiglia prima a Klangenfurt, poi Graz, a Vienna e Berlino: “Nel ricordo Gorizia era diventata sempre più piccola…e non ne avevo mai sentito la nostalgia” scrive Nora.
Dopo Vienna il grande salto a Hollywood, ma i teatri della capitale austriaca e la nostalgia per la città che ha visto i suoi primi passi nell’arte erano un’attrazione fatale e così ne parla: “Dall’America, dove mi consideravano una attrice austriaca, sono tornata diversa, un’americana di Gorizia,di Graz e Vienna, arricchita da un’esperienza nel cinema che devo ammettere, mi ha fatto acquisire una maggior disciplina del corpo e una grande consapevolezza” (1933).
La vita artistica dell’attrice si interseca con i tragici eventi storici del primo Novecento: i momenti di celebrità per le sue interpretazioni teatrali a Vienna sulla scia del successo hollywoodiano saranno interrotti dalla tragedia dell’annessione dell’Austria alla Germania di Hitler, l’Anschluss. Per questo sarà costretta a rifugiarsi a Parigi dove condurrà una vita mondana e interpreterà il film “La règle du jeu” di Jean Renoir, che narra di un mondo effimero e superficiale, inconsapevole dei venti di guerra che si stanno preparando.
Nora Gregor oltre che attrice è anche principessa in esilio, avendo sposato il principe Ernst Rüdiger Starhemberg che aveva fondato in Austria un partito contadino antihitleriano. Con l’occupazione di Parigi, assieme al figlio Heini si muoverà verso l’America Latina, prima in Argentina e poi in Cile.
Ebbe una vita piena di soddisfazioni e di riconoscimenti, ma dopo i quarant’anni tutto quel mondo andò in frantumi. Avrebbe voluto molte volte ritornare a Vienna, rimasta nel suo cuore, ma la mancanza di denaro non glielo ha concesso; sarà sempre riconoscente ad Amalia e alla famiglia Vergara che le concesse di vivere una vita dignitosa.
Nora Gregor morirà nel 1948 in esilio a quarantasette anni.
Fu una donna felice? Tra le pagine del suo diario c’è molta malinconia. C’è in lei la coscienza che il mondo del teatro e del cinema è stato un rifugio, per non vedere la tragica realtà che stava travolgendo il mondo, e che tuttavia non ha risparmiato il suo destino.
Anche l’amore non è stato suo alleato: le storie hanno lasciato ferite profonde nella sua dignità di donna. Il suo unico grande amore sarà per il figlio a cui dedicherà l’ultima sua lettera.
Credo sia doveroso e importante togliere dall’oblio una donna come Nora Gregor.

Intervista a Hans Kitzműller:
Come ha scoperto Nora Gregor?
Non ho scoperto io Nora Gregor. A Gorizia era stata completamente dimenticata. Un giorno un ricercatore in California ha interpellato il Kinoatelje di Gorizia per chiedere se conoscessero questa attrice nata a Gorizia che alle fine degli anni Venti aveva lavorato e fatto film a Hollywood. Aleš Doktoric, Nadja Velusek, Sandro Scandolara e Igor Devetak si sono rivolti a me per fare ricerche in Austria su Nora, anche perché ero l’unico fra quelli che conoscevano, che sapesse un po’ il tedesco. Da lì è venuto fuori il primo libro su Nora Gregor: “L’imperfezione della bellezza”, in cui ho proposto una biografia e la traduzione di alcune pagine del suo diario. Non è finita lì, perché poi sempre quei quattro mi hanno incoraggiato a scrivere un romanzo su di lei che poi è anche uscito: “L’altra regola del gioco” per i tipi della Zandonai, che poi però è fallita (non comunque a causa del mio romanzo!)
Quali difficoltà ha trovato nel tracciare la sua biografia?
Nessuna difficoltà: Nora Gregor era amatissima a Vienna negli anni Venti e Trenta, come attrice cinematografica ma soprattutto come attrice drammatica al Burgtheater. E tutti i giornali parlavano di lei. Ho raccolto un centinaio di articoli e servizi, critiche teatrali e varie interviste su quotidiani e periodici di quegli anni.
Ho trovato anche molte sue lettere. Importanti per me sono state soprattutto quelle con Alma Mahler.
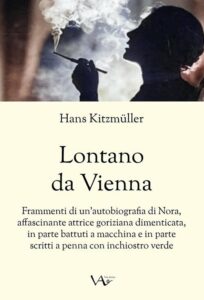
“Lontano da Vienna” è l’edizione ampliata di “Weit weg von Wien” del 2014, quali sono i nuovi elementi?
Non è molto ampliata, ho inserito solo qualche lettera autentica della protagonista. L’edizione tedesca e quella italiana sono in sostanza una ‘autobiografia romanzata’ che cerca di ricostruire i vari periodi della sua vita basandosi però su materiale documentario.
Come è stata accolta in Austria la storia di Nora Gregor?
Nora ha subito a Vienna nel secondo dopoguerra ad una damnatio memoriae principalmente perché era legata ad un periodo molto problematico, quello dell’austrofascismo. “Weit weg von Wien” ha riscosso comunque un discreto successo ed ha esaurito la sua prima edizione.
Che destino ha avuto il principe Starhemberg e il figlio Heini?
Il principe Starhemberg è ritornato in Austria nei primi anni Cinquanta, quando il governo austriaco ha deciso di restituirgli tutti i suoi beni che gli erano stati espropriati dai nazionalsocialisti dopo l’Anschluss. Parliamo di dodici castelli! Oppositore di Hitler e contrario all’annessione dell’Austria al III Reich, si trovava dal 1938 in esilio a Parigi. Se fosse tornato in Austria avrebbe fatto una brutta fine. Durante la seconda guerra dimostrò di essere uno dei pochi austriaci che combatterono pubblicamente contro Hitler in quanto venne arruolato dall’aviazione francese sotto il comando di de Gaulle. Morì nel 1956 appena tornato in Austria per prendere possesso dei suoi possedimenti che gli vennero restituiti, ma morì d’infarto il giorno dopo aver rimesso piede nella sua patria in seguito ad una discussione con un giornalista che lo contestava.
Il figlio Heini qualche anno dopo, tornò anche lui in Austria, ma nato e cresciuto in Sudamerica non riusciva ad ambientarsi in Austria e tornò nell’America latina, e morì a Buenos Aires alcuni decenni dopo.
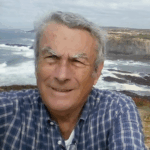
L’autore:
Hans Kitzműller è germanista, traduttore e scrittore, vive a Brazzano (Gorizia). Già docente di lingua e letteratura tedesca a Venezia e a Udine, ha pubblicato uno studio su Christine Lavant (Le parole, la luna, 1996) e uno su Peter Handke (2001).
Alla Gorizia austriaca Kitzmüller ha dedicato numerose ricerche (fra l’altro Görz 1500-1915, 1995). Di Peter Handke ha tradotto “Canto alla durata” edito da Einaudi nel 1995. Ha curato la versione in tedesco de “I Turcs tal Friûl”, dramma di P. P. Pasolini scritto in friulano,
Ha tradotto “Ricordi goriziani” del raccoglitore di leggende Anton von Mailly e quella di una scelta di poesie di Elisabetta d’Austria (Diario poetico,1998).
Il suo primo romanzo apparso in italiano nel 1999 è stato “Viaggio alle Incoronate”. Sono seguiti “Arcipelago del vento” (2003), “Alle Isole Marchesi” (2005) e nel 2008 “E in lontananza Gorizia”, una riflessione in forma narrativa sul paesaggio della propria regione.
Nel 2014 è uscito in tedesco il romanzo “Weit weg von Wien” che ha contribuito alla definitiva riscoperta dell’attrice goriziana Nora Gregor (protagonista fra l’altro del film “La règle du jeu” di Jean Renoir).
Dal 1984, come Edizioni Braitan, Hans Kitzműller ha pubblicato in traduzione italiana anche numerosi autori friulani, sloveni e carinziani. Le sue più recenti pubblicazioni sulla Gorizia del passato sono state “Lo Staatsgymnasium di Gorizia” (2021) e “Gorizia austriaca” (2023), entrambe con il sostegno dell’ICM.
(Hans Kitzműller “Lontano da Vienna” pp. 252, 20 euro, Vita Activa 2023)
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Ti racconto ———
Di fine settembre
Un testo inedito
di Luca Buiat

Sono arrivate queste giornate di settembre, le ultime giornate.
Cadono improvvise sui colli che ci vivono accanto, quasi appiccicati alle nostre case.
Qui abbiamo le finestre che danno sui boschi, e quando le apriamo sentiamo il Verde venirci incontro.
Ci ritroviamo in ascolto del richiamo che si porta dietro di sé, attraverso la grazia dei sentieri che vanno dentro al Quarin.
Sentiamo le voci sfregate e sottili delle foglie, quando possono, ci vogliono accarezzare. Ci lasciamo andare così nel bosco ogni volta che possiamo, ogni volta che abbiamo il tempo che talvolta non troviamo.
Noi cerchiamo il sacro bisogno di custodire il tepore di quell’attimo, tenerci tra le mani il riflesso che si rigenera tra i rami dei castagni verso la metà del giorno, la delizia nel rossore che fanno i primi ricci caduti a terra.

Sono arrivate delle giornate diverse in questo settembre, i colori sono differenti. Queste serate spezzate che scivolano sui laghetti del Preval dove un vento fortissimo ha rotto improvvisamente settembre.
Ora vedo e mi godo il più possibile l’irruzione di queste luci infrante dell’estate che fanno i loro ultimi passi.
Tramonti di luci che fanno del Quarin un colle giallo canarino che saltella morbido e canta tra gli ulivi, scivola tra i vitigni, raggiunge i tetti delle nostre case.
Dentro i vetri delle finestre dove quando possiamo ci mettiamo le nostre utopie.
Intanto sui prati del Preval si allunga il canto selvatico del topinambur con i suoi petali accesi che squillano attraverso le vie dei caprioli.
Sgambettano e corrono via i caprioli, appena sentono un mio passo più rapido, un tocco più deciso sulla terra e se ne vanno via veloci sfiorando le cortecce, andandosi a fermare in un posto più intimo dove affermare il loro rifugio, la loro eterna fuga dalla curiosità degli uomini.
Io credo che qui dove viviamo noi, quando arriva settembre e le giornate si spezzano, cresce il Topinambur.
Splende sui prati per compensare quello che ci manca a fine settembre.
Nei suoi petali resta e sopravvive ancora l’ultima luce dell’estate.
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

Tempo presente ——————
Una regalità selvaggia
Giancarlo Baroni, “Il mio piccolo bestiario in versi”
di Giovanni Fierro
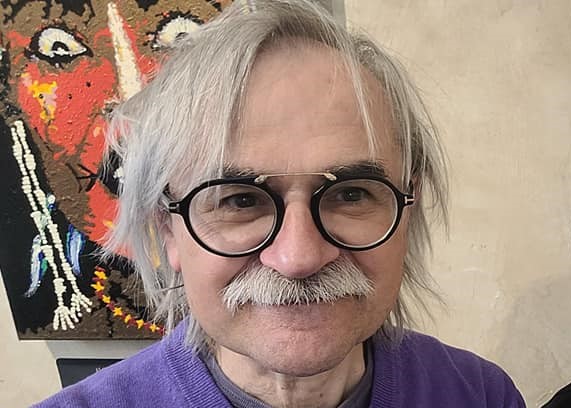
È un lavoro certosino e fatto con cura “Il mio piccolo bestiario in versi”, libro con cui Giancarlo Baroni omaggia la presenza animale nel mondo della poesia. “Da bambino preferivo le figurine degli animali a quelle dei calciatori; la passione continua”, inizia così questo piacevole volume, e il suo svilupparsi, pagina dopo pagina, è un continuo esplorare, trovando l’intonazione giusta a partire da Umberto Saba, “Tu sei come una giovane,/ una bianca pollastra”, “Ho parlato a una capra./ Era sola sul prato”, per poi proseguire da autore ad autore, da poesia a poesia, disegnando un percorso ricco di citazioni e riflessioni, in un movimento di ricerca che è ricco e vario, tra pipistrelli e lucertole, cani e gatti, istrici e talpe…
Per poi anche interrogarsi, come quando Baroni scrive: “Cane oppure gatto, ‘cinofili’ o gattofili’? La domanda è perentoria e la risposta forse semplice: dipende dalle esigenze, dalle preferenze. Antepongo la fedeltà all’indipendenza? Allora probabilmente cane. Privilegio il mistero alla versatilità? Dunque forse gatto”.
È davvero un caleidoscopio di animali che lasciano la propria impronta nella poesia che più amiamo, la loro presenza che dona ulteriore vita e confronto, occasione per condividere tutto quanto ci è più caro, dalle certezze ai desideri.
“Chuang Tzu […] sognò che era una farfalla e non sapeva, destandosi, se fosse un uomo che aveva sognato d’essere una farfalla o una farfalla che sognava d’essere un uomo”.
La bellezza di “Il mio piccolo bestiario in versi” è anche quando Baroni dice “amo le creature alate, che mettono in contatto la terra con il cielo”, e il merlo lo caratterizza con semplice ammirazione, “saltella, cammina, si nasconde fra i cespugli, ci osserva da sopra un ramo, vola via…”.
Nel libro c’è spazio anche per gli animali inventati, frutto dell’immaginazione dell’uomo, creature fantastiche che da sempre hanno affascinato Giancarlo Baroni. Come ad esempio il grifone, che “è per metà aquila (la signora del cielo) e per metà leone (il sovrano della terra). Aquilina la parte anteriore (becco a uncino, zampe con artigli devastanti, ali enormi), leonine la coda e la parte posteriore del corpo. Fortissimo, è in grado di lottare con i draghi”.
Ricco e vario, “Il mio piccolo bestiario in versi” di Giancarlo Baroni è opera degna di nota e merito, raccolta non solo di poesie, ma anche di sguardi interessati e memoria viva, intreccio di passione e devozione. Qualcosa di prezioso, da avere sempre vicino.
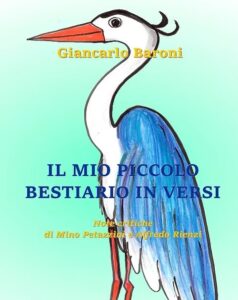
Dal libro:
Il cinghiale
di Pier Luigi Bacchini
Ficcato, il suo grifo villoso, contro il muro
tra le bottiglie. Trofeo da caccia
sull’Appennino. Tra etichette di vigneti scelti,
– e i rovi. Con i canini arcuati,
l’occhio obliquo. Una regalità selvaggia. E la polvere
si è depositata, adagio, su quei vetri
di vini tabaccosi. Appeso. Morsicato dai cani. Fulminato
dalle doppiette.
[…]
*
Aeree frontiere
di Giancarlo Baroni
Nati prima degli eroi e della terra
a voi uccelli tocca
il primato sul mondo. Al primogenito spetta
sempre l’investitura.
Il nibbio è principe dei Greci
e l’ibis signore degli Egizi.
Come un’intercapedine, un’aerea frontiera
fra la gente e gli dei
sta la vostra città. I sandali di Mercurio
si spostano con le ali e il messaggero viene
rapido a farvi visita. Noi uomini giungiamo
fin lì con la preghiera
di predire il futuro. Giove con le folgori
e il fuoco di Vulcano
vi tolgono le parole
mutandole nel canto
che tutti vi invidiamo.
*
Oasi
di Andrea De Alberti
[…]
Guarda la lontra, ha ancora la testa sudata,
un castoro nuota a ritroso, il bradipo è sveglio,
mentre mio figlio lo guarda dopo il lungo riposo,
oppure la didascalia dice che certi pesci tropicali
mangiano a mezzogiorno come gli umani.
Mi muovo più lento guardando da molto vicino un
gufo reale,
osservo il volo del nibbio,
mi sembra il verso del gheppio come un segnale
di avvicinamento all’inverno.
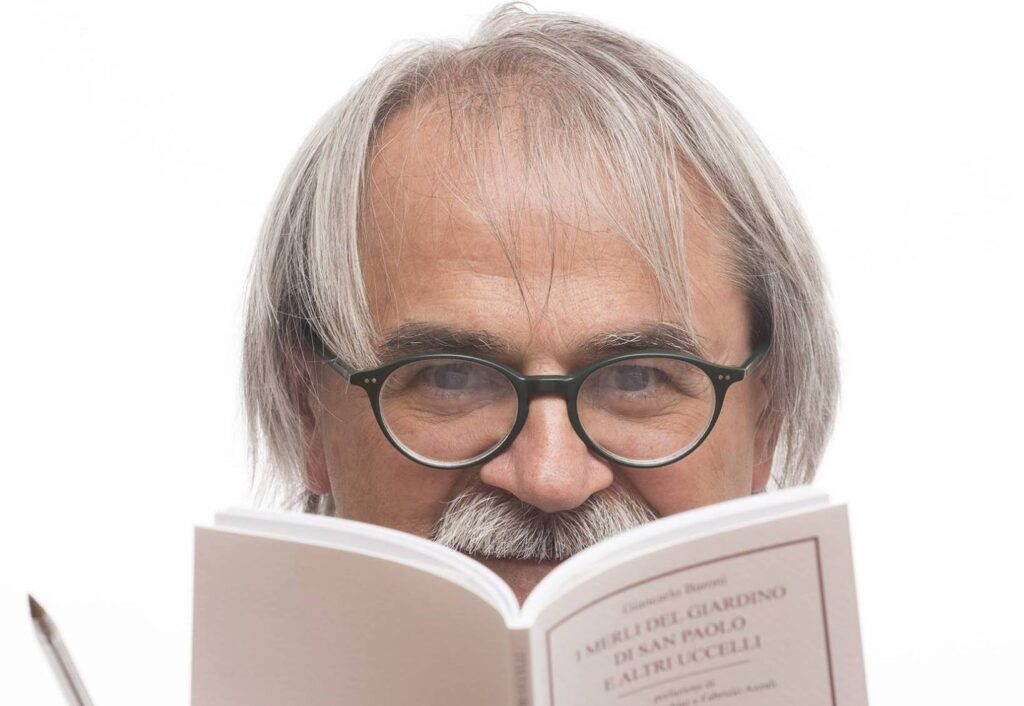
Intervista a Giancarlo Baroni:
Cosa c’è alla base de “Il mio piccolo bestiario in versi”?
Il libro inizia così: “Da bambino preferivo le figurine degli animali a quelle dei calciatori; la passione continua. Qualche anno fa ho immaginato che la mia pagina facebook fosse una piccola Arca di Noè dove, ogni settimana, entrava un animale descritto nei versi di poeti italiani contemporanei; da lì ha origine questo mio piccolo bestiario in versi”.
Quanto è importante l’immaginario animale nel fare poesia?
Gli animali e soprattutto gli uccelli hanno rappresentato per me un’importante fonte di ispirazione. Nel 2009, con l’editore Mobydick, ho pubblicato una raccolta che si intitola “I merli del Giardino di san Paolo e altri uccelli”, con prefazione di Pier Luigi Bacchini, interamente dedicata alle creature alate; del 2016 è una edizione ampliata e illustrata (prefazioni di Pier Luigi Bacchini e Fabrizio Azzali, illustrazioni di Vania Bllosi e Alberto Zannoni, Grafiche Step editrice).
“Gli uccelli”, afferma Giorgio Caproni, “sono sempre i primi/ pensieri del mondo”.
Scrive nella sua nota critica Mino Petazzini: “Dall’incontro tra poesia e natura sono nate e possono ancora nascere infinite meraviglie”; ribadisce a sua volta Alfredo Rienzi che “Meravigliarsi della presenza degli animali nella poesia e, più in generale, nell’arte equivale a stupirsi che l’aria entri ed esca dai polmoni”. Dell’immaginario animale in poesia entrambi sono assai esperti.
Cosa accomuna, nella poesia ma non solo, gli animali veri e quelli inventati e fantastici?
Nella seconda parte del volume, intitolata “Animali fantastici”, si parla di Bestiari medioevali, del Basilisco re dei serpenti, di San Giorgio, la Principessa, il Cavallo e il Drago, del favoloso zoo di pietra del Battistero di Parma e del Duomo di Modena. Non solo poesie quindi ma architetture, monumenti, dipinti, miti, leggende.
“Fra gli animali fantastici”, scrivo, “quelli che maggiormente suscitano curiosità e stimolano l’immaginazione sono i cosiddetti ibridi, la cui fisionomia nasce dalla combinazione stralunata e capricciosa di parti del corpo di diversi animali. Una specie di stupefacente e raccapricciante mosaico” generato dalla fervida, versatile e creativa fantasia umana.
Secondo te, la parte animale c’è, o manca, alla poesia contemporanea?
“Gli animali da sempre appassionano i poeti e ispirano i loro versi”. Nel libro ho raccolto le testimonianze poetiche di una moltitudine di poeti, non importa se più o meno famosi, principalmente italiani contemporanei.
Sono consapevole che l’argomento è vasto e le mie conoscenze limitate, mi scuso perciò con gli autori che non ho nominato. La mia ricerca però continua in previsione di una futura edizione aggiornata e ampliata. Chissà.
E a quale animale assomiglia di più il tuo fare poesia? E perché?
Lo scoiattolo è agile, scattante, quasi inafferrabile nel suo rapido manifestarsi, capace di apparire e sparire repentinamente, di proporsi e di sottrarsi in un batter d’occhio. Apprezzo in modo particolare questo testo di Luciano Erba: “poesia sei come uno scoiattolo/ resti in letargo per parecchi mesi/ quando ti svegli salti in mezzo al verde/ vedo appena la tua coda folta/ prima che scompaia dentro gli abeti”.

L’autore:
Giancarlo Baroni è nato a Parma, dove abita, nel 1953. Ha pubblicato due romanzi brevi, qualche racconto, un testo di riflessioni letterarie (“Una incerta beatitudine”) e otto raccolte di poesia, tra le più recenti “Le anime di Marco Polo” (2015) e “I nomi delle cose” (2020).
Del 2020 è anche il volume di poesie e fotografie “Il colore del tempo” e del 2024 “I nostri gatti esenti da difetti (7 mie poesie)”, con illustrazioni di Vania Bellosi, Elena Bertoncini e Alberto Zannoni.
Ha coordinato, assieme a Luca Ariano, l’antologia “Testimonianze di voci poetiche. 22 poeti a Parma” (2018). Nel 2009, 2010 e 2011 ha letto suoi testi a “Fahrenheit” (Rai Radio 3).
Per quasi vent’anni ha collaborato alla pagina culturale della “Gazzetta di Parma”. Per la rivista on line “Pioggia Obliqua. Scritture d’arte” cura una pagina intitolata “Viaggiando in Italia”; collabora a “Margutte. Non-rivista on line di letteratura e altro”.
(Giancarlo Baroni “Il mio piccolo bestiario in versi” prefazione di Mino Petazzini, postfazione di Alfredo Rienzi, illustrazione in copertina di Vania Bellosi, pp. 93, 15 euro, puntoacapo 2025)
Immagini ——————–
HABITAT
di Franco Belsole

HABITAT – in un tempo e luogo qualunque
Intervista a Franco Belsole
di Luigi Auriemma

Caro Franco, ci introduci nel tuo progetto sfociato poi in un libro dal titolo “HABITAT – In un tempo e luogo qualunque”?
“Habitat” fa parte di un progetto artistico che approfondisco da diversi anni, possiamo dire che è un progetto a larga scala, visto che coinvolge, attraverso il lavoro fotografico, varie metropoli nel mondo.
Alcuni urbanisti prevedono che tra qualche anno, nelle città si concentrerà il 70-80 % della popolazione mondiale dando vita alle cosiddette “città mondo” o “mondo città” come dice Marc Auge’, quindi trovo interessante una visione su questo campo, esplorando e sintetizzando una complessità del mondo esterno in relazione al nostro vivere ordinario, in contrapposizione anche a un magma psicologico interiore ad ognuno di noi.
Il tentativo è di riprendere l’anonimato senza teatralismi o messa in scena, presente nelle grandi città, e trasferirlo in uno spazio artistico, in un contesto d’arte.
È una ricerca che sviluppa e approfondisce il mondo metropolitano annullando, o quasi, i segni di riconoscimento di una singola metropoli rispetto l’altra, caratterizzando un mondo globale di interazione individuale e di collettività, in spazi anonimi.
In questo lavoro sono interessato a una fotografia che si differenzia dal concetto cosi detto “bressoniano’’ quello di fissare l’attimo decisivo, spettacolare, piuttosto sono interessato ad una fotografia che rimanda e sostituisce il significato dell’unicità dello scatto alla complessità della visione in genere, attraverso una serie di momenti, di passaggi di transitoria estemporaneità, assumendo ed evidenziando un concetto specifico, di totalità nel rilevare l’astrazione e il tema di fondo.
Analizzando visivamente una tua foto, si nota da subito una rigorosa griglia compositiva, quasi ricercassi un equilibrio tra gli elementi; per esempio piccoli particolari come una maglietta, una pettinatura o un accessorio dei personaggi fotografati si confrontano a simili elementi di architettura. Da cosa nasce questa esigenza espressiva?
Sono attratto dal flusso anonimo delle folle, separandomi da ogni forma di contaminazione e logica preconfezionata visiva, tutto ciò mi porta la contingenza di rappresentare nelle immagini, un evento che si possa dire esaustivo nella sua natura statica di rappresentazione, persino attraverso il contributo di una “maglietta a righe” di un personaggio o qualcos’altro che possa stabilire o richiamare una simmetria e coerenza con il significato e luogo in cui si svolge l’evento ripreso.
D‘altronde nella fotografia, cosi come nelle altre discipline artistiche, si dà molta importanza a particolari, magari sfuggiti a una prima lettura che richiedono una attenzione più accurata e profonda e che svolgono una rilevanza emblematica, di rappresentazione di un momento che si possa dire di equilibrio, di staticità definita e raggiunta, dell’attimo che si vuole rappresentare.
Le opere in questo progetto mettono in relazione l’uomo con l’architettura, o meglio il corpo-uomo con il corpo-architettura, questi corpi come si pongono con il corpo-mondo rispetto al tuo pensiero di artista?
Il mio pensiero si basa e si concentra proprio in questa relazione tra “corpi”, con parti di architettura urbana che riflettono la nostra vita il nostro quotidiano, il nostro relazionarci con il mondo esterno e interno a ognuno di noi, costruito di spazi, e luoghi interposti, reali o illusori, che determinano la nostra appartenenza assegnataci.
Cerco di lavorare sulla dicotomia tra anonimato della folla e identità individuale, e sebbene in un contesto urbano o habitat facciano da scenario elementi strutturali in una veste simbolica, non sono quest’ultimi a essere al centro del lavoro pur rivestendo una impronta di rilievo, ma sono il tramite di rivendicare l’unicità dell’individuo e il mondo circoscritto a cui è relegato, sono immagini apparentemente informali in contrapposizione a parti o limiti imposti, interpretati da strutture architettoniche simboliche.
È una fotografia che ci comprende, che ci assomiglia coinvolgendoci nella nostra contemporaneità, ma che si interroga sugli impedimenti opposti di varia natura, culturali, sociali, in cui emerge un senso generale di mancanza, di ‘’non raggiungimento”, in una percezione di disincanto e incertezza che accompagna i personaggi ripresi nelle immagini in corrispondenza del nostro vivere, delle nostre domande, del nostro tempo, in una società certamente non a misura d’uomo.
I personaggi presenti nelle tue foto, alcuni sembrano essere in posa, altri (non ripresi in volto) non hanno identità, tutti sono comunque, nei loro movimenti, non bloccati ma rallentati, altri completamente alieni e inadeguati al contesto architettonico. Questo può essere letto come una tua indagine della società contemporanea in chiave socio-antropologica e psicologica?
Penso che quando l’obiettivo fotografico o l’interesse di una ricerca artistica si orienta verso la figura umana specialmente in un contesto di habitat, inconsciamente o volutamente andiamo a convergere in una lettura della società di carattere socio antropologica, d’altronde lo scopo primario in questo caso è quello di documentare una realtà con tutte le molteplicità che possono essere di carattere etnico, sociale, ecc. , in particolare non cerco una forzatura in una specifica lettura socio-politica, ma una riflessione e interpretazione artistica che possa interrogarci sul nostro vivere.
Il proposito è di un lavoro fotografico che rispecchi il nostro tempo riprendendo l’ordinario, mettendo in rilievo nei personaggi un profilo di estraneità al momento, al luogo e alla società di cui fanno o facciamo parte.
Cerco di fare in modo che le nostre storie, i nostri giudizi la nostra capacità empatica di fruizione delle immagini, da qualsiasi aspetto o provenienza socio culturale vengano considerate, siano parte e completino le sequenze fotografiche, rendendole condivisibili, facendoci sentire partecipi e complici al lavoro stesso.
È una fotografia che rifiuta la messa in posa, e che nasce credo dal’ attitudine di staccarmi da qualsiasi legame di appartenenza e provenienza storica culturale, da ogni qualsiasi forma di contaminazione e logica preconfezionata visiva, e immergermi in una volontà di dimensione empatica con la situazione ricercata venutasi a creare in un determinato momento, quello definito dallo scatto fotografico.

I luoghi o particolari di architettura che per astrazione compositiva diventano non-luoghi, non identificabili, astratti sono elementi di una possibile città immaginaria perfetta o contrariamente uno spazio poco vivibile per nulla in armonia con l’essere umano?
Oggi viviamo nelle città e le città vivono dentro noi, il sociale fa parte del paesaggio, e l’immagini credo che determino un corpo unico nella visione e nel approfondimento del contemporaneo, quindi rispondendo alla tua domanda direi che la necessità di fotografare il dato reale nelle metropoli, sia l’esigenza di documentare il mondo allo stato puro, senza manomissioni fotografiche di alcun genere, sia in fase tecnica che di post produzione e la scelta di rinunciare ad una forma di teatralità di ripresa, penso che sia la prova di porre attenzione e interrogarci degli spazi del mondo che non sono, per nulla in armonia con l’essere umano.
L’intenzione è quella di documentare un estratto, un frammento delle nostre vite, una transitoria estemporaneità dei nostri spazi, dei nostri non luoghi che rimandando il significato dell’unicità dello scatto, alla complessità della visione.
Del resto la realtà che ci circonda diventa sempre più frammentata e complessa, noi tutti guardiamo intorno con meno percettività, e il nostro sguardo è diventato sempre più introverso, le nostre vite sempre più impercettibili e isolate a ciò che accade intorno a noi.
Le tue sequenze fotografiche appaiono all’occhio dell’osservatore come fotogrammi di un’unica pellicola cinematografica, ci parli della tua esperienza relativamente al film dal titolo “QUE SUIS – JE”?
Sono stato sempre interessato alle probabilità di un aspetto cinematografico del mio lavoro e l’occasione è sfociata mentre mi trovavo a Parigi durante un lavoro.
Il tutto e nato per merito di una scritta pubblicitaria in rilievo, presso un grande centro commerciale nel quartiere le La Defense di Parigi che indicava appunto QUE SUIS – JE, il tutto alternato con luci dinamiche ad intermittenza.
Ho trovato interessante e curioso che una campagna commerciale imposti il proprio programma di vendita prodotti con un’interrogazione esistenziale molto profonda. Da lì nasce lo spunto per una connessione tra il mio lavoro caratterizzato da immagini statiche in relazione con immagini in movimento e devo dire che in tutti e due i casi, esiste una certa attinenza tra linguaggi nel raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato.
D’ altronde nella mia prima fase di lavoro con la fotografia le mie immagini si orientavano sulla possibilità e continuità di un linguaggio cinematografico e video-arte.
Quale è stato il tuo rapporto con due media simili ma diversi?
Diciamo che sono due discipline, come dici, simili ma diverse certamente, io aggiungerei che per la video-arte naturalmente anche complementare.
Il rapporto tra i due media e in particolare con il video, è stato sostanzialmente un fattore tecnico di ripresa, in quanto l’intento è quello di raccontare l’evento, che in fotografia naturalmente è statico e definito nella sua compiutezza dell’attimo.
Nella videoarte richiede una narrazione dinamica, fluida, che va a influire sui tempi e sugli anticipi di ripresa, creando nell’aspetto, porzioni di tempo-visione che si completano reciprocamente allacciandosi, in una narrazione esaustiva e definita al corpo dinamico dell’immagine.
Per quanto mi riguarda, trovo che i due media siano congrui per la mia ricerca nelle loro specificità, forse nella video arte c’è un arricchimento in più, per quanto riguarda l’accompagnamento musicale o audio, a discapito di una fotografia che richiede meno programmazione nel riprendere l’evento, in una non teatralità, rendendo certamente l’immagine meno espansiva in sé, più istintiva e con minor tempo di gestazione nella compiutezza finale.
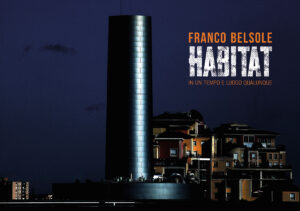
Il libro “HABITAT in un tempo e luogo qualunque” di Franco Belsole, con testo di Matteo Cremonesi, è edito da Vanillaedizioni.

L’artista:
Franco Belsole nasce a Viterbo. Nel 1990 inizia a lavorare con la fotografia collaborando con operatori culturali e artisti realizzando documentazioni a carattere artistico.
Nel 1991 vince una borsa di studio al Progetto Internazionale Civitella D’Agliano fondato dal critico d’Arte Filiberto Menna. Nel 1992 espone in una collettiva con pittori e scultori al Palazzo d’Alessandri di Viterbo.
Approfondisce il suo linguaggio fotografico in linea con la tendenza documentaristica della scuola di Düsseldorf, pur mantenendo un suo personalissimo stile.
Nel 1993 inizia a realizzare lavori su metropoli come Parigi, Monaco, Londra, Helsinki, Berlino. È nell’ambito di Photogrammatica, la rassegna Internazionale di Fotografia di Roma, che nel 1993 gli viene assegnato il premio Sebastiano Oschmann Gradenico Giovani Fotografi Romani.
Nel 1994 è a New York, nel 1997 è finalista al premio arte moderna Flash Art Museum.
Nel 1998 vince il primo premio della critica alla Biennale Internazionale della Fotografia del Trevi Flash Art Museum.
Realizza “Streets“, un lavoro sulle strade di New York, dal quale uscirà anche un libro, presentato successivamente alla mostra personale nella galleria AOCF58 di Roma.
Nel 2002 è a Philadelphia dove realizza “Market Street“, un lavoro concentrato su una delle strade e vie principali di Philadelphia. È del 2006 il libro fotografico “Fermata Taxi con Dedica“.
Nel 2007 vince il primo premio nel concorso nazionale d’arte contemporanea “Saturarte” di Genova.
È del 2013 il libro fotografico “PARIS 2010” presentato alla Galleria Laure Roynette di Parigi.
Seguono numerose mostre personali e collettive ed è presente in rassegne internazionali in Italia e all’estero. Le sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche.
www.francobelsole.com
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Anna Piccioni, Antonio Nazzaro, Antonello Bifulco, Luigi Auriemma, Laura Mautone, Ilaria Battista, Livio Caruso.


