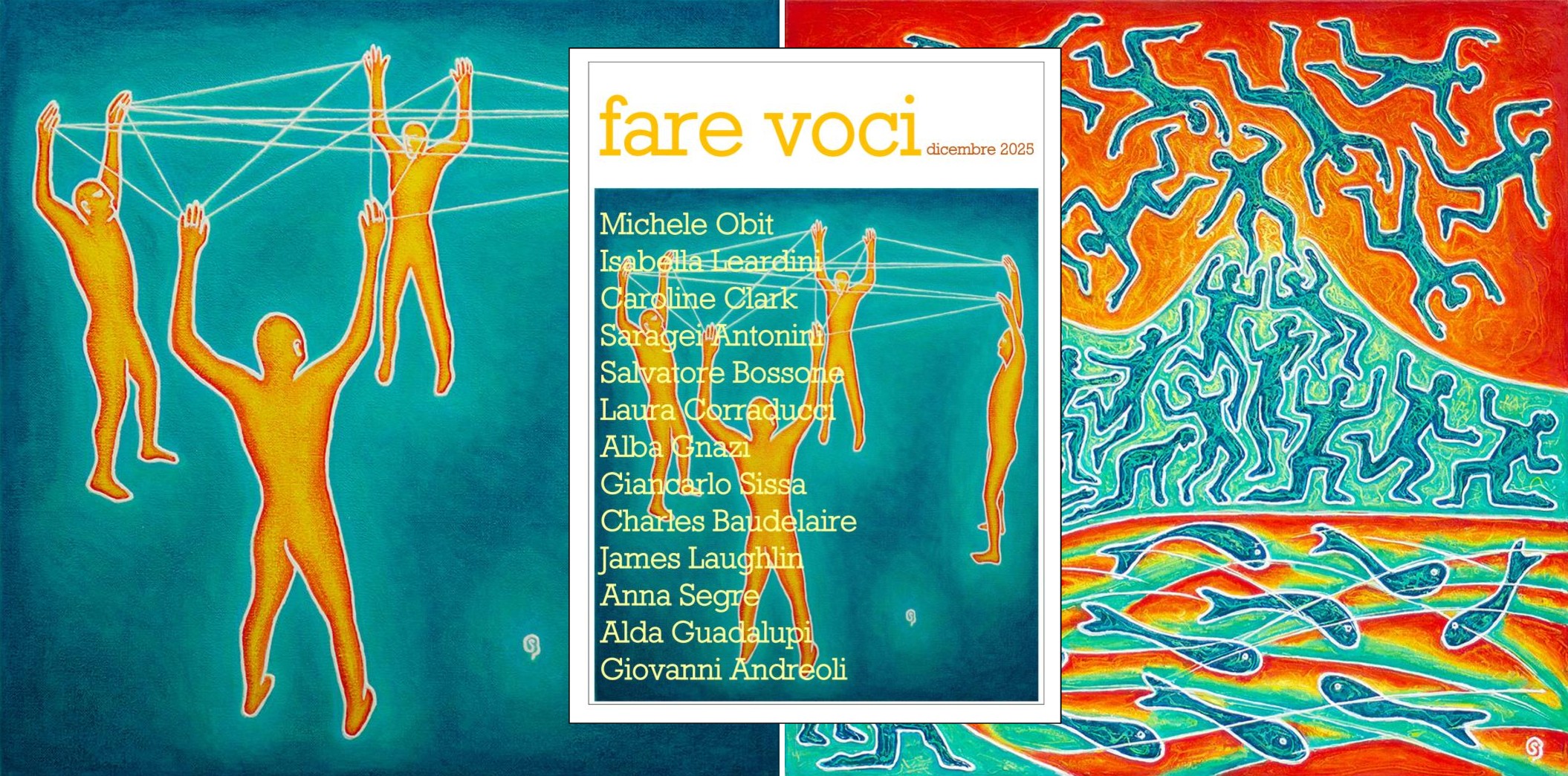Ed è giunto anche l’ultimo mese dell’anno. Il giusto momento per fare ulteriore attenzione al nostro tempo presente, luogo e momento sempre più bisognoso di una lettura attenta e partecipata.
E questo nuovo numero di “Fare Voci” è un rinnovato invito a nutrire la propria sensibilità e curiosità, nel confronto e nell’incontro.
Ad iniziare da Michele Obit, che fa un po’ il sunto del suo percorso d’autore con l’antologia di propri testi “Ricordarsi del privilegio”. Per poi esplorare la nuova uscita della storica collana “Lo Specchio”, grazie ad Isabella Leardini e il suo nuovo libro “Maniere nere”.
Laura Corraducci traduce e ci presenta Caroline Clark, con cinque suoi testi inediti in italiano.
E Giancarlo Sissa ci invita a perderci e ritrovarci, nuovamente, nello scrivere di Charles Baudelaire, e nello specifico nel suo “XCIII A una passante”. Da qui anche la possibilità di stare con James Laughlin, nella sua poesia “Canzone”.
Con tanto piacere torniamo ad occuparci di Saragei Antonini, il suo “La volpe dell’insonnia: a spizzata” è libro di assoluta bellezza, dove italiano e dialetto trovano l’equilibrio in uno stesso respiro.
La poesia continua a sorprendere anche grazie ad Alba Gnazi, che con “Sopravvivenza in acqua” è capace di raccontare una mancanza che non diventa mai vuoto….
E poi ci sono anche Anna Segre con la sua nuova raccolta “Onora la figlia”, Alda Guadalupi con l’intenso “Meno Odio Tanto Amore” e Giovanni Andreoli con “Absorbeat”, libro che sorprende e coinvolge.
Le immagini sono di Salvatore Bossone, una mappa di veri e propri luoghi dove il dipingere accade e accende.
Buona lettura e buone feste.
Giovanni Fierro
(la nostra mail è farevoci@gmail.com)
Immagini —————–
Città
di Salvatore Bossone

Voce d’autore —————–
Non calpestate l’erba – e nemmeno i poeti
Michele Obit, “Ricordarsi del privilegio”
di Giovanni Fierro

Per fortuna la Poesia ha persone come Michele Obit. È grazie alla sua presenza, e a figure come lui, se la Poesia continua ad essere un laboratorio permanente di umanità e dialogo.
Autore che ha una certa confidenza con le Valli del Natisone, quella Benecia zona di frontiera dove Italia e Slovenia (e prima ancora Jugoslavia) si toccano e si intrecciano, zona che però troppe volte si è fatta confine, taglio e divisione, Michele Obit con il suo fare poesia, con il suo essere tramite di mondi espressivi (È anche traduttore dallo sloveno all’italiano e organizzatore di incontri, come sono stati gli appuntamenti delle Voci dalla Sala d’Aspetto, al festival Stazione di Topolò Postaja Topolove) è riferimento significativo, presenza preziosa in un ambito dove la scrittura sempre di più è strumento vitale e necessario.
L’occasione per parlare del suo scrivere è la pubblicazione di “Ricordarsi del privilegio”, antologia selezionata dei suoi scritti, a cui si aggiungono alcuni inediti.
Fin dall’esordio con la raccolta “Notte delle radici” del 1988, Obit ha saputo mettere a fuoco la forza che nutre la poesia, il dubbio che chiede alle parole di essere domanda perpetua, invocazione alla verità, fiducia che si costruisce anche andando a capo, anche lasciando una riga vuota: “Non sarò mai certo/ di essere stato bambino”.
E questo lavoro di ricerca ha poi portato a “Per certi versi – Po drugi strani”, nel 1995, altro luogo di rinnovata sensibilità espressiva, dove il domandarsi della poesia, ma ancor prima della parola, è allo stesso tempo forza e fragilità, nello stare in una considerazione come “E che la mia voce/ dicesse le parole – non/ le sussurrasse – e che le mie parole/ dicessero le cose – non le nascondessero”, che diventa fulcro e tensione generatrice per tutto lo scrivere che seguirà, perché “se parole davvero/ potessero dire tutto/ non sarei mai stato poeta”.
Nel 2004 è poi la volta di “Mardeisargassi”, a cui basta un testo come “Cambiare casa” (più sotto lo si può leggere nella selezione dei suoi testi che proponiamo) per essere un libro di riferimento, poesia che si fa manifesto di un desiderio di andare incontro agli accadimenti, di non accettare i canoni, sempre più banali e omologati, di una società in difficoltà. È l’invito ad abbandonare ogni riparo solo apparentemente sicuro e confortante. Tanto nella vita di ogni giorno, quanto nella scrittura poetica.
Un libro in cui Obit lavora anche, in modo attento e calibrato, sul concetto di identità: “Italiano – mi dicono./ E di là: sloveno”.
Il tempo è cosa preziosa, e Obit lo sottolinea anche con i tempi larghi che separano ogni sua pubblicazione. In questo c’è tutto il suo rispetto verso la poesia, che ha bisogno di spazio e pagina solo quando sente il suo tempo, quando la maturazione è avvenuta, quando il dire qualcosa è necessità.
Così solo nel 2010 arriva “Le parole nascono già sporche”, che già nel titolo contiene una intenzione di significato, un raccontare e un mostrare. E nella sua ricchezza, ampia di un respiro che coinvolge e convince, basta una frase soltanto per far eccellere tutto il libro: “Non calpestate l’erba – e nemmeno i poeti”.
Lo scrivere di Michele Obit nel suo muoversi negli anni è sempre più diventato un senso di appartenenza, a quella devozione che c’è nel sacro della parola poesia, che accade solo quando è capace di coniugarsi con la vita di ogni giorno, peso specifico che porta la (sua) poesia a farsi battito cardiaco e sguardo indispensabile.
Ulteriore testimonianza è “La balena e le foglie”, la sua raccolta più recente datata 2019 e vincitrice del Premio Internazionale “Rainer Maria Rilke”, in cui tutto il suo percorso è ulteriormente esplorato e arricchito.
Qui il nostro tempo è ritratto nella sua specificità, “Non ha icone questo lasciarsi andare/ a una deriva senza argini”, e nel poterlo affrontare, “Capire dove sta l’essenza assottiglia la vita/ ma rende meno barbaro il cuore”, individuando una sorgente a cui sempre fare riferimento, “riconoscere in una rosa/ la fedeltà alle stagioni e al rimpianto./ Non deve succedere nulla. È tutto già successo”.
Per poi sorprenderci in un semplice stupore, a cui sentirsi legati e devoti per sempre: “L’essere fiamma prima della scoperta del fuoco”.
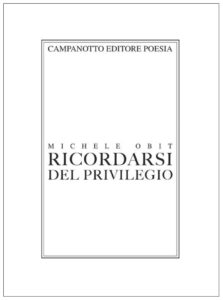
Dal libro:
Tisti večer
Takrat zvečer smo se dobili
v tistem samskem stanovanju
trije moški troje žensk ali
tako nekako
in smo si pravili svoje zgodbe
mladi bledični obsedeni
od en esame misli vedno
hiteti ne da bi kdaj
kam prispeli.
Ena sama vrata
so bila tam.
Vprašal sem če so to vrata
v stranišče.
Vstopil sem
pogledal sem se v zrcalu
opravil svoje stvari.
Povlekel sem vodo.
Ni šlo.
Tako nekako kot vse ostalo.
L’altra sera
Ci siamo trovati l’altra sera
in quel monolocale
tre donne tre uomini o
qualcosa del genere
a parlarci delle nostre cose
giovani spompati con in testa
solo la voglia matta di
correre e mai
arrivare.
C’era una porta
l’unica.
Ho chiesto se era la porta
del bagno.
Sono entrato
mi sono guardato allo specchio
ho fatto le mie cose.
Ho tirato l’acqua.
Non andava.
Un po’ come tutto.
da “Per certi versi – Po drugi strani”, 1995
*
Cambiare casa
Bisognerebbe sempre cambiare casa
anche quando non si è soli
e non stanchi
e si sta bene.
Bisognerebbe cambiare casa
sempre e portare con sé i quadri
la radio e le tende
cambiare casa perché è così che
si cambia
prendendo le poche armi e i tanti bagagli
andandosene
anche quando non si è soli
e non stanchi
e si pensa di star bene.
da “Mardeisargassi”, 2004
*
Ho un modo tutto mio per tenermi
in disparte. Mi costruisco un perimetro
di ricordi e da ogni angolo con una
diagonale seppellisco mentalmente
gli amici che non ci sono più
le bottiglie vuote – i lampioni carichi
di mosche – la dedizione dei colpi
a una porta chiusa.
Con una certa necessità di lentezza
ripercorro i corridoi degli aeroporti
il clima clandestino dei miei primi
versi – i fiumi che tracimano senza bagnare.
Me ne sto in disparte stando
al centro – come preso tra un’insoluta presenza
e una ragionevole non esistenza.
Come qui – in questo momento.
Ho una mano sulla vostra spalla
e vi sto sussurrando queste parole.
da “La balena e le foglie”, 2019
*
Ricordarsi del privilegio
Di essere stato molto più
dell’equivoco di un pensiero
di essere nato in autunno
le prime ore di un giorno ventoso
di aver incontrato Kafka
tra i canali e le edicole di Venezia
di aver imparato a scrivere
mentre i compagni giocavano a biglie
di essere stato zattera e approdo
almeno per le poche persone che ho amato
di aver visto ombre di alberi secolari
inchinarsi al passo di un bambino
di aver pensato spesso alla Mesopotamia
quando le scarpe si riempivano di sabbia
di aver creduto in un dolore più tenue
e nelle ore immutabili dell’attesa
di averti avuta sempre accanto
sola nella latitudine dei miei ricordi.
inedita

Intervista a Michele Obit:
Com’è nato “Ricordarsi del privilegio”? E come si è costruito il libro?
Non avevo nemmeno lontanamente in progetto di pubblicare un libro. È successo che ho incontrato in qualche occasione Carlo Marcello Conti, che vuol dire Campanotto editore, che mi ha ogni volta ripetuto il suo desiderio di pubblicare un mio libro.
A me piacciono molto le sue edizioni, proprio come oggetto. Ho pensato che, non avendo poesie sufficienti per una raccolta (anzi, ne avevo pochissime) poteva essere l’occasione per riunire in un unico libro qualcosa di quanto avevo pubblicato in passato, aggiungendo alla fine alcuni inediti.
Fare un’antologia del proprio percorso d’autore è certamente qualcosa di significativo ed importante. Cosa vuol dire per te?
Certamente fare i conti che il proprio passato, rivedere un percorso che all’inizio – almeno oggi lo vedo così – forse era ingenuo, ma che aveva (credo) una sua coerenza determinata dal fatto che per me la poesia ha sempre significato comunicare, e quindi, molto semplicemente, in tutti questi anni ho provato a raccontare, a spiegare il mondo che mi circondava, quello vicino e quello lontano.
Il tuo primo libro di poesia, “Notte delle radici”, è uscito nel 1988. Cosa è rimasto di quel tuo primo fare poesia? Cosa ritrovi ancora nelle poesie che scrivi oggi?
Non ho memoria di quando ho scritto quel libro. Mi sono ritrovato tra le mani un fascio di fogli dattiloscritti che mi pareva fossero poesia, vista oggi, come dicevo, di un’ingenuità (bella) che si può avere solo attorno ai vent’anni. C’era in ogni caso già nel titolo una parola, radici, che mi avrebbe poi accompagnato anche nella vita e nella scrittura successiva.
Nel corso degli anni il territorio sempre di più ha trovato spazio e voce nella tua poesia. Quale la sua importanza e il suo significato?
Se intendi le Valli del Natisone, è stata per me una realtà fondamentale, anche per la mia scrittura. Ho cercato anche di raccontarla, questa realtà, cosa non facile perché è complessa. E con l’andare del tempo mi sono reso conto che quel territorio mi stava stretto.
Oggi con esso ho un rapporto che in qualche modo si può definire di amore e odio. O forse di amore e rabbia. Perché è un territorio che ha avuto delle grandissime opportunità e non le ha sapute sfruttare. Qui parlo da osservatore e in fondo da giornalista, più che da poeta.
Sì, perché in questo caso territorio significa proprio Valli del Natisone, luogo di confine e di frontiera, di cultura italiana e cultura slovena. Luogo d’incontro ma anche, a suo tempo, di attrito. Cosa ti ha dato di così particolare questa realtà?
Il mio rapporto con il confine è stato particolare. Fino a che non ho iniziato a lavorare per il settimanale Novi Matajur era come se per me non esistesse, nel senso che non avevo cognizione del fatto che esistesse un ‘di qua’ e un ‘di là’. Non mi ponevo il problema di cosa fosse, quel confine.
Poi ho iniziato a conoscerlo, a conoscere la storia, i traumi che ha causato, perché solo chi ha vissuto in quelle zone la Guerra Freddda sa cosa ha significato. Ma per me è rimasto sempre una linea immaginaria, qualcosa che non limita ma anzi ti offre la possibilità di guardare oltre, e conoscere quell’oltre.
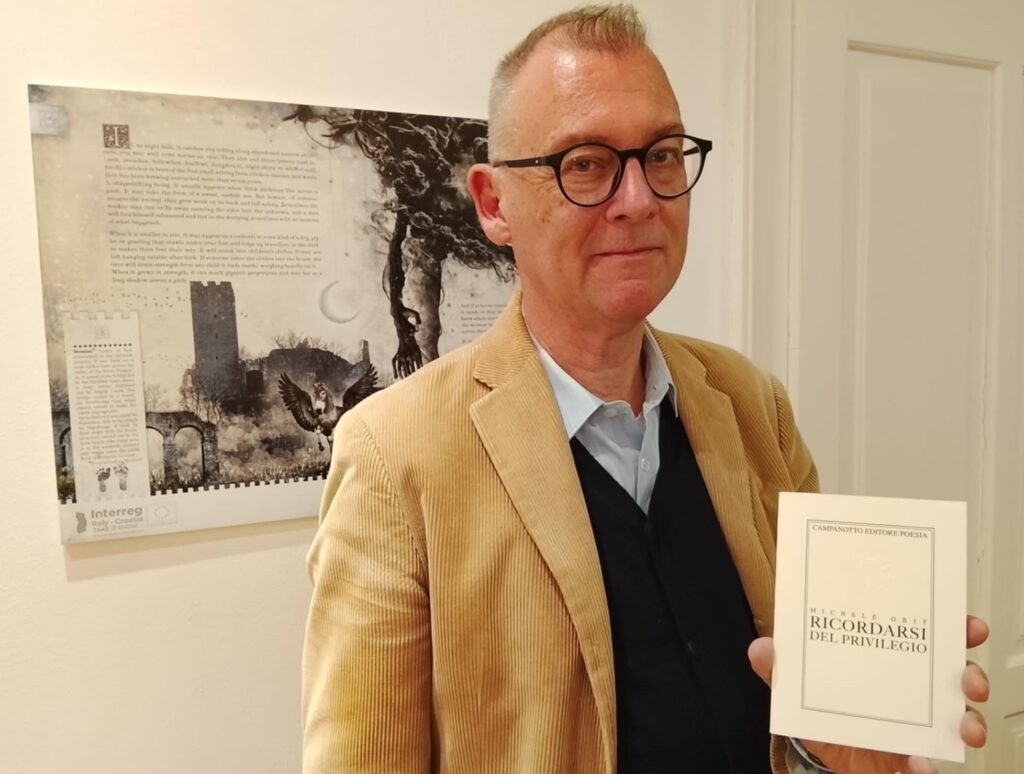
Nel tempo sei diventano anche traduttore dallo sloveno, portando in Italia la scrittura di autori e poeti importanti. Il tuo impegno di traduttore come ha influenzato, se lo ha fatto, il tuo scrivere poesia?
Se lo ha fatto è stato in maniera inconscia, come per molte delle letterature che leggo. Riguardo il lavoro di traduzione ci tengo a dire che la pubblicazione di libri tradotti dallo sloveno non avrebbe per me un grande significato se non fosse accompagnata dalla possibilità di conoscere personalmente una gran parte degli autori/autrici sloveni (in alcuni casi di diventare loro amico) e di permettere ad altri che li conoscano. Questo per me vale più di qualsiasi libro tradotto.
E il tuo essere giornalista? Ha in qualche modo influito nel formare la tua dimensione poetica?
Ha influito togliendomi tempo (anche) alla mia scrittura, ma d’altra parte di qualcosa bisogna pur vivere, e insegnandomi la necessità dell’essenziale, della sottrazione, del limite nella scrittura, perché ovviamente chi scrive articoli ha uno spazio determinato da riempire oltre il quale non può andare.
Per tanti anni hai curato “Voci dalla Sala d’Aspetto”, lo spazio che il festival “Stazione di Topolò – Postaja Topolove” ha dedicato alla poesia. Che esperienza è stata? Cosa ti ha permesso di creare e di percepire, nell’ambito della poesia contemporanea, ma non solo?
È stata uno sguardo privilegiato che mi ha permesso di conoscere la poesia, italiana, slovena e non solo. Dal primo anno, era il 1996, per oltre vent’anni (anche con la residenza artistica Koderjana) ho sempre voluto ci fosse presente almeno un autore sloveno, per dare la possibilità al pubblico italiano di conoscere quella letteratura. Ma ci sono stati altri incontri importanti, penso a Leonardo Zanier, Franco Loi, Jack Hirschman, Pierluigi Cappello, a tanti altri.
I tuoi libri hanno sempre contenuto una riflessione sulle parole e sul loro uso, basta pensare al titolo emblematico della raccolta del 2010, “Le parole nascono già sporche”. E oggi, come stanno le parole?
Male, direi. Mi viene da dire che ci salvano i silenzi, quando ci sono. Ma troppo spesso invece siamo sommersi da parole che dicono tutto e il contrario di tutto, che sono calpestate, denigrate, e la deriva populista in cui sta andando il mondo da una parte, e l’uso scriteriato dei social dall’altra, non aiutano. Come diceva Nanni Moretti in un film, le parole invece sono importanti. Deve essere per questo che ne uso poche, sia nella poesia che nel dire quotidiano.
Fra una raccolta e l’altra hai sempre fatto trascorrere un tempo significativo, quattro cinque anni. A cosa è dovuto questo lasso di tempo così ampio? Soprattutto in una società come la nostra che, ormai da decenni, è diventata bulimica nella produzione letteraria….
Di anni tra una raccolta e l’altra ne sono passati anche dieci. Sono sempre stato lento nello scrivere poesia, perché tendo a soppesare, prima di ogni parola scritta, ogni pensiero. Non è che mi sforzo di farlo, è che mi viene così. Credo sia anche perché mi sembra importante rispettare il lettore, non dargli in pasto qualsiasi cosa.
“Ricordarsi del privilegio” ha anche una sezione che contiene cinque inediti. Il tuo scrivere odierno cosa sta affrontando, in cosa è immerso?
“Ricordarsi del privilegio” è il titolo della prima poesia inedita e dell’antologia non a caso. Non voglio parlare di massimi sistemi, anche se penso dobbiamo considerarci, noi che viviamo in questa parte del mondo, grati del fatto che non andiamo ogni sera a dormire pensando che di notte può caderci una bomba in testa.
Pensò però soprattutto al privilegio dato dalle piccole cose quotidiane, da un gesto, da una parola, da uno sguardo. Quello che Wim Wenders ha raccontato così bene nel film “Perfect days”. Se non perfetti, i nostri giorni siano almeno qualcosa per cui vada la pena vivere, magari con un sorriso: di questo dobbiamo renderci conto, dobbiamo ricordarci.

L’autore:
Michele Obit (1966) ha pubblicato le raccolte poetiche “Notte delle radici” (1988, premio Lions club Milano), “Per certi versi / Po drugi strani” (1995), “Epifania del profondo / Epiphanie Der Tiefe” (Austria, 2001), “Leta na oknu” (2001), “Mardeisargassi” (2004), “Quiebra-Canto” (Colombia, 2004), “Le parole nascono già sporche” (2010), “Marginalia” (Slovenia, 2010)“La balena e le foglie” (2019, Premio Internazionale “Rainer Maria Rilke”) e la plaquette “Un uomo è anche un aratro” del 2015.
Ha tradotto in italiano e fatto pubblicare i principali poeti e scrittori sloveni, tra questi Srečko Kosovel, Boris Pahor, Miha Mazzini, Aleš Šteger, Bronja Žakelj, Primož Čučnik e Miljana Cunta.
È direttore responsabile del settimanale bilingue della minoranza slovena in Italia “Novi Matajur”. Ha curato la rassegna “Voci dalla Sala d’Aspetto” al festival “Stazione di Topolò – Postaja Topolove”, e il relativo progetto di residenza per scrittori e poeti “Koderjana”.
Attualmente cura la rassegna di incontri con l’autore “Drugi glasovi Altre voci”, a San Pietro al Natisone (Ud).
(Michele Obit “Ricordarsi del privilegio” pp. 67, 13 euro, Campanotto editore2025)
Immagini —————–
L’ultimo gioco
di Salvatore Bossone
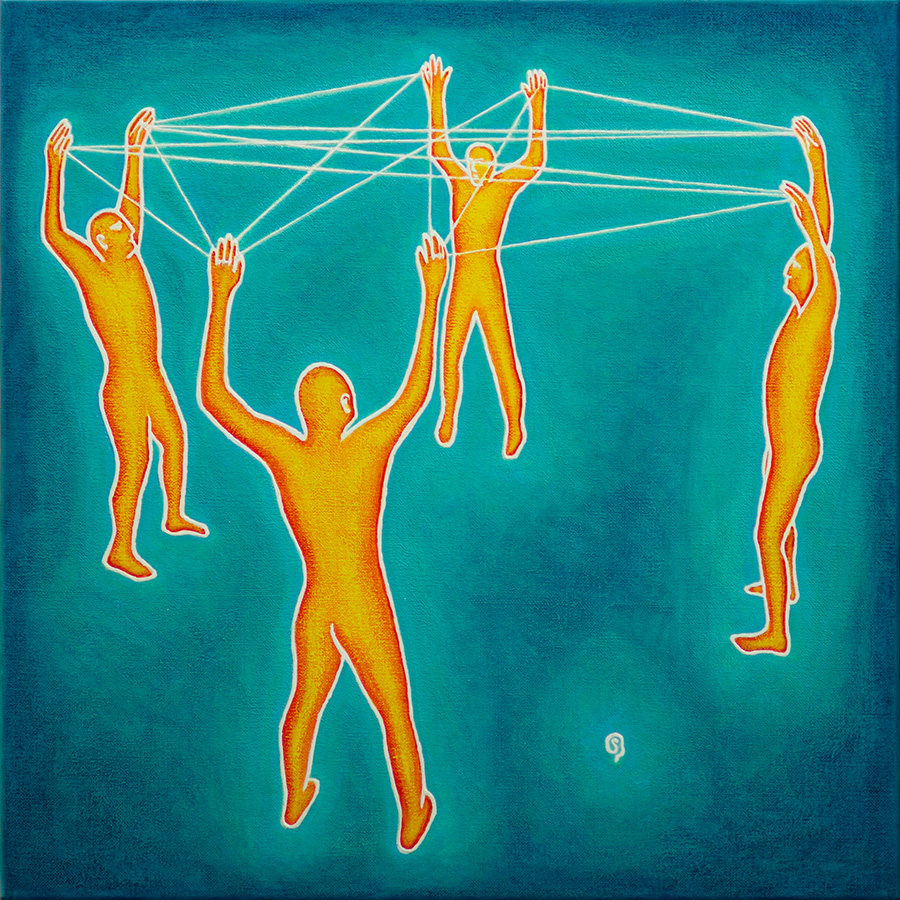
Tempo presente ——————
That world was enough, you say Quel mondo era abbastanza, dici
Cinque testi inediti in italiano
di Caroline Clark

Tonight Moscow
When your streets are beyond
the touch of sun
and darkness gulfs your greying gullies
let your rooftops flare red
flank by flank
each stand of white
from shadow streets to desert fire,
your heights to where the railway track
cuts through a depth now filled with light,
one second acres wide
set with stones of paradise –
Moscow flare red
tonight.
Mosca stasera
Quando le tue strade sono al di là
del tocco del sole
e l’oscurità inghiotte i tuoi gabbiani che si fanno grigi,
lascia che le punte dei tuoi tetti si infiammino di rosso
fianco a fianco
ogni fila di bianco
dalle ombre della strada al fuoco del deserto,
le tue cime verso dove il binario della ferrovia
taglia una profondità riempita adesso di luce,
in un secondo grandi acri
fissati con pietre di paradiso –
Mosca infiammati di rosso,
stasera.
*
Tell me,
I say, the sounds
you used to love. But before
you can, I give mine.
The slanting rain on wild black nights,
me inside below it dry.
The heating coming on,
its clicking comfort
promising maybe a frost, maybe snow,
maybe that the world will be changed.
For you,
a summer evening,
the kind you used to get.
The balcony door open
and Dad watching football inside.
Sounds mix,
the distant cries of kids,
the late light evenings carrying over
in their shouts.
That world was enough, you say.
Dimmi,
Pronuncio, i suoni
che eri solito amare. Ma prima
che tu possa, consegno i miei.
La pioggia obliqua sulle notti scure e selvagge,
io mi asciugo in lei.
Il calore sta arrivando,
fa nascere il benessere
forse promette gelo, forse neve,
o forse che il mondo verrà cambiato.
Per te,
una sera d’estate,
il genere che solitamente volevi.
La porta del terrazzo aperta
e dentro papà che guarda il calcio.
Un incrocio di suoni,
le grida lontane dei ragazzi,
la tarda luce della sera si allunga
nelle loro urla.
Quel mondo era abbastanza, dici.
*
The Myth of the Nightingale
Arrowshadowed I wait at the city’s core,
earthbound in dust. First murmurs an underground
stream, gurgling audible waterways, sound
becoming beaded globes propelled through narrow
canals. When away is all I know – now break
these ambersounded notes. All of me is burgeoning
to burst these boulders, pebbles and stones and over-
flow, flower into the kerbside world.
All that you hear is real. May you be blessed
in strangeness, loved in newness. I’ll shake you loose
a summer storm against the background roar.
Through jasmine and lime, I’ll sing you to my source.
Let there be flowers in the sand, lilacs in the streets.
I can make more life, more life than the sun.
Il Mito dell’Usignolo
Adombrato dalle frecce attendo nel cuore della città,
in polvere legato alla terra. I primi sussurri un flusso
sotterraneo, gorgogliano gli udibili corsi d’acqua, suono
che diviene globi di perle sospinti attraverso stretti
canali. Quando via è tutto quello che so – ora rompo
queste note dal suono d’ambra. Tutto di me sta germogliando
per scoppiare questi massi, ciottoli e pietre stra-
ripamento, fiore nel mondo da marciapiede.
Tutto quello che senti è reale. Possa tu essere benedetto
nella estraneità, amato nella novità. Ti scatenerò
una tempesta estiva contro il ruggito in sottofondo
Attraverso il gelsomino e il tiglio, ti condurrò cantando alla mia fonte
Lascia che ci siano i fiori nella sabbia, lillà nelle strade.
Posso creare più vita, più vita del sole.

Saying Yes in Russian
Place the tip of your tongue
against the roof of your mouth
pressing the point just behind your teeth.
Push up, jaw tough, eyes hard.
Make as if to say no, nyet,
think of the negative n of never, at least, not yet.
In this position and state of mind,
swiftly release the tongue forward and down;
you must surprise it, yourself and the one who asked.
Then turn that heavy knock of a n
into the delicate etiquette of da.
Dire sì in russo
Metti la punta della lingua
contro il palato della bocca
spingi il punto proprio dietro ai denti.
Solleva, mascella ferma, occhi duri.
Fai come per dire no, nyet,
pensa alla n negativa di un “non più”.
In questa posizione e stato mentale,
rilascia velocemente la lingua avanti e in basso;
ti devi sorprendere, tu e colui che te l’ha chiesto.
Poi rovescia il pesante colpo di una n
nella etichetta delicata di un da.
*
Italian Lessons
One year, her last good one,
she wrote out all the verb endings
on a sheet of paper and gave it to me.
Is this all I need to know?
-are, -ere, -ire, -ato, -uto, -ito.
Then she went downhill.
We’d sit in front of her heater
repeating the present perfect.
Now I know the future.
Lezioni di italiano
Un anno, il suo ultimo buono,
lei scrisse tutte le finali dei verbi
su un foglio di carta e me lo diede.
Questo è tutto quello che ho bisogno di sapere?
-are, -ere, -ire, -ato, -uto, -ito.
Poi si aggravò.
Sedevamo di fronte al suo termosifone,
ripetendo il passato prossimo.
Ora io conosco il futuro.
(I testi di Caroline Clark sono tradotti in italiano da Laura Corraducci)

L’autrice:
Caroline Clark ha pubblicato tre libri: “Saying Yest In Russian” (Agenda Editions, 2012); “Sovietica” (2021) e “Own Sweet Time” (2022) entrambi con CB Edition.
Ha tradotto il saggio che dà il titolo alla raccolta di opere della poetessa russa Olga Sedakova, “In Praise of Poetry“, pubblicata da Open Letter Books nel 2015.Ha pubblicato di recente sul sito Fictionable.
Nel 2026 Black Herald Press pubblicherà il suo prossimo libro, “What Lies Ahead and Other Essays”.
Vive a Lewes in Inghilterra e lavora come interprete di comunità per russofoni.

La traduttrice:
Laura Corraducci è nata a Pesaro nel 1974 è insegnante di inglese.
Organizza con il Comune della sua città la rassegna poetica “Vaghe stelle dell’Orsa” sulla poesia italiana e straniera.
Ha pubblicato la raccolta di poesie “Lux Renova” nel 2007 con Edizione Del Leone, “Il Canto di Cecilia e altre poesie” nel 2015 con Raffaelli editore e “Il passo dell’obbedienza” con “Moretti e Vitali nel 2020.
Ha scritto e portato in scena diversi recital letterari, l’ultimo “Orgoglio e Pregiudizio” riadattamento a due voci del celebre romanzo di Jane Austen.
Ha tradotto il libro “Saying Yes in Russian” (Dire sì in russo) di Caroline Clark, poesie del poeta americano Bill Wolak, della poetessa turca Muesser Yehniay e del poeta indiano Sonnet Mondal apparsi in blog e antologie letterarie.
Immagini —————–
Siamo veniamo andiamo
di Salvatore Bossone

Voce d’autore ———————–
La rinuncia del fiore più alto
Isabella Leardini, “Maniere nere”
di Roberto Lamantea

È un libro di evanescenze, trasparenze, ali d’acqua e aria “Maniere nere” di Isabella Leardini, appena pubblicato nello “Specchio” Mondadori, forse il libro di poesia più bello del 2025. Sono parole sospese sull’aria, dove i bambini “guardano stupiti i non più vivi”, gli ungebornen, i “non nati” di Georg Trakl, il poeta austriaco di stagni azzurri e rossi boschi autunnali morto nel 1914 a 27 anni. Sono poesie dove nell’erba “dorme improvvisa la paura“, i morti amano i vivi e giocano con le perle nella luce dell’erba. Poesie-fiaba: “l’albero dell’aria non mette fiore/ rossi petali senza colore”. Creature indefinite chiedono di fiorire, “mani di piume, dita di corallo/ abbiamo un vestito di conchiglie vuote”. Poesie d’acqua e fiori.
“Maniere nere” – “maniera nera è una tecnica d’incisione in cui l’immagine emerge da un opaco fondo scuro, come luce che filtra attraverso il buio” spiega l’autrice nelle note – è un libro incantato e misterioso, un libro magico di bambini come ombre nel bosco, perle, stelle marine, alghe, fiori d’aria e d’acqua, coleotteri, conchiglie, alghe. Si potrebbe abbondare con le citazioni per una poesia così colta, ma è amore quello che traluce da queste pagine, non rinvii eruditi e civettuoli, l’amore dei versi – dei libri – è respiro, non abito di filologi: Emily Dickinson, Virginia Woolf (citata in una sequenza dedicata alle scrittrici suicide accanto a Mariangela Sears, Antonia Pozzi, Sylvia Plath).
Una recensione molto bella su laltroveappuntidipoesia cita Valéry per il simbolismo acquatico, Paul Celan, e concorda sulla Dickinson: “L’elemento acquatico attraversa l’intera raccolta non come semplice motivo tematico ma come vera e propria categoria ontologica. “A lungo siamo stati nel battito/ di un’acqua che non era vera onda”: l’acqua amniotica, l’acqua della memoria prenatale, l’acqua come dimensione originaria a cui è possibile tornare. Ma è anche l’acqua della morte, della dissoluzione, del farsi informe” (ed ecco Trakl); inoltre Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Maria Luisa Spaziani.

Traspaiono anche echi di Pascoli: alcuni testi di “Maniere nere” confinano con la filastrocca anche in metrica e rime e per l’uso “litanico, quasi incantatorio” dell’anafora.
La scrittura danza tra veglia e sogno, un velo delicato è forse un confine, un altro spazio dell’aria, una soglia intermedia tra qui e l’altrove. Anche i bambini sono trasparenze, come è un velo la memoria dell’infanzia, l’acquarello di una fiaba, le ali di una fata-libellula: “la poeta costruisce una vera e propria fenomenologia dell’incompiuto […] Questi “perduti vivi nell’enigma” non abitano il regno dei morti ma uno spazio intermedio, una soglia perennemente oscillante” (sempre in laltrove) e la soglia (Schwelle) è uno dei temi simbolo di Celan già nel titolo della raccolta del 1955 “Di soglia in soglia”.
Eppure è anche altro la poesia di Isabella Leardini: “Vengo dalle assi in cui germoglia/ nell’acqua al buio questo strano fiore/ frutto di stiva che natura affonda/ e rinasce fenice neve”. È una poetica della trasformazione: come le ali delle libellule, che sono quelle delle fate, e la loro trasparenza permette un altro sguardo sul mondo. È la metamorfosi delle forme al confine tra luce e buio, dove tutto è possibile, la fiaba come la coscienza.
“Maniere nere” è articolato in sette sezioni: Maniere nere, Danza delle conchiglie, I subacquei, Le alghe, Al buio dell’ala, La fortuna e l’epilogo La giustizia della neve, e nasce da una lunga gestazione, tre libri di poesia in vent’anni, dopo “La coinquilina scalza” (Niebo/La Vita Felice 2004), “Una stagione d’aria” (Donzelli 2017) e il saggio “Domare il drago. Laboratorio di poesia per dare forma alle emozioni nascoste” (Mondadori 2018): l’autrice guida workshop e laboratori di poesia in tutta Italia e insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
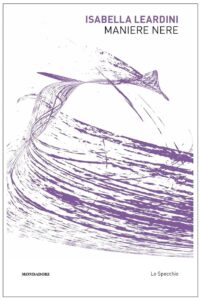
Dal libro:
L’albero dei morti bambini
più splendente fiorisce ogni mese
frutto di interminabile sete
germogliare ostinato dell’amore.
Gioco che gira incantato
dove la vita sconosciuta esiste
spietata infanzia dei non vissuti
che guardano stupiti i non più vivi.
A un battito dalle mani
che non arrivano a toccare le mani
a un passo dalla polvere dei piedi
che battono lo spazio delle stanze
dietro gli stipiti aperti delle porte
indisturbati si stendono i rami.
*
Luce definitiva nell’erba
dove dorme improvvisa la paura
vento invisibile di ogni trasalire.
Anime risollevate, i morti
non si innamorano ma amano i vivi
giocano tra le dita piccole perle
ogni tanto le fanno cadere.
*
Stella che nel mare nuota
ma toccando la spiaggia si addormenta.
Stella marina primo fiore d’abisso
che le bambine accudiscono in segreto
come fanno con le cose degli altri.
In segreto si accrescono i figli
quando staccano dal ramo le mani.
*
Non è spazio a cui appartenere
la rinuncia del fiore più alto.
Rinuncia stellata di magnolia
è fiorire soltanto per il cielo,
rinunciare a fiorire prima ancora
di sapere che non si potrà fiorire.
*
Fiore della mia fronte
bianco di disperazione
unica possibile fioritura
che nel mio corpo mette radice.
Felice è chi riesce a fare fiore
con in mano il bulbo chiuso del destino
noi povere miracolanti in fila
chiediamo in che modo fiorire.
*
Per essere felici servono:
un cane che dorme felice
un uomo, anche se triste
poeti che scintillano lontani
che toccano ingenui la morte
e restano convinti che sia il mare.

Intervista a Isabella Leardini:
Molte immagini di “Maniere nere” ricordano figure dell’immaginario tra fiaba e natura, ricorrono immagini di fiori, insetti, pietre, trasparenze, sogni…
“Maniere nere” ha un tema molto preciso: la generatività e il suo rovescio, inteso come non generatività ma anche come pulsione di morte, suicidio. A queste due note di fondo si annodano cinque fili, uno di essi ha a che fare con l’invisibile: i morti e i bambini non nati sono i protagonisti del libro, coabitano le nostre stanze in un altrove-accanto che si apre sul confine delle porte. “Loro” è la persona plurale ricorrente di questo libro.
Il secondo filo è la natura come spazio simbolico del sommerso, la conchiglia come esoscheletro, la madreperla come immagine della poesia, il mare guardato come fondale-destinazione o come riva intesa come limite, spazio che ha comunque a che fare con la morte; poi l’erba come soglia, accesso al mondo
sotterraneo con il suo popolo di insetti mediatori. Il simbolo più ricorrente è il fiore, generativo ma anche metapoetico: i fiori subacquei diventano terrestri, mistero creativo e mostruoso prodigio, come la rosa stabilizzata che è metafora della scrittura.
Il terzo filo è proprio la poesia stessa, i poeti, il fraintendimento. Il quarto riguarda il femminile e le donne che hanno scritto, volutamente e come atto politico ho insistito sui simboli di una tradizione di cui faccio parte. L’ultimo filo è l’infanzia, la sua metamorfosi ferita: i ragazzini e le ragazzine che appaiono nel libro sono volti incontrati nei miei laboratori.
Anche se questo libro è stato scritto sulla soglia del sonno, in una sottrazione di coscienza, parlerei di visioni più che di sogni, il sogno è materia di scarto del quotidiano, la visione è vista altra. Per visioni e per simboli ha preso forma qualcosa che non poteva essere detto altrimenti, ma il modo in cui i simboli si sono presentati, come nel procedimento metaforico e anche nella fiaba, li pone nel testo come reali.
Leggendo i suoi versi vengono in mente Emily Dickinson, Georg Trakl, Antonia Pozzi (che cita): quali sono i suoi amori letterari, quelli che le fanno “battere forte il cuore”?
Forse non è un battere del cuore quello che cerco dalla poesia, piuttosto un battere della mente credo, e un battito – questo sì – del ritmo come ascesa o discesa. Se devo fare una genealogia Dante deve essere il primo che nomino, poi Emily Dickinson che per me gli siede accanto.
Da bambina sono stata ossessionata da Pascoli, credo che ci sia moltissimo di lui nei fantasmi e nella musica di questo libro. Da adolescente ho amato Baudelaire e Pavese, da ragazza Sereni e Achmatova, crescendo Rilke.
Wislawa Szymborska da alcuni anni mi accompagna quotidianamente, vive con me si potrebbe dire, e penso sia la presenza segreta di questo libro. Credo che ci siano due correnti contrastanti che vengono in superficie o in sottofondo in “Maniere nere”, una funzione Plath e una funzione Szymborska.
Poi ci sono due custodi, Piero Bigongiari e Margherita Guidacci, che apre e chiude il libro. Mentre ero immersa nella sua opera ho iniziato a scriverlo in misterioso rapporto con la sua voce, lei era una rabdomante e ha trovato l’acqua anche in me.
Antonia Pozzi è presente nel libro come figura, ma voglio citare anche Maria Luisa Spaziani e più in generale le autrici italiane del Novecento che ho antologizzato in “Costellazione parallela”, gran parte del libro l’ho scritto mentre lavoravo a quella antologia, immersa nel mare dei loro simboli.
Ci sono poi due libri di autori contemporanei che ho letto nel periodo precedente alla scrittura del libro e che credo abbiano lavorato in me, “Linea intera, linea spezzata” di Milo De Angelis e “Historiae” di Antonella Anedda. Questi due libri hanno inciso sulle ossessioni e i simboli che sono riemersi in “Maniere nere”.
Sono state importanti anche le voci di alcuni autori giovani a me vicini, credo che in poesia il rapporto con i figli e le figlie sia importante quanto quello con i padri e le madri.

“Maniere nere” è il suo terzo libro di poesia in vent’anni, dopo “La coinquilina scalza” (2004) e “Una stagione d’aria” (2017). Ogni libro ha un’architettura, un percorso, sezioni diverse: qual è il suo metodo di lavoro?
Il metodo è stare alla regola dell’opera che di volta in volta può cambiare tutte le regole. Mi sembra che il compito sia avere il coraggio di intercettare il libro appena prima che arrivi, iniziare a desiderarlo, e poi lasciare che conduca il gioco. Io credo che si debba arrivare almeno a metà per vedere ciò che si sta scrivendo, ma a quel punto bisogna saperlo riconoscere e conoscere.
Per “La coinquilina scalza” sono stati la voce e il tema a trainarmi, avevo vent’anni ed ero ossessionata dalla sincerità e dal congegno: un canzoniere d’amore come un romanzo stilizzato, capace di narrare con la sola trama dello scarto. Quattro sezioni di dodici poesie in ordine cronologico quasi fedele, scritte in quattro anni. Di quel libro sentivo il ritmo stabile, la regolarità della formazione. Dopo l’uscita della Coinquilina scalza ho scritto pochissimo, è iniziata la mia intermittenza.
“Una stagione d’aria” è un libro scandito dai vuoti; mi ha dettato la regola del silenzio, è il libro dei trent’anni, della sospensione. Nel 2011 era finito, ma aspettavo l’editore giusto ed è uscito nel 2017. Trattenere “Una stagione d’aria” ha bloccato qualcosa e compromesso l’esistenza di un libro che non ho scritto: “L’anello”.
Le poesie de “La Coinquilina scalza” avevano avuto molte stesure fino a una forma che si sarebbe poi fissata senza ripensamenti. Le poesie di “Una stagione d’aria” le ho sempre pensate come tuberi, cresciute sottoterra nei periodi di silenzio che duravano molti mesi, estratte già formate, tutte insieme, sezione per sezione. Un giorno al massimo ed erano finite. L’errore è stato ritoccarle all’ultimo momento, se potrò torneranno nella versione originale.
Scrivere “Domare il drago” è stato fondamentale per la conoscenza del mio processo creativo, non è un libro di poesia ma è scritto poeticamente. Dopo quel libro sapevo che non avrei più potuto scrivere poesia come prima, non avevo più scritto, se non una manciata di poesie in quattro anni, su commissione, come se la poesia potesse arrivare soltanto invitata. Sono le poesie che ora chiudono il libro come antefatto e incredibilmente ne prevedono i simboli.
Dopo altri due anni di silenzio, nella primavera del 2021 mi si sono presentati due versi, ho scritto la poesia che apre il libro e che ancora resta per me un mistero. Da quella notte ho scritto ogni notte per sei mesi, sulla soglia del sonno.
La mattina seguente aprivo il quaderno, decifravo la mia scrittura con timore e sorpresa. La felicità di scrivere superava il rischio di quello che prendeva forma, tutte le poesie parlavano di morte, ero disposta a guardare pur di scriverle. Non lo avevo detto a nessuno, temevo che mi sarei fermata, era un segreto come lo era stato all’inizio, scrivevo libera da me stessa.
Dopo averne scritte circa quaranta ho capito ciò che stavo scrivendo, ho iniziato a trascriverle in un file e ho deciso di scrivere “Le alghe” e il poemetto sulle ragazze suicide, ma li ho scritti con lo stesso procedimento. Per un attimo ho creduto di aver trovato la chiave del gioco.
Il lavoro sui testi di “Maniere nere” è stato in sottrazione: sottrazione di coscienza, sottrazione di qualche verso appena. Se le poesie di questo libro hanno una così fitta trama di allitterazioni, novenari ed endecasillabi è proprio perché il procedimento di scrittura ha agito sugli aspetti più istintuali del linguaggio poetico, la musicalità e la metafora.
Anche il fatto che ogni giorno io conduca laboratori di poesia credo abbia inciso sulla mia scrittura, trasformando il lavoro sul testo in qualcosa di preconscio; la poesia in fondo è un’intonazione, un’accordatura. Sentivo in quelle poesie una dimensione quasi medianica che non doveva essere toccata troppo e il grande lavoro di questo libro è stata la struttura: per due anni ho lavorato soltanto a quella.
I testi non sono nell’ordine in cui sono stati scritti, i fili erano tutti ingarbugliati, il mio compito è stato dipanarli, la maniera è stata portarli in primo piano perché potessero narrare in altro modo.
A differenza dei miei libri precedenti “Maniere nere” non è narrativo, lavora per nuclei simbolici e ogni sezione è un capitolo quasi poematico annodato agli altri. Dopo due anni di silenzio ho scritto la sezione “La fortuna”, l’unica che rispetta un ordine cronologico dei testi.
Il procedimento di “Maniere nere” io lo vedo come una mano che lavora nel buio, senza vedere la materia che tocca, a cui si affida tanto quanto la domina.
Scrive a penna, allo smartphone, al computer? La tecnologia è “nemica” della poesia o è solo un altro strumento? Leggo che alcuni autori per scrivere ricorrono anche all’intelligenza artificiale: che cosa ne pensa?
Ho iniziato “La coinquilina scalza” su una macchina da scrivere e l’ho finita al pc, è davvero un libro sul confine del secolo. “Una stagione d’aria” l’ho scritto interamente al computer, le ultime poesie forse sul telefono.
Sono disgrafica e per molto tempo la scrittura a mano era diventata dolorosa e indecifrabile.
Negli ultimi anni ho avuto l’esigenza di scrivere a mano, ho ricominciato a farlo e fin dalle prime poesie di “Maniere nere”, scritte su foglietti e poi numerate su un quaderno, mi sono accorta che è un canale più diretto all’inconscio e alla scrittura di soglia.
Tutto questo libro è scritto su tre quaderni e credo sia prezioso averne tutti gli autografi, a futura riprova di ciò che ho raccontato.
L’intelligenza artificiale per ora è uno strumento, come ogni tecnologia decisiva, anche la scrittura e la stampa lo sono, cambierà le nostre menti e percezioni. Io ho sempre fiducia nel genio, vedremo se e come la userà.
(Le fotoritratto di Isabella Leardini sono di Valentina Solfrini)

L’autrice:
Isabella Leardini è nata a Rimini nel 1978. Ha pubblicato le raccolte di poesia “La coinquilina scalza” (Niebo/La Vita Felice 2004) e “Una stagione d’aria” (Donzelli 2017).
Insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da anni tiene workshop e laboratori di poesia in tutta Italia con il metodo da lei stessa ideato, oggetto del saggio “Domare il drago” (Mondadori 2018).
Dal 2022 dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna; cura inoltre le collane di poesia dell’editore Vallecchi, per cui ha pubblicato l’antologia “Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento” (2023).
(Isabella Leardini “Maniere nere” pp. 128, 18 euro, Mondadori “Lo Specchio” 2025)
Immagini —————–
Dimensioni parallele
di Salvatore Bossone
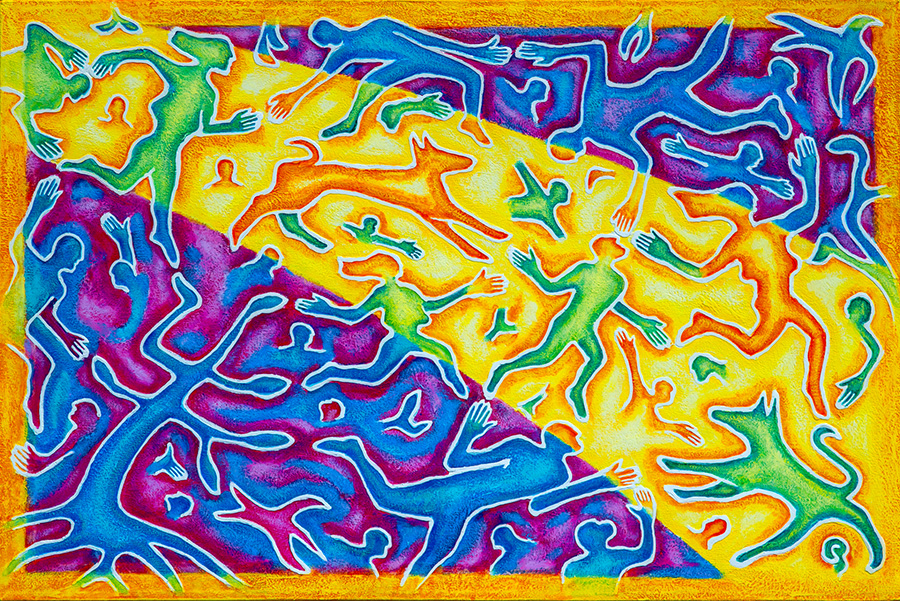
Voce d’autore ——–
A megghiu isca arresta u pani La migliore esca resta il pane
Saragei Antonini, “La volpe dell’insonnia: a spizzata”
di Giovanni Fierro

È sempre più interessante il mondo poetico di Saragei Antonini, luogo dove lingua italiana e dialetto sono creature che si incontrano, e in questo suo nuovo “La volpe dell’insonnia: a spizzata” sono anche capaci, nello stesso testo, di mescolarsi in un qualcosa di unico, di davvero raro.
Sorprende Saragei Antonini, perché già dalle prime pagine la sua scrittura trova una nuova lunghezza d’onda con cui esprimersi, ed in cui è veramente un grande piacere sintonizzarsi. Il verso si fa più largo che in passato, lo sguardo si muove con maggiore ampiezza, “vedere piano come un lume rimanere come una pagina e quando una porta si/ chiude male lasciarla così: col suo desiderio di soglia – la sorte è stare socchiusi”. E chi legge si trova in un paesaggio da esplorare, in cui immergersi, passo dopo passo.
La prima parte del libro, “la volpe dell’insonnia”, è tutto un accendersi di epifanie, svelamenti del quotidiano che hanno il profumo e l’odore della vita stessa: “mangi con la sinistra mangio con la destra ti metto ancora nella notte e nel giorno/ nel salto e al risveglio – c’è un verso su cui fare stare il pane e uno per soffiarci”, “mi dai un’arancia questo il peso del nostro silenzio io la spoglio della buccia”.
Questo per capire che Saragei Antonini ha imbastito anche un lavoro differente con il tempo, che adesso si fa anch’esso più ampio, capace così di permettere alla sua poesia di abbracciare ancora più cose, più contenuto, nel suo andare maggiormente in profondità.
Tanti sono i passaggi che meritano la citazione, vere e proprie istantanee che catturano e regalano qualcosa di speciale. Come “gli appunti dell’inverno la primavera che copia”, oppure “il dietro delle cose ora è davanti e i guanti sono monouso” o ancora “sì piango è il mio modo di guardare fuori quando apri piano la porta”. A cui aggiungere un vero e proprio ritratto, tratteggiato con segni universali: “mia madre ha sempre cercato la verità/ mio padre creava abiti su misura”. Perché bisogna sempre andare “a lezione di candela: imparare a stare nella bugia”.
Tanto è esposta e in rilievo questa prima parte del libro, scritta in italiano, quanto si fa invece più intima, raccolta e voce anche di uno smarrimento umano la seconda, “a spizzata”, scritta in dialetto.
Qui il respiro è trattenuto, il silenzio riempie le parole, ogni minuto accadimento è ancor più appartenenza personale. C’è il bisogno dell’orientamento, “ro tempu nun mi sacciu squaràri nenti/ è assai ca sacciu ri unni s’adduma a luci” (“del tempo non so immaginarmi niente/ è già abbastanza che so dove si accende la luce”) e il desiderio di uno spazio in più, non solo da guardare ma anche da respirare, “c’è na finestra ca nun si rapi cchiù/ è misa accussì àuta ca a talìu comu na luna china” (“c’è una finestra che non apre più/ è messa così in alto che la guardo come una luna piena”).
Le pagine de “a spizzata” hanno contorni meno rassicuranti, hanno bordi da cui è più pericoloso sporgersi, dove “u scuru mpasta/ u lustru acchiana/ appoi u Signuri fa i cunti” (“il buio impasta/ la luce sale/ poi il Signore fa i conti”) e in cui “vulissi u mari vicinu e ddì scogghi niuri cauri ri nfanzia” (“vorrei il mare vicino e quegli scogli neri caldi d’infanzia”).
Tutto questo libro è un attraversare il nostro presente, in una voce originale e capace di trovare l’autenticità e l’esperienza di ogni singolo momento.
Stare con la poesia di Saragei Antonini e nel suo scrivere di “La volpe dell’insonnia: a spizzata” è esperienza da fare, custodire e tramandare.
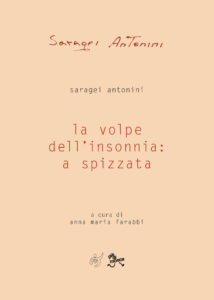
Dal libro:
a dire il nero diamo il tempo alla volpe dell’insonnia di sfamarsi e impaurirsi
della tua bianca gentilezza del lento rito dell’avvicinamento a dire ancora più nero
le prime lame del mattino e oltre la porta il bue a fissarti.
*
conserva i bottoni
sono le promesse più vicine al respiro
attraversati tante volte
quelli dei morti sono i più tondi
quando un bottone viene a mancare tu
mettili insieme come monete
che cambierai per un po’ di caldo nel freddo
per le loro confidenze a un filo di corpo
un bottone non va stretto
vive di una linea di cuore
l’asola che lo aspetta ad occhi chiusi.
*
cchì ricissi me’ matri
si m’attruvassi no’ funnu ra notti
a talìari i stiddi –
capaci ca
cchì ci fai ancura ccà luci addumata.
cosa direbbe mia madre
se mi trovasse nel fondo della notte
a guardar le stelle –
probabilmente
cosa fai ancora con la luce accesa.
*
ma u Signuri u pararisu
fini uri fallu?
nun sacciu ri unni si trasi
ma tu ci nesci sempri
ma il Signore il paradiso
ha finito di farlo?
non so da dove si entra
ma tu ci esci sempre
*
sunu catti r’amuri
ca nun tegnu cchiù ne’manu
na prumissa è cosa àuta
spiddu ca nun scanta
sono carte d’amore
che non tengo più nelle mani
una promessa è cosa alta
fantasma che non spaventa

Intervista a Saragei Antonini:
La sorpresa è vedere che le prime frasi del libro sono più lunghe che in passato, vedere che contengono più parole, che lo sguardo del loro significato si è fatto più ampio. E questo significa che c’è anche un lavoro con il tempo differente, che si fa anch’esso più ampio. È come se ci fosse stato il bisogno di una durata maggiore, per costruire queste poesie. Mi sbaglio?
Alcuni testi della raccolta hanno un cammino orizzontale e prima di tutto perché seguono la respirazione e il dire quelle parole con un tempo dell’orizzonte – ho scritto in passato con questa andatura – non so se questo riguarda il farsi del tempo più ampio e l’abbracciare più cose – forse questo è dato dalla parola – anche solo una – spero sempre che scrivere sia un andare in fondo che sia terra o cielo, e a volte anche in un dialogo tra sogno e veglia – qualcosa oltre lo scrivere.
Il quotidiano è sempre e comunque il luogo dell’accadere del tuo fare poesia. Per quale motivo?
Il quotidiano per me è osservare e ascoltare ogni giorno e ogni notte con tutto quello che portano e contengono o non contengono affatto – un’attenzione al tempo con riconoscenza.
“La volpe dell’insonnia”, la prima parte del libro, è anche un fiorire di complicità. C’è un continuo io + tu che è sempre nel centro dell’attenzione… ti ci ritrovi in questo?
Sì, nella prima parte del libro “La volpe dell’insonnia” ci sono testi più chiaramente amorosi – un dialogo tra un Tu e un Io – dichiarazioni, confidenze e, come hai notato tu, complicità.
L’immagine e la presenza del pane sono continue in queste pagine. Che significato ha per te?
Il pane è pane – antico – essenziale – è sacro per me: il tempo e la cura che occorrono per farlo – il tenerlo nelle mani – il poterlo condividere – da solo saprebbe bastare – è corpo e grazia.

La seconda parte, “A spizzata” – che è anche quella scritta in dialetto – si muove in altre dimensioni. Dal pane l’attenzione (e la presenza) si sposta alle stelle…. Cosa succede di diverso?
Nella seconda parte del libro “a spizzata” accade la spezzata, il lampo – accade il sentire di una lingua diversa e mescolata all’altra – uno sguardo al cielo per orientarsi e non rimanere solo terreni – accade il capovolgimento della clessidra.
Il dialetto è una strada più diretta e pietrosa al sangue – un canto biologico e forse la scaramanzia tra i morti e i vivi.
Nel tempo le due lingue, l’italiano e il dialetto, si sono naturalmente mescolate – così accade che pronuncio parole che sono l’unione di entrambe – ho scritto testi che avevano l’urgenza dell’una e dell’altra insieme come un dialogo tra loro e una complicità – un’intesa reciproca e sorgiva – forse anche questa è una relazione e che conduce a un’altra presenza: una terza lingua.
E qui c’è un senso di solitudine quasi, uno smarrimento che va e viene, ma che comunque dà sapore a questa parte del libro. Cosa l’uso del dialetto riesce a farti scoprire, che nella prima parte si nascondeva o celava?
Il senso di solitudine lo sento quando scrivo in dialetto e sia quando scrivo in italiano – e forse perché si scrive soli – per me si scrive ritirandosi – quello che scopro nel dialetto lo scopro anche nell’italiano quello che cambia sono i suoni e i tempi. Un esempio è la vecchia che legge il caffè in lingua nera: è la voce in alcuni testi in dialetto, ed è la voce degli antenati, non solo la mia.
In alcuni testi l’italiano e il dialetto condividono la pagina, si intersecano. Si cercano in una vicinanza importante. Da cosa nasce questa scelta di scrittura?
Le due lingue ora convivono e aggiungo in equilibrio – lavorano contemporaneamente a qualcosa che riguarda la parola la cellula (e dopo la cellula c’è altro) rispetto a qualcosa che non so ancora se più grande o quasi invisibile – è una dualità che guarda allo zero e lo zero è intero. La complessità è farlo, dunque esserci senza spezzarlo. Lo zero è essere nel mondo – è lo stare al mondo spogliandosi ogni volta di quello che si crede di sapere e di portare – non posso dire che è ricominciare né rinascere – ha a che fare forse con il proseguire più concentrati e anche più altrove se si guarda a quante “cose” esistono.

L’autrice:
Saragei Antonini è nata a Catania nel 1973, città dove vive. Nel 2000 pubblica la raccolta di poesie “Il cerino soggetto“ (1° premio ex aequo Edda Squassabia, prima edizione), nel 2004 “L’inverno apre un ombrello in casa” (3° premio ex aequo Città di Marineo 2005), nel 2010 “Sotto i capelli una nave” (3° premio Angelo Majorana 2013), nel 2013 “Egregio signor Tanto” (3° premio Pietro Mignosi X edizione; menzione d’onore al Premio Va Pensiero 2017 e al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 2017), nell’aprile 2017 pubblica “La passione secondo”.
In dialetto ha pubblicato le raccolte “A virina” (2019) e “A scala è fimmina” (2024).
Diverse le menzioni di merito e le segnalazioni in concorsi e premi. Nel 2018 con la poesia “U chiòvu” le viene assegnato il Premio Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata di Barcis – XXXI edizione.
Nella ventesima edizione del Concorso Guido Gozzano riceve il Premio Speciale Poesia Dialettale con la silloge in dialetto “Comu ‘na ugghia ̎. Sue poesie sono presenti in antologie e riviste in Italia e all’estero.
(Saragei Antonini “La volpe dell’insonnia: a spizzata” pp. 177, 12 euro, collana Arca curata da Anna Maria Farabbi, Al3viE – pièdimosca edizioni 2025)
Immagini —————–
Paradiso con démoni
di Salvatore Bossone

Testo unico ——————–
XCIII A une passante A una passante
di Charles Baudelaire

XCIII A une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston1 et l’ourlet;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?
Bien loin d’ici ! trop tard! jamais peut-être!
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!
(da “Les Fleurs du Mal”, 1857)
XCIII A una passante
Urlava attorno a me la via, senza pietà.
Alta, snella, in gramaglie, sovranamente triste,
con sontuosa mano sollevando le liste
dell’abito, guarnito di ondosi falbalà,
e con gamba di statua, passò una donna: vidi,
bevvi nell’occhio suo, con spasimi d’insano,
come in un cielo livido, gravido d’uragano,
dolcezze ammalianti e piaceri omicidi.
Fu un lampo… poi la notte. Fuggitiva beltà,
nel cui sguardo, all’istante, l’anima mia risorse,
non ti vedrò più dunque che nell’eternità?
Altrove, e via di qui! Troppo tardi! mai, forse!
Poiché corriamo entrambi a ignoto e opposto sito,
o tu che avrei amato, o tu che l’hai capito!
(Traduzione di Gesualdo Bufalino, in Charles Baudelaire “I fiori del male“, Mondadori 1983)
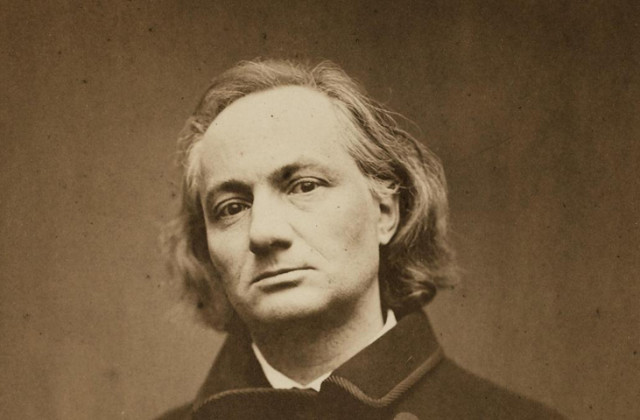
Una poesia di Baudelaire
di Giancarlo Sissa
Premetto che la poesia che più mi piace sono non meno di mille, dislocate e pulsanti lungo le età della mia vita come creature disobbedienti, voci d’eserciti in rotta, mamme che fanno la spesa, amanti che pedalano nella nebbia lungo l’argine del fiume, e che sono per me come la pioggia verso la sete, come la notte trascorsa sottovoce, come l’albero che resiste e testimonia. Quella che qui trascelgo dunque è semplicemente quella che mi ha convocato a una rilettura e a una coincidenza che racconterò fra poco.
“A una passante” è la poesia XCIII de “I fiori del male” di Charles-Pierre Baudelaire, pubblicata per la prima volta su “L’Artiste” il 15 ottobre 1860 è l’ottavo testo della sezione Tableaux parisiens (Quadri parigini) che ne contempla diciassette in totale. Va qui in scena un gesto quotidiano e infinito al tempo stesso, lo sguardo fra il poeta e una donna – la passante del titolo – che viene descritta, nella splendida traduzione di Gesualdo Bufalino, come “Alta, snella, in gramaglie, sovranamente triste” sicché non è difficile per noi vederla avanzare bellissima lungo la via nella raffinata eleganza del lutto, silenziosa e tuttavia sfuggente dominatrice d’anime e destini, in primis quello di Baudelaire, naturalmente, la cui anima non a caso si trova a risorgere nel nitore di tanta “Fuggitiva beltà”.
È un lampo, certo, un breve istante – forse capitato almeno una volta anche a ognuno di noi – nel quale bere dallo sguardo tutto il fascino ammaliante e tutto il pericolo insiti nella creaturalità femminile, ma è un lampo che apre ipotesi d’eternità, d’un “mai, forse!” riferito alla possibilità di un nuovo incontro, affidato al caso o, e qui si apre la mia ipotesi di lettura, all’energia della poesia, sia in quanto testo sia in quanto attitudine erotica e spirituale che la Poesia, quella con la P maiuscola, sa luminosamente (e forse numinosamente) riconoscere nel quotidiano, cosa che Baudelaire, splendido flaneur parigino, conosceva bene. Metafora, in definitiva, trasferimento di significato d’un’istante verso le suggestioni eterne dell’amore o “schema della catastrofe” secondo la definizione che di questo sonetto offre Walter Benjamin.
E ora la coincidenza che, in quanto junghiano convinto definisco tale sorridendo. Ecco che a mia volta, minuscolo e risibile flaneur, attraversando le piazze di Bologna e pensando a cosa avrei potuto scrivere del testo di Baudelaire, mi imbatto in un mercatino vintage di suppellettili varie e di libri polverosi dove acquisto (per un euro!) “Scorciatoie – Poesie 1945-1997” dell’americano James Laughlin, tradotto da Massimo Bacigalupo e il cui testo d’apertura, la poesia “Song” (Canzone), del 1978 circa, è senza ombra di dubbio la prosecuzione? la risposta? l’ulteriore possibile sviluppo? del sonetto di Baudelaire. Anche qui si tratta d’un reciproco fuggevole sguardo fra il poeta e una passante, nella fattispecie una donna, di chiaro fascino, che va rincasando al mattino “appena venuta da tutta una notte fuori” (“fresh from a night of it” nell’originale), anche qui il gioco d’anime resta inconseguente, altro è già accaduto altrove, prima, nella notte trascorsa, è un po’ come se la poesia di Laughlin fosse il dopo del sonetto di Baudelaire, al poeta resta solo il manque amoroso, il necessario perché la Poesia, ancora una volta quella con la P maiuscola, abbia futuro.
A conforto di questa mia lettura riporto qui di seguito i versi finali di entrambi i testi, quello di Baudelaire:
Fu un lampo… poi la notte. Fuggitiva beltà,
nel cui sguardo, all’istante, l’anima mia risorse,
non ti vedrò più dunque che nell’eternità?
Altrove, e via di qui! Troppo tardi! mai, forse!
Poiché corriamo entrambi a ignoto e opposto sito,
o tu che avrei amato, o tu che l’hai capito!
E quello di Laughlin:
angolo aspettando il semaforo e i tuoi
occhi mi hanno fissato bella così
bella e tu hai capito che
avevo capito e hai capito che
ti desideravo anch’io così fresca
dopo tutta una notte fuori bellissima.
Allo stesso modo le due poesie si guardano e si riconoscono, a un secolo di distanza l’una dall’altra, secondo una logica che getta il quotidiano nel sempre e che fa del manque la più accesa presenza. Questione di Poesia.
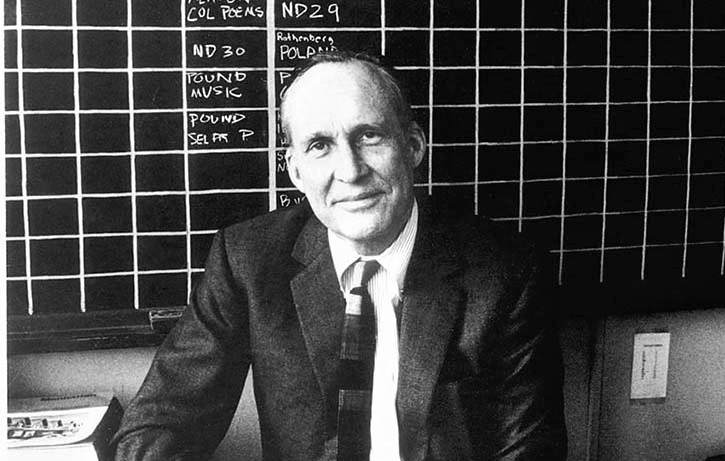
Song
di James Laughlin
O lovely lovely so lovely
just fresh from a night of
it lovely oh I saw you at
nine in the morning coming
home in the street with no
hat and your coat clutched
tight but not hiding your
evening dress lovely and
fresh from a night of it
lovely you stopped on the
curb for the light & your
eye caught mine lovely so
lovely and you knew that
I knew and you knew that
I wanted you too so fresh
from a night of it lovely.
(da “In another country”, 1978)
Canzone
Bella bella oh bellissima
appena venuta da tutta una notte
fuori proprio bella oh ti ho vista alle
nove di mattina che tornavi
a casa per strada senza
cappello e tenevi il cappotto
stretto ma non nascondeva il tuo
abito da sera bellissima e
appena venuta da tutta una notte fuori
bellissima ti sei fermata all’
angolo aspettando il semaforo e i tuoi
occhi mi hanno fissato bella così
bella e tu hai capito che
avevo capito e hai capito che
ti desideravo anch’io così fresca
dopo tutta una notte fuori bellissima.
(Traduzione di Massimo Bacigalupo, in James Laughlin, “Scorciatoie – Poesie 1945 – 1997”, Mondadori 2003)
Gli autori:

Giancarlo Sissa è nato a Mantova nel 1961. Vive nei pressi di Bologna. Ha pubblicato “Laureola” (1997 Book Editore), “Prima della tac e altre poesie” (Marcos y Marcos 1998), “Il mestiere dell’educatore” (Book Editore 2002), “Manuale d’insonnia” (Aragno, 2004), “Il bambino perfetto” (Manni, 2008), “Autoritratto (poesie 1990-2015)” (italic/pequod, 2015), “Persona minore” (qudulibri, 2015), “Archivio del Padre” (MC edizioni 2020), “Tamen” (Moretti&Vitali Editori, 2023).
Dal 2023 è redattore de “L’anello critico – Annuario della poesia italiana contemporanea” (Carta Canta Editore) e dal 2024 è Caporedattore della rivista online dell’Associazione Independent Poetry.
Presta opera di “narratore in scena” nell’ambito del progetto teatrale “Rosaspina, il tempo del sogno” di Alessandra Gabriela Baldoni.
Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue europee.

Charles Pierre Baudelaire (Parigi 1821 – Parigi 1867) è stato un poeta, scrittore, critico letterario, critico d’arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese.
È considerato uno dei più importanti poeti del XIX secolo, esponente chiave del simbolismo, affiliato del parnassianesimo e grande innovatore del genere lirico, nonché anticipatore del decadentismo. “I fiori del male”, la sua opera maggiore, è considerata uno dei classici della letteratura francese e mondiale.

James Laughlin (Pittsburgh 1914 – Norfolk 1997) è stato un poeta, saggista e editore statunitense, ricordato soprattutto per aver fondato la casa editrice New Directions.
Immagini —————–
Cani che inseguono gatti di Shrodinger
di Salvatore Bossone

Tempo presente —————–
Perché la lingua è madre
Anna Segre, “Onora la figlia”
di Roberto Lamantea

In “100 punti di ebraicità (secondo me)” (Elliot 2018) la nota biobibliografica su Anna Segre recita: “Anna Segre, cattolica per gli ebrei, ebrea per i cattolici, medico per gli psicoterapeuti, psicoterapeuta per i medici, non proprio connotata come omosessuale, ma abbastanza lesbica per gli eterosessuali, comunque in equilibrio instabile sulle etichette sociali”. E in “La distruzione dell’amore” (Interno Poesia 2022): “Medico, psicoterapeuta, anche ebrea, in più lesbica, perfino mancina”.
Non manca l’autoironia ad Anna Segre, ma non è un vezzo intellettuale: già “La distruzione dell’amore” è un libro lacerante anche per il lettore, almeno per il lettore superficiale avvezzo alla “bella forma” della poesia, per il suo essere un diario così sincero da fare male. Non finge mai, Anna Segre, la sua è una poesia che dilania e, proprio per questo, risplende.
Nel nuovo libro, pubblicato da Interno Poesia di Andrea Cati, “Onora la figlia”, quasi un undicesimo comandamento, Anna va oltre il diario, la confessione, guarda negli occhi la propria anima con una sincerità assoluta e la racconta sulla pagina in un’occasione dolorosissima, la morte della madre, uno di quei momenti della vita che costringe a riavvolgere il nastro di ciò che siamo stati fin da bambini, a interrogarci su che cosa è essere di fronte alla religione, alla morale, alla società, fino a respirare un vuoto inatteso, dove si mescola tutto: rabbia, tenerezza, rimpianto, vertigine, e un silenzio strano dentro di noi, come se anche il silenzio fosse vuoto.
Negli ultimi libri di Anna, “La distruzione dell’amore” e “A corpo vivo” (2023) le poesie sono scritte con il bisturi e la voce è quella di una ribelle per sincerità (o ribelle per amore, che è lo stesso). “Onora la figlia” comincia così: “Io non sono una proprietà,/ anche se nasco dall’atto di qualcuno/ e quel qualcuno penserà/ di avere dei diritti/ su di me./ Potrei non soddisfare le aspettative,/ anzi, lo dico subito:// deluderò le proiezioni,/ non corrisponderò all’idea/ e incenerirò gli investimenti,/ sarò un’idiota incurabile,/ sarò malgrado te,/ sarò quello che mi pare,/ disubbidirò,/ disturberò,/ busserò/ alle tue braccia conserte”: nel ‘68 e negli anni della contestazione questi versi sarebbero diventati un manifesto.
La poesia numero 27 – ogni testo è numerato da 0 a 68 – si chiude così: “Guardo la vita senza parteciparvi,/ come una senza invito/ sulla soglia di una festa”. Ci sono anche versi fulminanti: “Cosa è Amore.// Per me è stato/ non farlo vedere./ Amore è nascondere”; poche pagine dopo: “L’amore non si merita”, ma il libro si chiude così: “Togli morte/ dalla parola ‘morte’// rimane Amore”. Quella di “Onora la figlia” è poesia d’amore senza essere un canzoniere, un amore fatto di domande, un abito di spine cucito addosso che scopri essere la tua pelle.
La scrittura sembra lineare, sintattica, e nasce invece da un raffinato lavoro di sottrazione: “Le mie poesie”, ha detto l’autrice in un’intervista, “che appaiono lineari, nascono in realtà da un eccesso di parole, poi limato fino all’essenza. È un processo di sottrazione, una distillazione dell’emozione. Ogni parola è scelta con cura, incastrata con la successiva. Cambiarne una altera il senso. […] È una scrittura di precisione, come un ricamo o una partitura musicale”.
I libri di Anna Segre vanno letti, riletti, conquistati come ogni libro di poesie ma a condizione di arrendersi alla loro sincerità senza maschere, ricordano i testi di due grandi voci della poesia delle donne, Anne Sexton e Sylvia Plath. Nel libro “non è più solo la figlia che parla del mondo: è la figlia che parla della madre. Una madre che non è figura astratta, ma presenza concreta, quotidiana, irriducibile. Una madre devota e potente, invisibile e sovraesposta. Una madre che si dà e si nega nello stesso gesto, che si fa suora, serva, ebrea, borghese, comunista, povera e ricca. Inafferrabile. Forse irraggiungibile” scrive nella prefazione Manuela Fraire: “Questi versi non chiedono giustificazione, né indulgenza: aprono una soglia. Parlano da figlia, ma non per restare nel ruolo – per liberarlo, per rifarlo, per dare voce a ciò che non si era mai potuto dire”.
E Cecilia Lavatore nella postfazione: “Pagina dopo pagina, Segre ci accompagna tra le stanze di una casa in lutto e ci tiene per mano, siamo noi quella bambina. Siamo noi quella ferita. Scuciamo i punti di sutura, e tuttavia la perdita non si rimargina, continua a smarginare volontà e ribellione in una “primavera implacabile” scambiata per l’inverno, in una lenta caduta scambiata per un volo”. Fraire cita Rilke: “Ogni Angelo è tremendo”.

Dal libro:
1
Dice che prima di parlare
il bambino canta.
Che prima di camminare
danza.
Prima di scrivere
disegna.
Prima l’arte della mediazione.
L’arte subito
immediatamente.
Poi
sfarinati nella cognizione,
disfatti nella norma del linguaggio,
cerchiamo l’altro da noi
perdendo la scintilla divina.
*
12
Pigolavi, frinivi,
belavi, cinguettavi.
Eri gli animali piccoli
eri l’implume la preda
avevi quei piedi minuscoli
e quei denti da cavallo
gli occhi fiduciosi
come ignari del macello
eri la parte mite del creato
la vittima che beve a valle
del lupo.
Allora sono questo
le femmine, pensai:
la bellezza sbranata,
i vestiti a fiori
sottobraccio a
una falciatrice
con baffi e jeans,
un filo di profumo
nella tela dei fetori.
E dietro al ringhio
di quell’uomo
baluginavi
all’insaputa di lui.
Per rassicurarmi?
Per bloccare la rivolta?
Per abituarmi alla pratica
dell’essere sopraffatta?
Ho voluto credere che
quel luccichio fosse
l’inizio della spada
che avresti sfoderato
se la situazione
fosse peggiorata.
Quel luccichio è stato per me
il suono della cavalleria,
le trombe dei nostri,
l’arrivo della dea
che mai avrebbe permesso
un qualsiasi male
sulla tua creatura.
Ho creduto nel tuo avvento
senza curarmi dei dati di fatto
perché così è la fede, sì,
le tue piume
sarebbero sfuggite a
qualsiasi artiglio
e noi
saremmo volate via.
Grazia batte violenza
senza nemmeno la partita.
*
15
Credo nei documenti di viaggio
nella voce dell’altoparlante.
Credo nel dress code,
nei biglietti da visita,
nel frasario di circostanza.
Credo agli inchini,
ai salamelecchi
grazie prego scusi, prima lei!
Credo al vigile al capotreno al tassista fascista.
Credo ai ringraziamenti prima della conferenza,
ai concorsi, ai giochi in tivù.
Credo alla polizia alla pagella e ai premi.
I voti.
Si chiamano così
quelli che ti meriti,
quelli che ti eleggono
e quelli che prendi per essere suora.
E anche quelli che prometti
si chiamano voti.
Prima di credere in Dio
c’è come una scala di fede
ogni gradino una prova.
Prima di arrivare a Dio
devi abbassare la testa,
far finta di ubbidire.
Mentre dentro
quella che urla
viene tenuta ferma
da quella che assente.
Ma infatti.
Assente, sempre ingiustificata
perché, come dice Dio,
devi esserci
e io non ci sono.

20
Ho sognato un albero nero in mezzo alla neve.
Nero il tronco e le foglie luminose nella notte,
pieno di piccoli frutti, quasi semi, neri.
E una persona mi diceva,
trascinandomi là davanti:
d’ora in poi mangerò
solo i frutti di questo albero,
e sai perché?
Perché questo è
l’unico albero al mondo
senza radici.
E dunque questa faccia da albero,
con una storia,
una vita dimostrabile, un sotto e un dentro
è finta?
Sembri quello che non sei,
in questa notte bianca come la pece,
caduta, certo, vicino all’albero.
*
41
Se mia madre dovesse morire
sarei disorientata,
non perché lei fosse
il muschio sui tronchi
a indicarmi il nord.
Non era una bussola
non era una stella.
Se dovesse morire,
a chi somiglieranno
le donne che amo?
Morirebbe
la muta tenerezza
lo spasmo di vita
morirebbe
la vera bellezza.
Il credere il ridere
il cantare in salita
la conta dei salvi
non guardare l’abisso.
Chi ci sarà
tra me e il male?
Ho cercato dappertutto
e ho trovato molte madri
che mi hanno consolata
dalla tristezza
di non essere, loro,
lei.
Sanguinerebbero
quelle madri,
se mia madre
dovesse morire.
E il mio corpo
dubiterebbe di sé
in silenzio
perché la lingua è madre
e per un attimo
tutto in me
tacerebbe.

L’autrice:
Anna Segre, medico e psicoterapeuta, vive e lavora a Roma. Tra i suoi libri: “Il fumetto fa bene. Letture come terapia” (Comicout 2018), “100 punti di ebraicità (secondo me)” (Elliot 2018), “Cento punti di lesbicità” (Elliot 2018), “Fatiba Sed, biografia di una vita in più” con Fabiana Disegni (Elliot 2018), “Judenrampe” (Elliot 2019), “La distruzione dell’amore” (Interno Poesia 2022, premio Camaiore), “A corpo vivo” (Marietti 1820, 2023).
(Anna Segre “Onora la figlia”, prefazione di Manuela Fraire, postfazione di Cecilia Lavatore, pp. 128, 15 euro, Interno Poesia 2025)
Immagini —————–
L’ultimo gioco
di Salvatore Bossone

Voce d’autore —————–
Se anche in quei momenti
Alba Gnazi, “Sopravvivenza in acqua”
di Giovanni Fierro

Ha il sorriso gentile Alba Gnazi, di una gentilezza che immediatamente diventa appartenenza, trama personale che nutre la propria espressione, riflette l’eleganza del pensiero, corrisponde alla spontaneità dello scrivere. Perché poi tutto questo si riflette in “Sopravvivenza in acqua”, la raccolta poetica dedicata alla scomparsa di suo padre, ad una mancanza che riempie un vuoto, il vuoto.
“Chissà dov’è finita/ quell’attesa del pranzo,/ tutto quel tempo, sempre troppo,/ fino a cena”, ed allora il vivere senza è anche questa inevitabile necessità di ribilanciare la propria esistenza, il trovarne una nuova identità, pur nella continuità di uno stare al mondo che è legame indissolubile con il proprio genitore, ancor più tenace e necessario, luogo dove sempre più riconoscersi nel confronto, “Alcune mani fanno male da guardare,/ pesano forte sulla vita/ come gli occhi di certi padri/ quando i figli si voltano senza salutare/ e loro non li richiamano,/ non dicono niente”.
È delicato e allo stesso tempo determinato il fare poesia di Alba Gnazi, trova le parole e il loro peso specifico, le rispetta e a loro affida il proprio dolore, la propria passione, che si mostra e trova attenzione in modo diretto e pulito, con una scrittura che si può osservare in filigrana, che si può guardare in trasparenza, “e immagini la notte dolce sulla tua collina,/ il cane nel campo vicino, i fari stinti/ giù alla curva, un silenzio senza eco/ dalle case fino al fosso// a volte/ ti basta quest’idea/ per dormire più sereno/ con una mano sul petto/ e tutti i nomi, le facce, l’amore// posati sul cuore ingigantito e stanco/ che tutto, tutti// tiene dentro”.
È da questo atto di fiducia nella poesia che tutto “Sopravvivenza in acqua” diventa anche un esercizio dove la scrittura è vita in sé, respiro e battito, corpo che vibra e che pensa, fibra virtuosa, voce assoluta, “Era bello papà appena morto/ aveva un sorriso accennato/ era già parte del sogno,/ così lieve/ col suo corpo sottratto/ al peso”, “Si vedranno dopo i sogni,/ dai sogni chiamandosi/ prima del mattino”, “Guarda che hai fatto, guarda,/ ti sei portato via la parola”.
“Sopravvivenza in acqua” è questo scrivere esposto, un fermarsi prima che tutto si sciolga in un dolore che potrebbe solo trasformarsi in una lontananza, “Chi muore non aiuta chi rimane/ a trovarsi dentro una risposta,/ a un interrogativo detto meglio”.
Alba Gnazi con lo strumento della poesia è così capace di costruire un ritratto, anche in assenza, anche in ricordo: “Padre mio che ti espandi nel cuore/ che mi esplodi nel cranio/ e ovunque te/ spargi, mio verdissimo/ interminato amore// Padre mio del tempo futuro/ cancellata sia ogni tua morte/ la mia sola ombra sul muro/ quando ti siedi e cominci a parlare”.
Consolidare un legame, trasformarlo in una rinnovata verità. Alba Gnazi affida alle pagine di “Sopravvivenza in acqua” questo suo canto, sommesso ed intimo, di puro candore. “Bianco, bianco è il nome dei morti”.
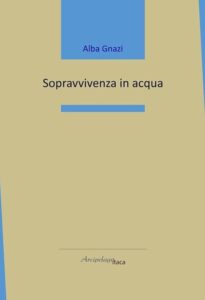
Dal libro:
DI TE SENZA
Ripenserò, già lo so
nel domani anteriore
di te senza, quando
dal terreno giù in fondo
fin sul tavolo sparpagliati
dalle mani annodate
dagli occhi di foresta
frutti foglie sterpi
piccoli insetti
a noi tutti rimessi
in offerta purché sia fatta
la volontà di un abbraccio
o una carezza di parole
all’aria intorno alla tua testa
di comete e interstizi di tempo
prima di andare via
contento.
*
SCALI IL FIATO
Scali il fiato: il fiato
ha tetti e tu
rovesci stupore
e costole tra le mani,
mantieni l’essere forte
con un assembramento
di intenzioni;
rosso in viso mentre
all’aria ti riassesti e disponi
paure e bestemmie al cielo
che di spalle vermiglio ti scuote
Cerchi negli occhi eventi
come segni e ti abbandoni
a un’intenerita pena
voltando il viso dove poco fa
lo avevo messo anch’io,
cercando comete
asfissiate nel muro,
la loro roca scia.
*
SE
dovranno guardare dentro al tuo corpo
per stabilire la causa del decesso
vorrei aprissero anche la testa,
guardassero nel cervello
per vedere che pensieri avevi
mentre stavi morendo,
se lo avevi capito,
se eri spaventato,
se ci volevi accanto
se anche in quei momenti
come il giorno precedente
hai chiamato tua madre
quando da padre
eri tornato a essere figlio.
*
MADRE
Mia madre prende a cazzotti il tuo cuscino
freddo e gonfio di assenza. La sua faccia
ha la stessa espressione fin dal mattino:
del condannato che aspetta una grazia
in cui spera senza credere, come il dio
che chiama e tenta, che non la ascolta.
*
PRIMAVERA
Primavera filtra bianco quasi sporca
e già sfatta di fiori dolciastri, profumi
negli occhi, il pruno il mandorlo il gelso,
il biancospino che ogni anno torna
a salvare. Mi brucia e commuove
l’urgenza di ogni prima volta,
la risalita da un antico buio,
lo scalpore non visto che esulta
di collina in collina. A suo modo
compirà la gioia indocile del padre,
il suo fertile, incessante divenire.

Intervista ad Alba Gnazi:
“Sopravvivenza all’acqua” è uno scrivere dedicato a suo padre Gerardo. Cosa significa affidarsi alla poesia per raccontare una perdita così importante?
Quello poetico è il codice più consono al mio sentire. Naturale, non programmato né, quantomeno per me, programmabile. Non avrebbe potuto che essere questo il sistema per cercare di affrontare un evento capitale come quello della perdita di mio padre.
E proprio lo scriverne, penso sia un fermarsi prima che tutto si sciolga in un dolore che possa solo trasformarsi in una mancanza. Anche questo mi sembra sia “Sopravvivenza in acqua”. È così?
Sì. È così. È il dolore ed è la mancanza che precede l’esplosione di quel dolore; è sapere – per vie oscure, nascoste – che si sta preparando la caduta, l’epilogo, lo spartiacque tra il Prima e il Dopo, la combustione, il vuoto. Mancanza è il salvagente cui il corpo, la mente, le viscere si aggrappano per adattarsi a quel vuoto, per convincersi dell’esistenza di quel vuoto – un vuoto che ci riguarda, ci scruta, è ineluttabile, e non si colma in alcun modo. È l’ultimo, l’estremo messaggio d’amore, quello a cui risponde l’abitudine inveterata di essere insieme in un tempo prossimo al presente, privo di futuro, che pure emana echi, onde concentriche di tenerezza e vicinanza.
Ma qual è l’acqua del titolo?
“Sopravvivenza in acqua” è la poesia che dà il titolo alla raccolta, scritta pochi anni prima della morte di mio padre, mentre vivevo in un’altra regione. Il distacco, la nostalgia, la mancanza hanno rappresentato il frangente da cui è scaturita una riflessione profonda, un ripensare schietto, senza scusanti né paraventi, a quel lungo corso di vita che dall’infanzia conduce alla maturità, all’alterità: che è Essere Altro e insieme Diventare Altro, scoprirsi altro, diventare Sé. Da qui, lentamente, l’accogliersi, il capirsi, il cercare di perdonarsi, di abbracciarsi.
Ciò implica, al contempo, l’accogliere, il capire, il perdonare, l’abbracciare chi è stato con noi in quel processo, chi quel processo lo ha condizionato in forme e modi spesso invisibili, non comprensibili né spiegabili a chi non ne è stato parte. È un oceano privato – ognuno è immerso nel proprio -, quell’acqua che nei sogni torna morbida e blu, o rovinosa e terribile, minacciosa come un silenzio punitivo, ingannevole nella sua illusione di sconfinato, di eterno.
Non si può che sopravvivere a/nonostante/grazie/in quell’acqua, che è dentro, tra le linee delle mani, nella postura, nel passo, e nutre e circonda, talvolta sommerge.

A volte, leggendo le varie poesie contenute nel libro, sembra che il tempo diventi troppo. Difficile quasi da affrontare, da vivere. È un tempo da cui nascondersi, o un tempo che ti mette a nudo, che ti svela? Che ti permette di raccontarti?
È tutto questo, sì. È questo, ed è quello che sagoma passaggi quando si procede verso un tempo parallelo. È la precarietà di ciò che si è, si fa, si costruisce e insieme la consapevolezza della durata, di quanto resiste e ci mantiene nello scorrere degli eventi: di quel che si lascia quando le luci si spengono e tutti vanno via.
In un passaggio del libro c’è scritto “guarda che hai fatto, guarda,/ ti sei portato via la parola”. Questa mancanza di parole è un’assenza o un silenzio, o un misto di entrambi? O cos’altro?
È il silenzio dell’orfanità. Non potere più sentirmi chiamare da mio padre, non potere più pronunciare “Papà” rivolta a lui, se non nel ricordo.
È anche non riuscire più a scrivere. Un ghiaccio paralizzante.
E di cosa sono fatte invece le parole che rimangono, che si consegnano alla poesia per trovare suono e significato, che vivono il quotidiano che è l’adesso? (questa domanda ha a che fare anche con la prima, in qualche modo…)
Ogni poesia porta agli occhi e alla coscienza occorrenze, accidenti, elementi di vario genere. Il disincanto, la paura, la ferocia, la sfrenatezza, la passione danno ragione della forma e del timbro linguistico con cui cerco di veicolare un significato, uno specifico sentire, un pensiero che avverto non altrimenti dicibile.
La poesia a volte avviene, me la trovo tra le dita, rotola via quasi mio malgrado; altre si presenta come un magma di espressioni sensazioni intendimenti furori incertezze e quant’altro. In questo caso scrivere è cercare di dipanare la matassa, darle un aspetto chiaro, spingere di lato le forze centrifughe per concentrarmi sul pensiero dominante, che ha la sua urgenza, il suo dettato, la sua partitura specifica. Quella e non altre. Allora le parole sono fatte di sottrazioni, di scelte fondamentali anche quando rischiose e dolorose; sono il meccanismo con cui accordo un senso e un ritmo che a volte solo intuisco e che mi si apre a testo compiuto.
Col tempo ho imparato che bisogna alleviare i carichi: sia del testo che di chi riceve quel testo. Il “trucco” magari c’è, ma non si deve vedere. Che resti la suggestione, che si instauri un dialogo di lunga durata: questa la mia speranza.
Diversi sono i capitoli del libro. Però la spina dorsale di questi è data dall’alternarsi delle stagioni (Estate, Autunno, Inverno, Ancora inverno, Primavera), come a dire che tutto il raccontare di “Sopravvivenza all’acqua” è inevitabilmente, e profondamente, radicato nel naturale procedere della natura. Può essere (anche) così?
Sono figlia di un artigiano che, quando smetteva di riparare e costruire pezzi interi di case, correva a fare il contadino. Le abitudini in casa erano scandite dalle stagioni, così come il lavoro nei campi, la raccolta dei prodotti, il cibo portato in tavola, il riposo della terra. Tutto procedeva secondo cadenze antiche, appena codificate dall’uso della tecnologia.
Vivo ancora qui, nei luoghi della mia famiglia, sebbene coi ritmi imposti dal mio lavoro a scuola e dalle esigenze di una figlia piccola.
Certe cose radicano, si fanno corrente carsica e cerniera tra mondi contigui.
E poi qui, poco oltre la vallata, quasi senza soluzione di continuità, si spiana il mare: di cui intuisco gli umori, che migrano da un versante a un altro a seconda del tracimare dei blu o dei rossi al tramonto.
Non poteva, non può che essere questo, il tempo da tenere con il piede, nella voce, sottopelle; mi respira da dentro, mi inscrive, e io ne scrivo, come è sempre stato.

L’autrice:
Alba Gnazi è nata e risiede in provincia di Roma. Insegna nella scuola pubblica.
Le sue raccolte edite sono: “Luccicanze” (Cicorivolta Editore 2015; con prefazione di Antonino Caponnetto), “Verdemare – Cronologia inversa di un andare” (La Vita Felice Edizioni 2018) e “In quel minimo che cade” (Il Convivio Editore 2021; con postfazione di Franca Alaimo).
(Alba Gnazi “Sopravvivenza in acqua” pp. 86, 15 euro, Arcipelago Itaca 2025)
Immagini —————–
Mirage in the rainbow
di Salvatore Bossone

Voce d’autore ——————–
In una sorta d’attrazione
Alda Guadalupi, “Meno Odio Tanto Amore”
di Anna Piccioni

Con l’espediente dell’acrostico, forma poetica in cui le prime parole dei singoli versi formano una parola di senso compiuto in questo caso ODIO o AMORE, Alda Guadalupi esprime la sua sensibilità poetica:
Aprire la
Mente all’infinito
Oltre la porta dell’anima.
Romantico
Esistere
Oltrepassare il reale
Di volare
Immaginava su una bianca nuvola
Ormai solo questo reca conforto
Scrive la poetessa nella prefazione di “Meno Odio Tanto Amore”: “Odio-Amore l’eterna dicotomia che secondo Empedocle sostiene il ciclo cosmico, uno opposto all’altro […] riconducibile alla natura umana”.
All’interno della silloge i componimenti poetici sono raccolti in capitoli: Esortazioni, Profumo di Poesia, Semplicemente Alda, Pensieri in Libertà, Varie, raggruppati sotto l’acrostico AMORE e ODIO.
I brevi componimenti poetici sono molto intensi: alcuni sono veri e propri aforismi, “Affrontare le/ Molestie del destino”, oppure esortazioni, “Odiare non si/ Dovrebbe”, “Avere la forza di reagire al /Male /Oscuro /Rendersi capaci di /Estirparlo dalla mente”; altri sono dei veri e propri consigli, “Amare la /Madre è un dovere”. E in un sommesso grido denuncia il Male del mondo: l’indifferenza, la violenza contro la natura.
Le parole di Alda Guadalupi sferzano le genti a reagire, ad accogliere l’amore e a strappare l’odio dai loro cuori, perché “Odio/ Degenera/ Infetta/ Ottenebra” e poi “Ad amare si può imparare/ Mettiamoci alla prova con/ Opportuno innovamento, con costante/ Esercizio”.
In altre parti sembra giocare con le parole, muovendole su uno schema che duella tra ODIO e AMORE. Nell’acrostico ODIO spesso la prima parola è Odiare, poi si stempera nei versi che danno regole di vita: “Odiare non si/ Dovrebbe/ Il rancore altro/ Odio porta”.
Alda Guadalupi denuncia con la sua poesia la perdita di atteggiamenti, parole, usanze che sono alla base della vita civile: ormai sono obsolete le buone maniere, e sapere ascoltare, intervenire in modo opportuno: la gentilezza e il rispetto fanno parte di un altro mondo, un mondo che non esiste più, a cui la Poesia può dare ancora speranza.
Oltre alla denuncia e al desiderio di ritornare alle buone maniere, in questa silloge la poetessa non si sottrae a parlare di sé, anzi si mette a nudo descrivendo i suoi sentimenti, le sue paure e la sua fragilità, raccontando anche qualcosa di molto più intimo, “Alda da adolescente/ Mirava in alto/ Oppure, sconsolata/ Rinunciava a/ Elegiache illusioni” e poi “Odio il/ Dovere/ Imposto, l’/ Obbligo coatto”.
Racconta di non saper mentire, di essere stata da giovane molto timida e introversa, di aver condotto una vita solitaria, e ancora oggi quella timidezza non è scomparsa, ma trova forza e sicurezza negli anni vissuti e nell’esperienza maturata.
Scrivere poesia, trasformare in versi il suo mondo interiore, cercando l’essenza della parola che dispiega il suo ricco pensiero volto verso tutte le tematiche, è per Alda Guadalupi frutto di una profonda riflessione e di una estesa sensibilità: in fondo grata al mondo per quello che ogni giorno le offre e per tutto l’Amore che riesce a donare.
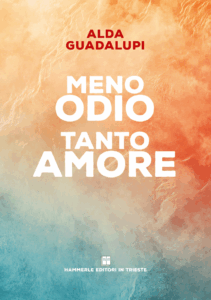
Dal libro:
AMORE
Avere il
Male
Oscuro della depressione può
Ridurre a
Essere larve di sé
Avere la forza di reagire al
Male
Oscuro
Rendersi capaci di
Estirparlo dalla mente
Andare con la
Mente alle cose belle
Ogni volta che si è tristi o delusi
Ripercorrere gioie trascorse
E immaginarne altre a venire
Amorevolezza
Misericordia
Opere di bene
Ristoro spirituale
Elargizioni
*
ODIO
Orecchio non sente, non
Duole
Il cuore.
Occhio non vede…
vi
Offro il veritiero
Detto
Il saggio
Ovvio proverbio
Odo soave suono
Da dentro una conchiglia
Immagini alla mente
Olezzi marini
Ortensie, lillà
Decorano
Il terrazzo con altri
Odorosi fiori

Intervista ad Alda Guadalupi:
Cosa significa per te la Poesia?
Se da piccola era qualcosa che razionalmente non mi spiegavo, ora posso ragionare sul moto dell’anima che non mi ha ancora abbandonato.
Ho scritto molto, non solo poesia, ma diari, pensieri, raccontini. A un certo punto ho creduto che potevo offrire al mondo le mie emozioni, condividerle, creare un dialogo muto con il lettore. Così ho condensato i miei scritti in raccolte poetiche.
La poesia per me è per prima cosa ispirazione, quella che solitamente mi sale nei momenti di solitudine. Basta una parola e il pensiero, senza ancora il filtro della mente, scava, alla ricerca del misterioso moto dell’anima. Il lampo del cuore. Le parole escono veloci prima che si dissolva quella luce. La poesia così pensata, è purezza.
Ma una volta formata, riletta, credo che non possa essere fine a se stessa. La poesia è comunicazione, interazione col prossimo. La poesia, come ogni manifestazione dell’arte, è energia che si espande e va offerta al mondo, perché l’artista appartiene al mondo.
La poesia, con l’efficacia dell’intuizione, può risvegliare principi di solidarietà e fratellanza.
Può accadere che un lettore, dopo aver attraversato le emozioni di un poeta, senta a sua volta il desiderio di immedesimazione e di incitamento a scendere nel sé profondo.
La poesia è un viaggio nell’anima di scrive e chi legge. Da una parte il poeta si porge, si palesa, dall’altra il lettore si sente libero nell’interpretazione e legittimato nel rilevare le possibili diversità.
Anche per questo la poesia ha valenza sociale, sia che esprima emozioni o concetti filosofici o semplicemente osservazioni sul mondo che ci circonda.
Considerato che scrivi poesia fin da giovane, quale il percorso del tuo essere autrice?
Son trascorsi decenni, da piccola scrivevo filastrocche in rima, ricordo la prima, a otto anni: “Nella notte scura, scura/ il grillo canta, senza paura … “.
Nella prima adolescenza poesie intimistiche, anche d’amore, in prevalenza in rima. Più tardi, nel desiderio di conoscenza ma anche supportata dagli studi magistrali, mi sono avvicinata alle poesie del Pascoli, ma di più apprezzavo l’ermetismo di Montale e di Ungaretti, quel loro modo particolare di dire l’essenziale e toccare le corde del mio cuore, “È la nebbia che vedo la sera/ e un grande timore mi prende …”, alcuni miei versi di diciassettenne.
Certamente, studiando e apprendendo i vari stili poetici, le molte tecniche, documentandomi, credo di aver affinato il mio modo di scrivere, di riuscire a dar forma, con maggior conoscenza linguistica e lessicale e capacità di sintesi, alle varie immagini che spontanee mi salgono alla mente.
Ho sì, maggior consapevolezza dei miei contenuti e mi piace molto, a distanza di tempo, commentarli come se non fossero miei e proprio per questo comprendere la mia stessa evoluzione. È così che riesco a entrare nelle intime pulsioni di altri poeti e scrittori e raccontare le mie impressioni sulle loro opere.
Com’è nata l’idea di pubblicare questa raccolta poetica con gli acrostici Odio e Amore?
Le due parole sono davvero molto inflazionate. Non ci si sofferma più sulla loro reale valenza.
Questo pensiero mi disturbava, dovevo in qualche modo renderle valide, puntualizzare il loro significato, senza la presunzione di discutere in chiave filosofica sulla loro dicotomia.
Così, dopo il primo, subitaneo acrostico con Amore, poi con Odio, ne sono seguiti altri e altri ancora. È stato quasi un gioco. A rileggerli, mi sono accorta di aver raccontato qualcosa di me, del mio modo di intendere l’esistenza, basata soprattutto sul diritto di essere se stessi. Mi sono accorta anche di non aver saputo rinunciare alla mia inclinazione poetica e ancora del fatto di essere stata una maestra – educatrice elementare e dunque ricca di consigli atti ad avviare all’importanza della relazionalità.
Dunque le due parole che apparentemente sono divergenti, sono uno stimolo per dare un volto alla nostra anima, per capire e motivare le nostre scelte. Siccome gli acrostici sono molto numerosi, ho pensato di riunirli e pubblicarli considerandoli una specie di vademecum.
Essendo poi in abbondanza quelli con Amore, ho pensato al titolo: “Meno Odio Tanto Amore”, titolo comunque aperto a personali interpretazioni.
Puoi spiegare perché Amore – Odio sono opposti e non contrari?
Odio – Amore sono sentimenti riposti nel nostro spazio interiore, in una sorta di attrazione – repulsione, con la prospettiva di svilupparsi nel bene o nel male o di restare in embrione per l’intera esistenza.
Noi siamo spettatori e protagonisti al tempo stesso della nostra storia, fatta di chiaroscuri, di contrapposizioni. Amore – Odio sono sentimenti che si compenetrano ma che possiamo plasmare e dar loro la forma che più ci conviene per la nostra serenità.
Nella fase dell’autoconoscenza ritroviamo in noi i due opposti sentimenti, che si alternano di fronte agli affanni quotidiani. E dico sentimenti, dunque sensazioni, impulsi del cuore, della nostra unicità, che non potremmo provare se quel che accade ci lasciasse indifferenti. Penso che la vera contrapposizione all’odio e all’amore siano la catarsi interiore, l’inerzia, la passività.
Cosa significa per te “opacità dell’anima”?
Definirei “opacità dell’anima” l’incertezza. Quando i due sentimenti si avvicendano in eterna dicotomia, rendono dubbiosa, instabile, la nostra coscienza e non riusciamo a percepire quello che davvero conta, quale sarebbe la giusta scelta. Penso che sia il muro dell’indifferenza quello che ottenebra, che fa guardare senza vedere.
Credo che il senso di precarietà che a volte ci pervade sia la cortina che solo con il coraggio e il desiderio di vita possiamo dissipare. E il desiderio di vita è Amore.

L’autrice:
Alda Guadalupi è nata a Trieste. Ha al suo attivo cinque raccolte poetiche, “Il fiore nudo” Il coriandolo 2004, “Una canzone sola” Bastogi 2006, “Parole di pioggia” Hannerle Editori 2008, “L’attento volo dell’aquila” Italo Svevo 2012 e “Amato ritorno” Hammerle Editori 2019.
(Alda Guadalupi “Meno Odio Tanto Amore” pp. 112, 14 euro, Hammerle Editori)
Immagini —————–
Incontri sul sole
di Salvatore Bossone
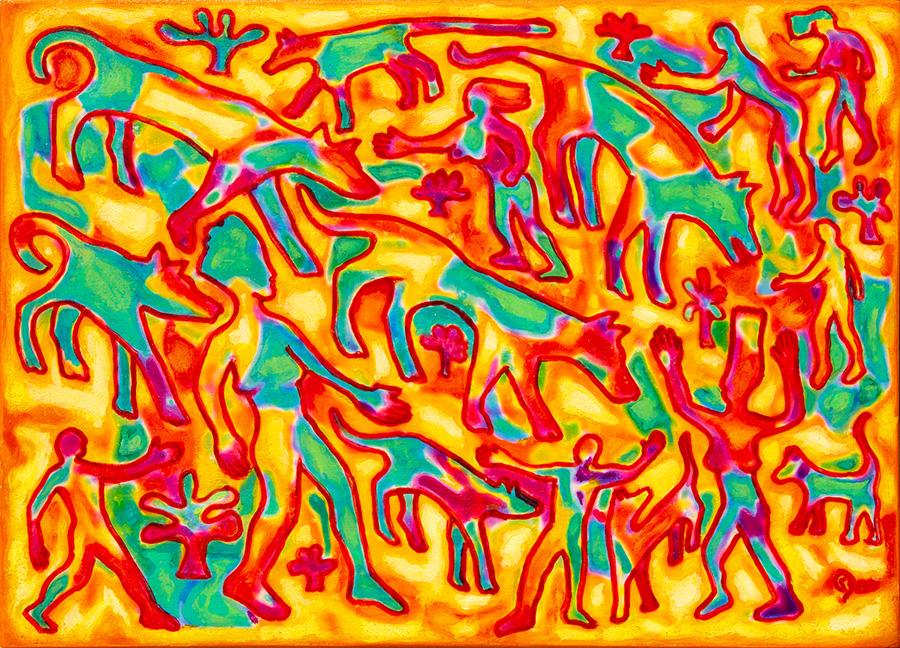
Tempo presente ———
Ho imparato l’imperfezione del quadrifoglio
Giovanni Andreoli, “Absorbeat”
di Giovanni Fierro
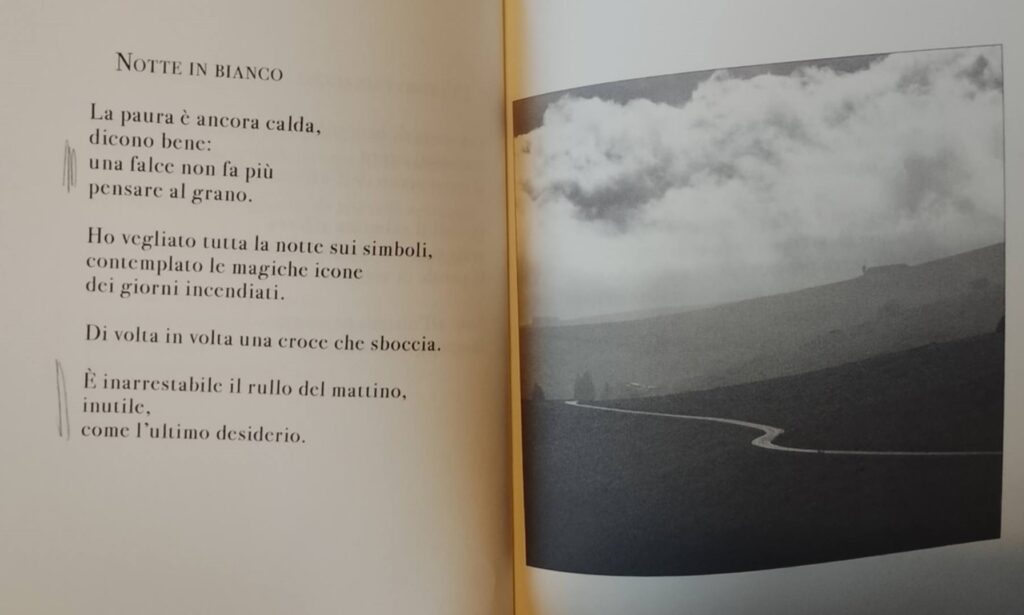
Scrive il giusto Dante Zamperini quando, nella prefazione ad “Absorbeat” di Giovanni Andreoli, dice “Appena ci si immerge in queste pagine, si avverte un intenso patrimonio affettivo”.
Perché la poesia di Andreoli è questo riconoscere la particolarità del vivere e la verità del suo mistero, tra la necessità dell’invenzione (“Nasceranno dei bambini.// A loro basteranno due coccinelle/ per fare il mondo a puntini”) e il nutrimento della percezione (“È inarrestabile il rullo del mattino,/ inutile,/ come l’ultimo desiderio”).
Il quotidiano in queste pagine è luogo di svelamento, di vicinanza a se stessi, dove la propria esistenza è coniugata al presente, con l’infinito attorno e dentro, in quell’intreccio che solo con l’intensità del ricordo può essere radice e provenienza, “Grava l’ombra di Sisifo/ proprio dove deragliano/ i miei vecchi trenini Lima”.
Tutto “Absorbeat” è questo assorbire l’atmosfera in cui ognuno è immerso, nella propria unicità, il suo farsi corpo, in quel quando dove “Finalmente si sanguina in pace” e “Il sangue soprattutto/ non ha più la spuma/ della prima vendemmia”. Ma è sangue che non porta con sé dolore, anzi, è testimonianza di corpo che vive, si riconosce e chiede di essere persona, perché “Le ombre/ non resistono a lungo/ con il battito al polso”.
La scrittura di Giovanni Andreoli è anche lo scegliere quale sguardo usare, per costruire una prospettiva, utile a riconoscere le immagini di cui si può avere bisogno, quelle che devono durare.
Perché poi in queste pagine tutto è anche paesaggio, che si fa spirituale, che rinuncia ad ogni protezione per essere più vero, respiro di cui si sente il bisogno: “La piccola grondaia/ sgocciola ancora/ all’altezza del cuore.// Succede sempre/ quando vedo le lucciole sfinite/ dal buio della valle”.
Sono poesie su cui ritornare queste, a cui affidare un volere bene che è sempre più necessario, dove si può trovare il coraggio, “Io che progetto Dio, la salute”, e il giusto momento per fare del silenzio un qualcosa di perfetto, “Una pioggia sottile sottile/ nella luce dei fari”.

Dal libro:
Rosso superiore
È sufficiente che
le due metà del cuore
pulsino intatte
che al bar evaporino
dagli impermeabili tristi
le vicissitudini domestiche.
Non si smette mai di cadere,
è meglio godere
nell’occhio del ciclone
con un rosso superiore.
Si sa che i turisti sono curiosi,
amano solo gli spettri.
Una foto ricordo.
*
Esperienza
Ho imparato
l’imperfezione del quadrifoglio,
che il cielo acconsente o dimentica,
un debole continuo dolore
che non mi rende giustizia.
Intanto arrotolo tramonti,
racconto mille bugie capovolte.
Il sangue soprattutto
non ha più la spuma
della prima vendemmia.
*
Al balcone
I miei battiti calmi da collina
tre sigarette e un po’ di vino.
La piccola grondaia
sgocciola ancora
all’altezza del cuore.
Succede sempre
quando vedo le lucciole sfinite
dal buio della valle.
*
La capriola
Che pratiche leggere l’esistenza.
Il futuro
è una data scolpita.
Sconosciuta.
Quanti cuori calpestiamo
per sopravvivere felici.
Io che progetto Dio, la salute.
Io che non vedo mai
la tua tenera capriola
nel mio piccolo orto.
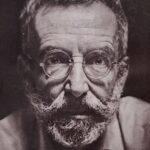
L’autore:
Giovanni Andreoli è nato a Bussolengo (VR) nel 1962 e vive a Sant’Ambrogio di Volpicella. Operatore per disabili, ama fare lunghe passeggiate in natura.
Presente nell’antologia “Olimpia” di Montegrotto Terme. Pubblicazioni: “Il giardino della terra” insieme a Remo Xumerle (2003).
(Giovanni Andreoli “Absorbeat” pp. 71, 10 euro, Fara editore 2024)
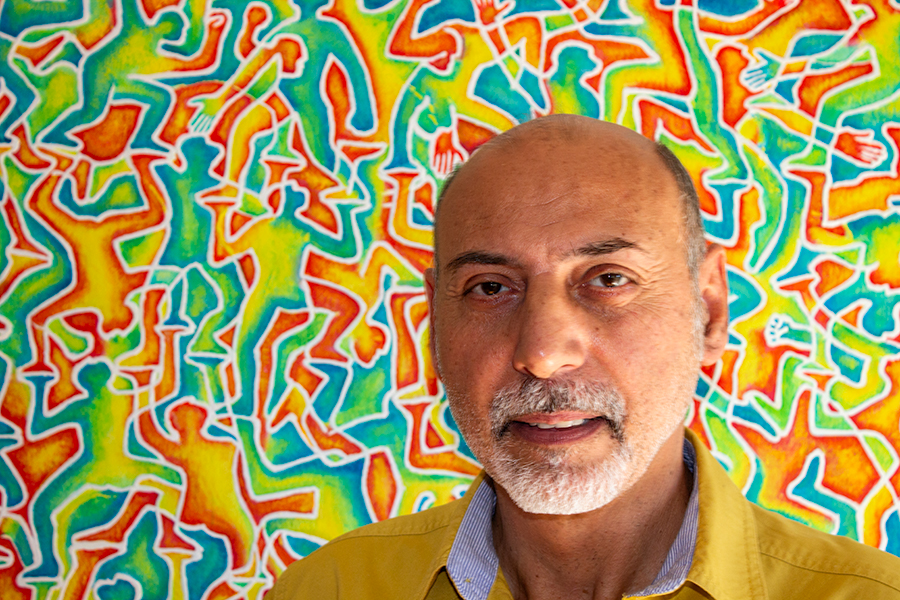
Intervista a Salvatore Bossone:
di Luigi Auriemma
Caro Salvatore, ci parli del tuo processo creativo? Da dove prendono origini le immagini delle tue opere?
Caro Luigi, nel tempo ho provato a spiegare a me stesso e ad altri il perché fossi attratto da forme e colori oltre che dai suoni e perché tenda a crearne di nuovi. La risposta è certamente nelle trame dell’inconscio che crea il nostro destino e che l’uomo, l’artista non può fare altro che assecondare pena la propria infelicità. Ho provato a “farmene una ragione”, a darmi delle “spiegazioni”. Negli anni ho prodotto vari scritti che possono essere un po’ sintetizzati in questi due piccoli brani:
Le immagini
sbucano dal caos dei sogni,
dell’inconscio.
Forse da vite passate…,
forse da vite future.
Ricordi lontani, pianeti in costruzione.
Le separo, le collego, le fondo,
le scambio con altri sognatori.
La casa, il vulcano, il mare, la stella…
Provo a dargli un senso, cerco di organizzarle,
di interpretarle, fantastico, indago in mondi paralleli,
odo domande, aspetto risposte, progetto utopie…
Le mie immagini non hanno, in genere, significati espliciti o impliciti. I pennelli ed i colori proiettano sulla tela forme immaginate e quello che l’azione stessa del dipingere e la vista o meglio visione forma nella mente. Figure umane, animali, piante, case, generate inizialmente da composizioni astratte, si coagulano quasi autonomamente nel tentativo, forse, di afferrare il senso primario del visibile e dello spirito che lo anima. Quando l’energia creativa dell’immaginazione diventa materia può sublimare ancora in energia per osservatore ed artista stesso. Quando questo accade il ciclo si chiude, l’opera è riuscita.
Le tue opere sono cariche di significati onirici, surreali e sub-reali: come si relaziona questa tua visione del mondo con il mondo reale?
Da ragazzo mi definivo ateo e materialista, poi a vent’anni circa ho cominciato a prendere coscienza che c’è, esiste, una realtà sottile, invisibile, di cui ho preso sempre più consapevolezza.
Da un primo interesse per pratiche magiche ed esoteriche ho conosciuto una corrente buddista che ho praticato per circa venticinque anni. Ho continuato con la meditazione ma un grosso contributo me l’ha dato la scoperta della fisica quantistica che fra tantissime cose ci spiega che l’universo, le cose e noi stessi siamo fatti di energia intelligente, un software quantistico dove universi paralleli, altre dimensioni sono realtà invisibili alla vista ed agli altri sensi ma presenti al di là dello spazio e del tempo.
Il sogno quindi, l’inconscio personale e collettivo, dove il tutto è uno, prendono parte alla creazione della cosiddetta realtà con il loro contributo alle intuizioni.
Nelle tue creazioni utilizzi molto la metafora, il paradosso e il nonsenso. Da dove nasce questa scelta rappresentativa?
Non è appunto il sogno, tornando alla domanda precedente, surreale, sub-reale ma che può apparire metaforico in senso rivelatorio di un significato? Esso ci appare spesso come portatore di messaggi provenienti da altri mondi, paralleli, forse superiori a volte inferiori attraverso visioni paradossali apparentemente senza senso.
Molto importanti nelle tue opere sono i titoli, che hanno una rilevanza molto significativa, pari se non addirittura più delle immagini, per comprendere ciò che è rappresentato: come avviene l’abbinamento?
Nella maggioranza dei casi le parole che andranno a comporre il titolo cominciano a manifestarsi nella fase finale o dopo il completamento dell’opera. A volte tentano di chiarirne il senso anche se spesso ironizzano e sdrammatizzano.
Prendo ad esempio “Mirage in the Rainbow” o anche “Antico gioco”. In queste immagini ho provato a rappresentare l’auspicio che le persone riconoscano il loro destino comune; “corredandole” di titoli suggerisco una possibile chiave di interpretazione.
È vero anche che non “obbligo” e non posso obbligare l’osservatore ad una certa interpretazione. Anzi capita spesso che le persone aggiungano altri significati, interpretazioni a cui non avevo pensato.
Altro esempio, “Cani che inseguono gatti di Schrodinger”; senza titolo potrebbe essere visto come un semplice gioco astratto di colori; forse neanche le sagome degli animali sarebbero state riconosciute.
In fondo anche i titoli sono spesso frutto di un processo intuitivo in gran parte non razionale.
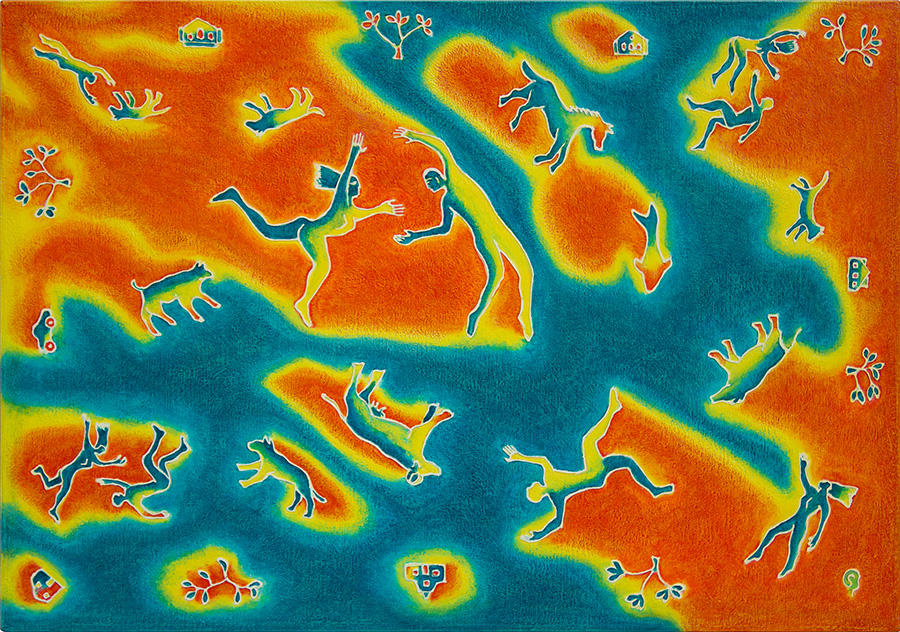
Nei tuoi quadri non c’è mai una impostazione prospettica (tranne qualche raro caso) ma più una sovrapposizione di piani bidimensionali dove figure piccole affianco a figure grandi affollano e si rincorrono in un apparente caos, che riempie tutto lo spazio della tela. Questo tuo modo di rappresentazione può essere una forma di critica alla superficialità di contenuti della società contemporanea?
Un’artista formalmente lontano dalla mia pratica e che ha usato la tela in modo completamente diverso dal mio ma che ha influenzato il mio rapporto con essa è stato Lucio Fontana, le sue tele cercavano la terza o quarta dimensione attraverso i tagli; io al contrario mi trattengo e intrattengo nella bidimensionalità, le mie figure sono in qualche modo pittogrammi. La prospettiva se c’è è solo simbolica, irrispettosa delle regole euclidee.
Il caos che solitamente popola i miei lavori meno recenti si riferisce in qualche modo, alla freneticità, spesso inutile e fuorviante, cui siamo costretti da una società che consuma le cose, i cibi, il mondo, la natura, il tempo, perdendo il senso della realtà profonda. Chi si ferma è perduto, incapace anche di trovare sé stesso.
In realtà poi, queste “coreografie”, per usare un termine forse non del tutto improprio, continuo in buona parte ad utilizzarle ancora oggi per “animare” le composizioni e creare un effetto di movimento che mi piace e diverte.
La prospettiva, anche solo accennata e simbolica si è man mano dissolta nella rappresentazione di uno spazio spirituale più che reale che prospetta spazi altri, altre dimensioni che richiamano, ispirano, la realtà fenomenica.
Tu sei un ambientalista praticante (non solo a chiacchiere), di questa tua pratica in che misura la tua ricerca artistica ne è influenzata?
Come dicevo, e sappiamo, la nostra società, il sistema economico è basato sul consumo, devia i nostri reali bisogni, ci fa credere che se non seguiamo la moda, non compriamo il nuovo modello di automobile o non mangiamo i cibi spazzatura che riempiono i supermercati siamo obsoleti, vecchi, alieni. Per questo penso ci sia il bisogno di un’arte che ci faccia pensare, meditare ma non per comprare birra come diceva una pubblicità.
Tutti questi pensieri, riflessioni, in un modo e in un altro finiscono sulle tele dove appunto mi rifletto e dove, spero, possano farlo anche altri.
Hai mai pensato di realizzare dei video o cortometraggi con i tuoi personaggi?
Come prima accennavo, sono attratto dai suoni oltre che dalle immagini. Da sempre ho provato a cantare e da ragazzo ho cominciato a suonare la chitarra ed altri strumenti. Fra questi, ad un certo punto, è arrivato Il Commodore 64, poi l’Amiga. Da lì ho cominciato a sperimentare le potenzialità dei computer sia in campo musicale che grafico.
Prima dell’Accademia di Belle Arti ho studiato elettronica che avevo però messo da parte. Questo background mi ha però conferito una certa dimestichezza con questi apparecchi, una certa capacità di comprenderne il funzionamento, collegarli fra loro, possibilmente ripararli quando si rompono. Da subito ho provato a creare grafiche e musiche, combinarle e realizzare piccole animazioni. Quest’arte però ha bisogno di capacità e conoscenze di software e hardware che si evolvono velocemente. Anche di moltissimo tempo.
Negli anni ho realizzato vari esperimenti, alcuni di essi sono presenti sul mio canale You Tube e sulle mie pagine Facebook ed Instagram. Link al sito: bossone.it
Il tentativo è da tempo quello di realizzare video a partire dai miei quadri combinandoli con riff di chitarre e semplici basi musicali tutti autoprodotti e/o con l’aiuto e “consulenza” della mia compagna Maria Francesca che ha studiato musica.
Spero di avere ancora vista, udito e tempo per realizzare altri quadri che ispirino altra musica e nuovi video.

L’artista:
Salvatore Bossone è nato a Napoli nel 1961, lì vive e lavora. Dopo studi tecnici, dove contemporaneamente coltiva le passioni per il design e la musica, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Napoli al corso di pittura del maestro Domenico Spinosa e prof. Crescenzo Del Vecchio. Dopo l’Accademia, con le prime mostre collettive e personali, comincia la collaborazione con alcuni studi grafici. Dal 2003 al 2009 è titolare dell’omonimo studio offrendo prevalentemente servizi ad altri artisti visivi e musicisti. Negli anni successivi si dedica esclusivamente alla pratica della pittura, grafica e video d’arte.
Da citare, fra le ultime, le mostre collettive: Itinere International contemporary ART, 2024 Maschio Angioino Napoli, Infinity Dada, 2024 Casina pompeiana Napoli, Il cammino dell’arte, 2024 Museo irpino Avellino e le mostre personali Enigmagma alla Apoteca Artport, 2012 Pozzuoli, Visibile invisibile al Complesso monumentale al Pendino, 2018 Napoli, Dimensioni parallele al Clubino, 2025 Napoli. Vari video d’arte sono presenti sul suo canale Youtube, pagine Facebook ed Instagram. Link al sito www.bossone.it
Sue opere sono presenti in varie collezioni private e pubbliche come la Pinacoteca Di Arte Contemporanea Massimo Stanzione a Sant’Arpino e il Museo di arte contemporanea di Sant’Angelo dei Lombardi.
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Anna Piccioni, Antonio Nazzaro, Antonello Bifulco, Luigi Auriemma, Laura Mautone, Ilaria Battista, Livio Caruso.